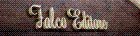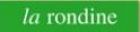Società di prodotti editoriali, comunicazione e giornalismo.
Iscrizione al Roc n. 21969.
Registrazione presso il Tribunale di Cosenza
n. 817 del 22/11/2007.
Issn 2035-7370.
Direttore editoriale: Mario Saccomanno
A. XVIII, n. 200, maggio 2024
 L’amor mundi
L’amor mundie l’impegno
di una filosofa
di Francesca Rinaldi
Per Donzelli: vita
di Hannah Arendt
«Era una donna bella, affascinante, attraente, femminile. […] Ciò che colpiva in lei erano gli occhi, luminosi e splendenti, sognanti, quando era felice o eccitata, ma allo stesso tempo profondi, scuri e assenti, piccoli laghi di interiorità. C’era qualcosa di impenetrabile in Hannah, che sembrava stare nel profondo di questi occhi». L’8 di dicembre del 1975 a New York, nella Riverside Memorial Chapel ha luogo il funerale di Hannah Arendt e con queste parole la sua amica Mary McCarthy prende il definitivo commiato da lei. Viene recitata la liturgia funebre ebraica, il kaddish, come già nel 1970 Hannah aveva voluto per il suo compagno della vita Heinrich Bluecher. Si conclude così la “vita activa” della filosofa tedesca sempre libera e mai uniformata e che spesso si era sentita la “fanciulla straniera” della lirica di Schiller. A raccontarne la biografia è il giornalista e scrittore tedesco Alois Prinz in Io, Hannah Arendt. Professione: filosofa (Donzelli editore, pp. 218, € 16,50).
Nata nel 1906 da una famiglia borghese e benestante, Johanna all’anagrafe, ma Hannah per tutti, trascorse la sua infanzia e prima giovinezza a Koenisberg, nella Prussia orientale, dove la sua famiglia, ebrea di origine russa, era molto importante ed autorevole. Dopo un breve soggiorno a Berlino durante la Grande guerra, prima della battaglia di Tannenberg, e un altro prima della maturità, Hannah decise di continuare i suoi studi a Marburgo, dove insegnava un giovane docente, che ancora non aveva scritto niente di significativo ma che era capace di illuminare qualsiasi argomento, il suo nome era Martin Heidegger.
Giovinezza tedesca, maturità francese
“Il mago di Messkirch”, come era chiamato Heidegger dagli studenti, era un “ribelle della filosofia” per il suo tempo, con un metodo di insegnamento diverso e coinvolgente. Era brillante e capace di “ipnotizzare” una platea attenta di giovani durante le sue affollate lezioni. Passò davvero poco prima che anche il “mago” rimanesse affascinato dalla giovane Hannah, bella, vivace, intelligente ed eccentrica. Tra i due iniziò una relazione che per entrambi era molto di più di una semplice avventura, Hannah era per Heidegger «la passione della sua vita», nonostante il suo matrimonio, che la stessa Arendt molto più tardi definì «un’alleanza di élite e plebe, questa volta suggellata nella maniera più stretta». Nel famoso Le origini del totalitarismo, dato alle stampe da Arendt nel 1951, “l’alleanza tra élite e plebe” era un fenomeno storico con il quale cercava di dare una spiegazione al perché il Nazismo in Germania (e non solo) avesse esercitato una potente forza d’attrazione verso uomini molto significativi (tra i quali, ahimè, Heidegger, sebbene lei non lo abbia citato).
Ma la giovane Arendt, già nel 1925, cosciente dello stato di subalternità nel quale una relazione con un uomo – dalla personalità forte e “oscura” – come Heidegger la avrebbe mantenuta, si trasferisce nell’università di Heidelberg, dove si laureerà con Karl Jaspers che rimarrà per tutta la vita il suo vero maestro.
Quando nel 1933 la Arendt lasciò illegalmente la Germania alla volta della Francia, il sentimento che predominava in lei era il disgusto verso la società di intellettuali che salutavano Hitler come un salvatore e la sua salita al potere come una «rivoluzione metafisica». A Parigi, vivrà nella comunità degli esuli intellettuali tedeschi con personalità del calibro di Walter Benjamin, Erich Cohn-Bendit, Karl Heidenreich e troverà lavoro a Parigi presso varie organizzazioni ebraiche che formavano i giovani ebrei per prepararsi a un futuro lavoro in Palestina. Lei stessa ricorderà, anni dopo, un suo viaggio in Palestina del 1935, per accompagnare alcuni giovani ebrei in un kibbutz, con queste parole: «Pensai: una nuova aristocrazia. Sapevo già allora […] che là non sarebbe stato possibile vivere. “Regna sul tuo vicino”, alla fine sarebbe andata a finire così». Con l’entrata in guerra della Francia i profughi ebrei tedeschi diventarono “stranieri indesiderati” e si cominciò a internarli in campi. Sorte che toccò nel 1940 anche alla filosofa, che riuscì comunque rocambolescamente a fuggirne e dopo aver superato i Pirenei e raggiunta, coi visti necessari, Lisbona si imbarcò per gli Stati Uniti.
Il male radicale e la banalità del male
Negli Stati Uniti, la Arendt divenne una «sorta di libera scrittrice» con una vasta cerchia di amici intellettuali. Nel 1945 riallacciò i rapporti che con la guerra si erano interrotti, primo fra tutti quello con Jaspers, al quale il Nazismo aveva impedito di insegnare. Fu proprio il filosofo-psichiatra a pubblicare sulla rivista Die Wandlung un saggio che Hannah aveva scritto nel 1944 sulla questione della colpa e nel quale argomentava l’impossibilità dell’esistenza di una colpa collettiva. Per la filosofa infatti, la colpa riguarda soltanto una persona individuale. L’uomo del quale i nazisti si erano serviti non era un sadico, un fanatico o un maniaco sessuale ma il comune padre di famiglia, era colui che «era disposto a sacrificare i sentimenti, l’onore e la dignità umana per amore della pensione, dell’assicurazione sulla vita, dell’esistenza sicura di sua moglie e dei suoi figli». Poco dopo ne Le origini del totalitarismo quando parlerà di «male radicale» lo definirà «impunibile e imperdonabile» proprio perché il carattere precipuo dell’ingranaggio di morte nazista, secondo la pensatrice, è lo sterminio di massa in nome di un compito storico, una «pulizia» su scala industriale: nel loro sforzo di tradurla in pratica, i regimi totalitari hanno scoperto, senza saperlo, che ci sono crimini che gli uomini non possono né punire né perdonare».
È proprio partendo dalla questione della responsabilità e della colpa che la Arendt affrontò un caso che le mise contro gran parte della comunità ebraica e degli intellettuali del tempo.
Il caso che la vide partecipe sia come studiosa della questione che come ebrea fu il processo Eichmann. Adolf Eichmann, nazista latitante che aveva avuto un ruolo preminente nello sterminio degli ebrei, viveva nascosto sotto falso nome in Argentina, era stato rintracciato nel 1960, prelevato dal Mossad e condotto a Gerusalemme. L’11 aprile 1961 si aprì il processo, Hannah vi assisteva in qualità di inviata per la rivista statunitense New Yorker. Nell’aula l’imputato stava in una gabbia di vetro sotto i giudici e di profilo al pubblico. Eichmann non era una figura marginale del regime nazista, tutt’altro, ma ad ascoltare la sua deposizione di fronte alla pubblica accusa che esponeva i dati impressionanti del genocidio nazista, veniva fuori l’assoluta normalità di una personalità mediocre che ricordava in continuazione di aver soltanto ottemperato al suo dovere. Nel dicembre del 1961 a Gerusalemme fu letto il verdetto del processo Eichmann: colpevole e condannato a morte. Il 31 marzo dell’anno successivo fu eseguita la condanna. Dal 16 febbraio al 16 marzo del 1963 uscirono sul New Yorker i cinque articoli della Arendt sul processo Eichmann, con il titolo Eichmann a Gerusalemme: un resoconto sulla banalità del male, più tardi raccolti in un libro. Già dalla pubblicazione dei primi articoli Hannah ricevette la “dichiarazione di guerra” da parte del consiglio ebraico tedesco, mentre, subito dopo, le sue conferenze furono boicottate e alcune fortemente contestate. La causa principale di tale atteggiamento furono soprattutto due punti: il ruolo dei consigli ebraici durante il Terzo Reich e il concetto di «banalità del male».
Nel suo resoconto del processo Eichmann, la Arendt aveva messo in luce «il capitolo più torbido di tutta quella fosca vicenda», vale a dire la collaborazione dei consigli ebraici nel compilare le liste degli ebrei da deportare e dei loro beni da confiscare. Per i detrattori della Arendt, questo era un falso argomento, perché la collaborazione coi nazisti era motivata dall’intenzione di salvare il salvabile, in una situazione senza speranza. Ma per Arendt, collaborare con i propri nemici «per evitare il peggio» era soltanto una strategia per zittire la propria coscienza e non ammettere di essere partecipi del modo di pensare del nemico. Per chiarire meglio, aveva analizzato la situazione in molti paesi europei e aveva dimostrato come per esempio in Danimarca, Svezia e Italia i nazisti si fossero trovati di fronte persone e istituzioni per nulla pronte a obbedire e a stilare liste, al contrario della Germania e di altri paesi come la Romania. I regimi totalitari, secondo la pensatrice, sono criminali e sterminatori nella misura in cui non incontrano un’opposizione decisa e solidale, quando ciò avviene si sciolgono «come burro al sole» perché sono assolutamente privi di sostanza, totalmente superficiali. Per questa ragione, per lei, non si poteva più parlare di «male radicale» (come nel suo libro del ’51) ma di «banalità del male». Per Hannah, Eichmann era un «pagliaccio», ubbidiente e deresponsabilizzato e impersonava il male banale, non demoniaco: «Quel che ora penso veramente è che il male non è mai “radicale”, ma soltanto estremo, e che non possiede né profondità né dimensione demoniaca. Esso può invadere e devastare il mondo intero, perché si espande sulla sua superficie come un fungo […]. Solo il bene è profondo e può essere radicale». Ma i suoi detrattori vedevano in questa categoria della «banalità del male» un modo per minimizzare i più terribili crimini nazisti e sdrammatizzare il dolore delle vittime.
La forza di Hannah Arendt è sempre stata anche nel coraggio di essere contro il pensiero dominante e nel saper difendere con precisione le sue tesi.
Per tutta la sua vita, infatti, si occupò senza mai tirarsi indietro del mondo. Il suo amor mundi (Liebe zur Welt), “amore nei confronti del mondo”, non era però diffuso e inflazionato ma, come spesso diceva Jaspers «chi ama tutti non ama nessuno», anche lei amava gli amici, le persone, non i popoli. Intervenne per parlare dei fatti d’Ungheria, degli avvenimenti di Little Rock, dell’elezione di Kennedy, del movimento del Sessantotto, perché per lei, l’agire e il parlare sono le facoltà più importanti per l’uomo. Solo con l’agire e il parlare si può creare un mondo, mentre nel privato risiede tutto ciò che non crea nessun mondo.
Francesca Rinaldi
(www.bottegascriptamanent.it, anno IV, n. 34, giugno 2010)
Elisa Guglielmi, Ilenia Marrapodi