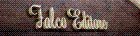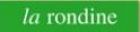Società di prodotti editoriali, comunicazione e giornalismo.
Iscrizione al Roc n. 21969.
Registrazione presso il Tribunale di Cosenza
n. 817 del 22/11/2007.
Issn 2035-7370.
Direttore editoriale: Mario Saccomanno
A. XVIII, n. 200, maggio 2024
 La guerra in Bosnia
La guerra in Bosniaattraverso i ricordi
di un famoso ufficiale
dell’armata bosniaca
di Alessia Cotroneo
Le stragi e le incognite del dopoguerra
in un libro-intervista di Infinito edizioni
Un canto d’amore appassionato per la sua città e un urlo straziante contro le atrocità della guerra e i pericoli che il dopoguerra nasconde: tutto questo in Sarajevo mon amour (Infinito edizioni, pp. 272, € 18,00), interessante libro-intervista di Jovan Divjak, tradotto in italiano da Gianluca Paciucci. Jovan Divjak, numero due dello Stato maggiore bosniaco durante la guerra in Bosnia-Erzegovina, ripercorre mezzo secolo di storia dell’ex Jugoslavia e racconta il durissimo assedio di Sarajevo (5 aprile 1992-29 febbraio 1996), passato alla storia come il più lungo dell’età contemporanea. Il libro prende spunto dal diario che il generale ha tenuto saltuariamente durante la guerra e dalle interviste rilasciate a Parigi e a Sarajevo a Florence
Sarajevo,
Un serbo che rinnega la nazionalità per difendere la cittadinanza
Il caso di Divjak ha da sempre incuriosito i giornalisti di tutto il mondo per la sua singolarità: fin dalle prime fasi della guerra, condotta dai separatisti serbo-bosniaci appoggiati da Slobodan Milošević, un colonnello di nazionalità serba dell’Armata popolare jugoslava (Jna) sceglie di combattere nelle fila dell’esercito bosniaco per difendere la sua città d’adozione, Sarajevo. Le rivendicazioni nazionaliste, falsamente connotate sotto il profilo religioso, non hanno mai fatto breccia nella sua mente e nel suo cuore. Il generale serbo, ricorda Paolo Rumiz nella Prefazione, ha sempre respinto le sirene del Narod, l’infausto concetto genealogico di popolo-nazione che per un secolo ha funestato i Balcani ed è sempre pronto, sotto altri nomi e in altre lingue, a risvegliarsi in Europa. Questo serbo, da quarant’anni in Bosnia, non ha avuto dubbi nel momento dell’aggressione alla sua terra adottiva ed è accorso in sua difesa. «Non ha sentito il richiamo del sangue, che in quelle ore divideva secondo assurdi pedigree le masse impaurite dalla Slovenia al Montenegro, – ricorda il giornalista – ma quello del territorio». I motivi di questa “scelta di campo” sono stati molteplici: innanzitutto la convinzione che l’identità culturale non coincide con la nazionalità, ma si costruisce giorno per giorno con la cittadinanza, entrando in contatto con gli altri, arricchendosi della storia, della cultura e della lingua di ciascuno; in secondo luogo l’aderenza al sogno titino di una grande Jugoslavia democratica, in cui tutti i popoli della regione (bosgnacchi, croati, macedoni, montenegrini e serbi) godessero di riconoscimento e rappresentatività proporzionale alla loro presenza; dulcis in fundo, l’amore sconfinato per Sarajevo e i suoi abitanti.
Ma Divjak ha pagato a caro prezzo la difesa dei suoi ideali: ha subito e continua tutt’oggi a subire minacce di morte e accuse di tradimento da parte dei suoi connazionali ed è guardato con sospetto dai nazionalisti bosgnacchi. Dopo essere stato accolto calorosamente dalle alte gerarchie militari bosniache, infatti, è stato gradualmente allontanato dai centri decisionali, fino ad assumere una posizione marginale all’interno dell’Armija, l’esercito bosniaco. Presentato agli osservatori internazionali come l’esempio vivente dell’ideale multietnico bosniaco, in realtà è stato l’ennesima vittima del clima del sospetto e della diffidenza reciproca che la guerra ha diffuso tra i tre popoli costitutivi della Bosnia-Erzegovina: bosgnacchi, serbi e croati.
Oggi Divjak rifiuta l’etichetta di “serbo buono” e, pur non rinnegando le sue radici serbe, dice di sentirsi bosniaco: «Ai curiosi che dicevano di voler incontrare il serbo dell’Armija, dicevo d’essere un bosniaco. Bosniaco e terrestre, dato che sul pianeta terra sono nato. Mi capitò di dire a un giornalista che ero un ebreo! Per farla corta, le nazionalità, i gruppi etnici, sono abiti striminziti nei quali mi seno soffocare».
Dal 1994 il generale si occupa degli orfani di guerra con l’associazione “L’educazione costruisce la Bosnia-Erzegovina” di cui è fondatore e presidente. Con questa iniziativa ha voluto continuare a prestare il proprio servizio alla comunità bosniaca, dopo il pensionamento forzato cui è stato costretto da esponenti nazionalisti dell’esercito e in seguito alla consegna, in segno di protesta, dei gradi militari al presidente bosniaco Alija Izetbegović.
La guerra in Bosnia-Erzegovina: l’assedio di Sarajevo, la tragedia di Srebrenica
Nei ricordi di Divjak,
L’assedio di Sarajevo inizia ufficialmente l’8 aprile 1992, quando
L’odio razziale raggiunge a Srebrenica l’acme dell’atrocità. La città era una enclave bosniaca circondata da territori abitati da serbi e costituiva una “zona protetta” controllata dalla Forza di protezione delle Nazioni Unite (Forpronu). L’11 luglio 1995, quando la guerra è alle battute finali, Srebrenica è il teatro del peggiore massacro di civili bosgnacchi da parte delle truppe paramilitari serbo-bosniache di Mladic, che deportano la popolazione e trucidano in massa circa ottomila uomini di età compresa tra i tredici e i sessantacinque anni. A questa strage assistono impotenti 600 caschi blu olandesi, non autorizzati a intervenire dal Consiglio di sicurezza dell’Onu. Così, quando i serbi iniziano a bombardare la città, le forze di pace abbandonano le loro posizioni per proteggersi, lasciando gli abitanti totalmente alla mercé degli aggressori.
A più di dieci anni dall’eccidio, i suoi responsabili politici e militari sono ancora largamente impuniti; solamente nel marzo 2007 il Tribunale penale internazionale dell’Aja ha disposto l’arresto dell’ex leader politico serbo-bosniaco Radovan Karadžić e del suo capo militare Mladić, e ha definito il massacro un genocidio, secondo i principi di Norimberga. La strage di Srebrenica, infatti, ricorda, per la crudeltà e la sistematicità con cui è stato commessa, la “caccia agli ebrei” scatenata dai nazisti durante
In questo quadro a tinte fosche, Divjak inserisce i ritratti di personaggi truci e violenti, come Karadžić e Mladić, ma anche di tanti eroi positivi, che si adoperano per un futuro all’insegna del rispetto reciproco e della tolleranza. Tuttavia, come dimostra il risveglio nei nazionalisti in Kosovo, i Balcani sono ancora lontani dalla pacificazione, a testimonianza del fatto che il germe dell’odio raziale, una volta diffuso, è difficile da estirpare.
L’ultima guerra del XX secolo o la prima del XXI?
Le guerre in ex Jugoslavia, le prime nel vecchio continente dopo
Allo stesso tempo, però, come ricorda Paolo Rumiz nella Prefazione, questa guerra conteneva in sé non solo il retaggio ideologico dei conflitti passati, ma anche i germi di quelli futuri, che insanguineranno il pianeta, da un capo all’altro, sotto le insegne di “guerre sante” o di “guerre della civiltà”. «Se avessimo chiamato i Balcani Balkanistan [...] avremmo visto che quella non era l’ultima barbarie del Novecento, ma la prima guerra del ventunesimo secolo», asserisce provocatoriamente il giornalista. La storia recente gli dà ragione: i posti in cui culture e religioni diverse convivono da secoli, basti pensare alla Terra santa e al Libano, sono teatro di conflitti sanguinosi e cresce ovunque l’intolleranza e la paura per lo straniero. Le idee di Milošević e dei suoi luogotenenti hanno infine trionfato: l’Islam è diventato il pericolo per antonomasia di questo scorcio di secolo.
Di fronte a questa deriva culturale, la comunità internazionale sembra del tutto incapace di reagire. L’Onu è un’istituzione anacronistica, dalla burocrazia elefantiaca, paralizzata dalle scaramucce tra i membri del Consiglio di sicurezza. L’Europa è sempre più impotente e succube delle ingerenze degli Stati Uniti, ribattezzati da Rumiz «il poliziotto del mondo». E, ancora una volta, dietro il pretesto dello scontro di civiltà e della difesa della libertà religiosa si conducono conflitti “politici” o “economici” che mietono vittime soprattutto tra i civili. Esattamente come è avvenuto in Bosnia dove, sotto le mentite spoglie di una guerra “santa” degli ortodossi (serbi) contro i musulmani (bosgnacchi), si celava un progetto espansionistico, che mirava ad allargare i confini dello stato serbo, inglobando buona parte del territorio bosniaco.
Alessia Cotroneo
(www.bottegascriptamanent.it, anno II, n. 9, maggio 2008)
Elisa Guglielmi, Ilenia Marrapodi