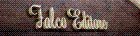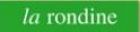Società di prodotti editoriali, comunicazione e giornalismo.
Iscrizione al Roc n. 21969.
Registrazione presso il Tribunale di Cosenza
n. 817 del 22/11/2007.
Issn 2035-7370.
A. XIV, n.150, marzo 2020
Che tipo di società
saremo dopo
la quarantena?
di Alessandro Milito
Diario ai tempi del Coronavirus:
storie di quotidiana “Resistenza”
Domenica 29 marzo 2020
Due settimane e un giorno: è l’età di questo diario. Quando ho iniziato non pensavo che avrei scritto così tante pagine. Forse in cuor mio speravo che questa reclusione si sarebbe attenuata presto o che comunque avremmo trovato il modo di convivere con l’emergenza, senza rinunciare completamente alle nostre abitudini e al nostro stile di vita. Queste due settimane hanno smentito buona parte delle mie prime ed ingenue convinzioni.
È quindi arrivato il momento di ricorrere a nuove dosi di ingenuità in sostituzione di quelle ormai esaurite. Ecco perché voglio chiudere gli occhi per qualche minuto ed immaginare come sarà il dopo. Che tipo di società vivremo? Riusciremo a far tesoro dei drammi che stiamo vivendo in queste giornate drammatiche? Torneremo ad essere liberi cittadini di una repubblica democratica e parlamentare? Sono domande che ancora devono essere interamente formulate e che attendono risposte ragionate e ben pesate: la fretta è cattiva consigliera. Ciò non toglie che dobbiamo e possiamo iniziare a ragionarci su, ad immaginare che tipo di domani vogliamo costruire.
Dovremo uscire da questa emergenza con una chiara convinzione: il sistema sanitario pubblico ed universale è uno dei pilastri imprescindibili su cui si fonda la nostra società. Senza di esso non riusciremmo a riconoscerla e ad identificarci con essa. Da ciò deve derivare una necessaria considerazione: attualmente il nostro Paese non è in grado di garantire un servizio sanitario degno di questo nome su tutto il territorio nazionale. Ferme restando le eccellenze comunque distribuite in ogni regione, il nostro sistema si basa su un’ormai inaccettabile differenza tra regioni meridionali e settentrionali. Cosa sarebbe successo se l’emergenza fosse scoppiata in Campania o in un’altra popolosa città meridionale anziché in Lombardia? Non vogliamo rispondere a questa domanda perché ci fa paura il solo pensiero. Il regionalismo, frutto della riforma del Titolo V delle Costituzione del 2001, non è riuscito nell’intento di garantire equamente su tutto il territorio il principio fondamentale della tutela della salute. Purtroppo, al di là delle varie sensibilità al riguardo, questo è un dato di fatto: e da ciò dovremo ripartire.
Dopo una sbornia di qualunquismo e di rifiuto di qualsiasi riconoscimento delle competenze, dovremo finalmente tornare ad essere tutti più umili. A capire che l’enorme potenziale concessoci dalla rete non ci rende esperti di tutto e che, anzi, ci rende potenzialmente più deboli ed ignoranti se non riusciamo a capire quando stare in silenzio e ad ascoltare chi ne sa più di noi. Non siamo tutti medici, non siamo tutti ministri o legislatori: ognuno può diventarlo e, se ci crede, deve provarci. Ma questo non ci abilita a trattare tutti con il medesimo metro di giudizio, a ritenere valida ogni opinione in qualsiasi campo. La scienza non è democratica e non può esserlo. La società democratica deve saper trasmettere le conoscenze scientifiche e formare i cittadini in modo tale che possano riconoscere quando sono presi in giro dal fanatico tuttologo di turno. In attesa del prossimo vaccino che ci permetterà di rompere la nostra reclusione, ricordiamoci di chi ha lottato per impedire le vaccinazioni obbligatorie: vogliamo ripetere lo stesso errore?
La libertà: mai darla per scontata, mai più. La consapevolezza di poter uscire di casa, andare dove meglio si crede; camminare senza avere in tasca un’autocertificazione, senza dover barrare una casella e senza dover dare conto a nessuno del perché abbiamo deciso di muoverci; la possibilità di andare in piazza, manifestare, scioperare, contestare; la garanzia che i nostri spostamenti non saranno tracciati tramite la rete cellulare e che la nostra privacy e la nostra riservatezza sono dei luoghi in cui non si può entrare senza la nostra autorizzazione. Quando sentiremo che, dopotutto, «quando c’era lui di cose buone ne sono state fatte»...ricordiamoci a maggior ragione a che prezzo. Rammentiamo che quel prezzo era la nostra libertà: quanto ci manca in questi giorni? Quanto è essenziale per poter definire davvero la nostra identità di cittadini?
Sono solo alcuni dei pensieri venuti fuori da qualche minuto di occhi chiusi e, forse, sognanti. Il nostro dopo deve iniziare già adesso: pensiamo a come vorremo essere quando questa quarantena sarà il grande racconto da tramandare a chi ancora non è venuto a farci visita
Alessandro Milito
(www.bottegascriptamanent.it, anno XIV, n. 150, marzo 2020)
Fantasia e diario
vaccini contro
la monotonia
Diario ai tempi del Coronavirus:
storie di quotidiana “Resistenza”
Giovedì 26 marzo 2020
Sabato 28 marzo 2020
Sabato, weekend. Ormai ha assunto un significato ben preciso: è il giorno della spesa. Le altre giornate sono dedicate allo smart working o, per dirla con il linguaggio bizzarro del nostro legislatore, lavoro agile. Domenica i supermercati sono chiusi: ordinanza regionale; senza contare che domenica devo uscire per andare in edicola e comprare un giornale e due inserti culturali: un piccolo rito che ancora mi concedo. Insomma, la domenica è già ampiamente occupata, la spesa si deve fare di sabato. E, infatti, sono uscito di casa, mi sono aggiunto alla solita fila, ordinata e silenziosa. Il suono di qualche ambulanza che passa, la voce che ripete alla gentile clientela di «non sostare troppo nel reparto ortofrutticolo e di agevolare le operazioni», lo sguardo diffidente di chi ti vede senza mascherina (ancora non sono riuscito a trovarne una, non è colpa mia). Insomma: tanti piccoli dettagli di quella che, a suo modo, è diventata una routine.
Fortuna che questo diario mi aiuta a spezzare quella monotonia che, altrimenti, diventerebbe davvero difficile da gestire più di quanto non lo sia già. Oggi ho ricevuto un bel racconto, il contributo di un autore che preferisce mantenere l’anonimato. Ancora una volta, noto che l’appello lanciato da queste pagine è stato accolto nel migliore dei modi: non potevo chiedere di più. Perciò, lascio spazio ad un punto di vista del tutto particolare: leggendo capirete il perché.
Non avevo mai notato lo scroscio d’acqua siddhartiano di quella fontana che mi è sempre stata di fronte. Nemmeno quando era notte fonda, o sul far del mattino, prima che accadesse “questa cosa di cui tutti parlavano in giro fino a qualche settimana fa”. Per la verità, non lo avevo mai sentito... Quante e quante cose non avevo più ri-sentito. Il grido di insofferenza di una bambina che piange, proveniente per la precisione dal lato sinistro di quella inerte fontana che ho sempre avuto di fronte: “Voglio andare all’asilo! Voglio andare all’asilo! Voglio andare all’asilo!”. Un eco potente, semplice. Un eco che non avrei mai sentito, “prima che accadesse questa cosa di cui tutti parlavano in giro fino a qualche settimana fa”. Un eco inevitabilmente confuso, tra il brusio frizzante di quelli che mi notano e quelli che non mi notano. Adesso, per esempio, basta che apra uno dei miei tanti occhietti ed ecco: riesco finalmente a sentire, ben scanditi, i vari “buongiorno”, “buonasera”, “grazie per quello che state facendo”, “forza ragazzi”, rivolti ai protettori in divisa che ho intorno. Sempre adesso, per esempio, odo ben scandito il nome di qualche Santo invocato coloritamente da chi proprio non è mai consuetamente notato o sentito. Eppure, basterebbe solo ricordarsi dove trascorrono quotidianamente la loro quarantena sociale (magari dietro il lato sinistro di quella sinistra fontana?), se un motivo ora lo permette, naturalmente...loro: “operai che nessuno chiama nella propria vigna”.
Trovare un motivo, per voi, è naturale. Per me, di naturale, c’è, solo, lo scroscio d’acqua siddarthiano di questa fontana che mi è sempre stata di fronte: un sottofondo surreale a “questa cosa di cui tutti parlavano in giro fino a qualche settimana fa”. Per voi, è naturale chiedersi, tra un ritornello musicale e un altro, “cosa sarà”? Per me, è naturale chiedersi, in fedele silenzio, “cosa non sarà”. Per voi, è naturale definirla “una guerra”, “una lotta”, “una trincea”. Per me, che da secoli ne ho viste e sentite di “guerre”, “lotte” e “trincee”, questa cosa non è un istinto di sopravvivenza verso una conquista che si è voluta con le armi. Le guerre si desiderano, si cercano, si vogliono per l’appunto. E poi, francamente, io ne sono la testimonianza diretta: si può sopravvivere/uscirne indenni dai bombardamenti. Comunque, le guerre, vengono dall’uomo, e più precisamente, dalla nota stonata che, arbitrariamente, intende leggere e ascoltare.
Questa cosa non ha nemici. Qualcuno l’ha voluta? E’ silenziosa, furtiva. E’ come una grande crepa che, un giorno, può formarsi all’improvviso dentro le mura della Chiesa che ho alla mia destra, da sempre, senza avvisare. E che implica un restauro esteriore ed interiore. Chiede di restare a casa, perché un raffreddore può diventare pericoloso, talora letale. Chiede di restare a casa, perché non si può più sognare, fare programmi. Fintanto che, può arrivare il momento che non c’è più la voglia, la forza interna. Come arriva in fretta la notte! E che straordinarie coincidenze...Quanto diventa pesante arrivare a sera e domandarsi se sul piatto della bilancia sia stata più pesante la Croce umiliante della restrizione temporale o spaziale, spirituale o fisica.
Questa cosa non può essere definita. Semplicemente perché non ha definizioni. Si definisce ciò che ha una Ratio. E questa volta, una Ratio non c’è. C’è una ratio scientifica, causale, “come sentivo per le strade fino a qualche settimana fa”. Ma una Ratio, questa volta, non c’è. Togliamoci dal tetto la retorica del Super-uomo, la ricerca (peraltro offensiva e irrispettosa) di un nostro quid da immolare a capro espiatorio di ciò che sta avvenendo, per passare una notte finalmente lieta e tranquilla. Piuttosto domandiamoci: perché siamo alla ricerca di immagini belliche? Perché ci stiamo ritrovando uniti in metafore belliche? Di quali e quanti vuoti, privati e pubblici, è fatto questo “qualcosa da raccontare alle generazioni future”, “questa guerra” accorata? E da quanto tempo si sta incubando “questa guerra” velata che, a detta dei più, aspetterebbe solo di essere squarciata?
Tra tesi e antitesi, io sono solo un palazzo. Un palazzo che ha sempre avuto, alla propria sinistra, persone e istituzioni dedite alla vita civile. Alla propria destra, persone e istituzioni dedite alla vita di fede. Una sintesi, quanto alle conseguenze dell’anno (e degli anni) che verrà, la si potrebbe trovare al centro, senza andare troppo in là con lo sguardo dal salotto in cui mi sono permesso anonimamente di intrufolarmi. I miei occhi sono squadrati e tondeggianti, e non hanno esattamente la stessa forma, a notarli bene. Di fantasia ne avrebbero...eppure continuano a posarsi, addolorati, piangenti, insistentemente, sullo scroscio d’Acqua siddhartiano di questa tranquilla fontana che ho sempre avuto di fronte. E in essa, noto, trovano metaforico, semplice e sicuro Conforto.
Ricordiamoci, insomma, che siamo palazzi: non caserme. “Siamo Uomini, o (incoronati) caporali”?
Un’esperienza come quella che stiamo vivendo, profondamente individuale ma drammaticamente collettiva, cambierà il nostro modo di vedere il mondo che ci circonda, inciderà su come ci approcciamo ad esso. Lo sta già facendo. Trovare le parole giuste per descrivere questo cambiamento in atto non è facile: ma è necessario. Abbiamo bisogno di penne agili e fantasiose, disposte a descrivere, raccontare, testimoniare. Andiamo avanti: c’è ancora tanto da scrivere. La fantasia non va in quarantena.
Alessandro Milito
(www.bottegascriptamanent.it, anno XIV, n. 150, marzo 2020)
Un’equa “Patrimoniale”
antivirus: non lasciamo
altri debiti ai nostri figli!
Diario ai tempi del Coronavirus:
storie di quotidiana “Resistenza”
Giovedì 26 marzo 2020
Venerdì 27 marzo 2020
Il bilancio di oggi è nero: mai così tanti morti in una sola giornata. Il costo umano di questa immane, immensa e storica tragedia comincia a diventare sempre più gravoso. Mentre l’Italia continua a guidare la drammatica classifica dei decessi nel mondo, comincia a diventare sempre più chiaro e tangibile che stiamo per addentrarci in un periodo ricco di incognite e di turbolenze economiche e sociali. La stessa integrazione europea, già ansimante negli ultimi anni, rischia definitivamente di esaurirsi e perdersi per sempre. Il drammatico Consiglio europeo di ieri non ha prodotto alcun reale passo in avanti nella condivisione dell’emergenza sanitaria e nella costruzione di un destino comune.
Il Presidente della Repubblica Mattarella ha rilasciato un breve ma deciso discorso alla nazione, caratterizzato da un insolito tono fermo e deciso contro l’inerzia degli stati membri dell’Unione. Ed oggi abbiamo tutti negli occhi l’immagine del Papa e della sua solitaria e smisurata preghiera in Piazza San Pietro: una foto che ha già fatto Storia.
Sono giorni di bilanci atroci e di previsioni fosche. Proprio per questo dobbiamo trovare la forza di reagire e di costruire un’alternativa, di immaginare soluzioni economiche e politiche per difendere il nostro tessuto sociale. Dobbiamo avere la forza e la voglia di fare Politica. Per questo oggi voglio lasciare spazio alle parole e alle proposte di Fulvio, direttore di Bottega Editoriale.
Leggiamole, riflettiamoci tutti insieme e, se ne abbiamo voglia e capacità, rilanciamone di nuove.
Afflitti come siamo dagli aggiornamenti circa il nostro caro “virusetto”, la notizia che l’Unione europea ci consenta di splafonare sui vincoli di bilancio sembra aver subito la sordina. Ma, seppur senza troppo chiasso, tutti hanno gioito: «ewwiwa!». E, già che c’era, l’Ue ha consentito la stessa deroga a tutti. Anzi, per farla per intero, abolirà i vincoli stessi «Ewwiwa!, Ewwiva!! Ewwvia!!!».
Nonostante gli “arresti domiciliari” che colpiscono ciascuno di noi, e che potrebbero essere utilizzati per ragionare con maggior ponderatezza le problematiche che ci si pongono dinnanzi, poche o nulle sono state le voci che hanno riflettuto e fatto riflettere che, sul lato europeo, ciò significa fare un passo indietro sul cammino dell’integrazione dei popoli d’Europa, e dell’abbattimento delle barriere nazionali. È chiaro che i vari governi (soprattutto quelli dei paesi ricchi) saranno portati a chiudersi a riccio non accettando più – essendo caduti i parametri di garanzia finanziaria – di mettere assieme i propri conti “forti” con quelli “deboli”.
Ma, al di là di questo: ci rendiamo o non ci rendiamo conto che oltre ad aver passato ai nostri figli i debiti che i nostri padri avevano contratto a nostro danno, stiamo passando loro altri miliardi di debiti aggiuntivi?
Ma certamente, l’esigenza di finanziare lo sforzo straordinario sanitario, come anche l’esigenza di sostenere le famiglie e i lavoratori di ogni tipologia – e più in generale l’Economia – dagli ingenti danni subiti, è un problema reale e imprescindibile.
Allora, parafrasando il nostro vecchio amico Vladimir Il'ič Ul'janov: «Che fare?».
Non v’è dubbio che una equa “Patrimoniale” sarebbe la via più indolore e più efficace.
Indolore perché, tassando i patrimoni immobiliari, si inciderebbe su persone ricche che non si accorgerebbero nemmeno del danno subito. Efficace perché risolverebbe in poco tempo il problema delle attuali spese straordinarie e – se attuato con un po’ di coraggio in più – darebbe un bel colpo all’enorme Debito pubblico che tanto ci danneggia e tanto rende quasi inutile quell’Avanzo primario che con tanta fatica l’Italia riesce a conseguire da diversi anni a questa parte. Ovviamente l’imposizione straordinaria dovrebbe essere progressiva colpendo con un’aliquota più alta i patrimoni maggiori con riduzioni progressive, appunto, sino ai più piccoli e con esenzione per la Prima casa. Ma, sia ben chiaro, solo se il valore catastale non dovesse superare il valore di 100.000 euro; oltre questa cifra si dovrebbe contribuire con un piccolo importo che salirebbe poi seguendo la citata progressività.
Il gettito fiscale sarebbe, oltre che equo e indolore, anche certamente risolutivo: non va difatti dimenticato che l’Italia, accanto ad un terribile Debito pubblico, si caratterizza pure per un’enorme ricchezza privata che, in buona parte, si è creata anche grazie ai benefici prodottisi in loro favore dalla spesa pubblica che ha determinato il citato Debito pubblico.
Una “Patrimoniale” siffatta rappresenterebbe dunque sostanzialmente una restituzione, da parte dei grandi beneficiari, di una parte dei benefici ottenuti.
Ma non tutto il gettito andrebbe utilizzato per le misure di compensazione dei redditi persi a causa della nostra reclusione e per la diminuzione del Debito pubblico.
Necessitano investimenti e recuperare veramente l’evasione fiscale.
Due esempi: sul primo punto, forti investimenti per Lavori pubblici urgenti nel campo della tutela idrogeologica del Territorio; sul secondo punto, realizzazione di una migliore e più articolata e precisa realizzazione degli Studi di settore.
Pensiamoci un attimo: facendo pagare una piccola e indolore cifra ai benestanti rivolteremmo la prospettiva attuale. Non consegneremmo ai nostri figli un Debito pubblico ulteriore ma, invece, consegneremmo una situazione migliore sia dal punto di vista finanziario sia da quello ecologico.
«Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività». Sono le parole della nostra Costituzione, idealmente connesse a quell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale che abbiamo citato qualche giorno fa.
Cantare dai balconi l’Inno di Mameli è una forma di patriottismo gentile e sincera. Se a questa si accompagnasse una leale e altrettanto patriottica politica fiscale, ne verrebbe fuori una società migliore, non solo guarita da un virus ma anche più giusta. Pensiamoci.
Alessandro Milito
(www.bottegascriptamanent.it, anno XIV, n. 150, marzo 2020)
La narrazione
della crisi chiede
una nuova meta
Diario ai tempi del Coronavirus:
storie di quotidiana “Resistenza”
Giovedì 26 marzo 2020
Non può durare ancora a lungo, non così. Molti dei discorsi di questi giorni contengono questo passaggio. Parlando con i miei genitori, con i miei amici, presenti e distanti allo stesso tempo, viene fuori un’insofferenza sempre crescente. Niente di strano: i giorni si accumulano senza aggiungere granché alle nostre vite assopite. La quarantena ha completamente stravolto la nostra concezione di spazio e di distanza. Se prima una passeggiata di quindici minuti mi separava dal centro della città, adesso la distanza tra casa mia e le due torri sembra incolmabile. Quel tragitto, percorso più volte, sembra quasi perdersi nella mia mente, ricoperto da una nebbia fitta e gelida. Ormai il mio perimetro non si spinge oltre la forma rettangolare del mio condominio. Quei minuti passati a girare più volte il palazzo sono diventati ormai la mia ora d’aria che, in verità, di ora ha ben poco.
Questa reclusione era stata accettata quasi di buon grado all’inizio, specie perché accompagnata dalla previsione di un orizzonte, di una fine, non troppo distanti. Oggi è difficile indicare una settimana, un mese a partire dal quale potremo dire: sì, abbiamo fatto il nostro dovere, ora si riparte. «Adesso ricominciamo a vivere».
«Inerti, come una nave dipinta sopra un oceano dipinto», scriveva Samuel Taylor Coleridge ne La ballata del vecchio marinaio, evocando un’immagine che possiamo prendere in prestito e far nostra in questi giorni. La mancanza di un orizzonte visibile, anche solo immaginabile, rappresenta un serio problema che dovremo affrontare collettivamente, quanto prima. Certo: può sembrare ben poca cosa se paragonata alla guerra quotidiana combattuta dalle strutture sanitarie, dai malati e dai loro cari che non riescono a star loro vicini. Ciononostante si tratta di un problema drammaticamente reale nella sua semplicità: la società non può funzionare così. Non siamo fatti per stare soli: siamo animali politici, abbiamo bisogno della nostra polis. Senza di essa, semplicemente, non siamo.
Per questo sarà necessario abbandonare un po’ di quella retorica che ci ha accompagnati fino a ora. Abbiamo bisogno di una narrazione della crisi differente, più realistica, più pragmatica, forse più cinica. Non è più sufficiente raccontarci che «andrà tutto bene» e che potremo riabbracciarci di più in futuro. La fame di un obiettivo, di uno scopo e di una meta richiede un nuovo discorso collettivo. Le autorità politiche e sanitarie dovrebbero al più presto inaugurare una nuova fase comunicativa e motivazionale. Se non lo faranno sarà difficile contenere la fisiologica insoddisfazione dei cittadini che, frustrati e demotivati, potrebbero perdere fiducia nelle misure restrittive, pur necessarie.
La battaglia ancora è lunga: serriamo i ranghi.
Alessandro Milito
(www.bottegascriptamanent.it, anno XIV, n. 150, marzo 2020)
La Cultura
bisogna viverla
collettivamente
Diario ai tempi del Coronavirus:
storie di quotidiana “Resistenza”
Mercoledì 25 marzo 2020
Non vado al cinema dal 18 febbraio. Ero andato a vedere Fabrizio De André e Pfm: Il concerto ritrovato, un evento speciale da vivere in sala, il giorno del compleanno del cantautore genovese. Il documentario raccontava il prodigioso esperimento, mirabilmente riuscito, di unire la poetica di De André con la raffinata e colorata musicalità della Pfm. Dopo una prima parte dedicata al racconto di questo sodalizio, seguiva la registrazione del concerto tenuto a Genova nel 1979.
Ricordo bene quella serata al cinema il 18 febbraio: la sala era piena, i posti già occupati da tempo; io e i miei due amici che mi accompagnavano eravamo stati costretti a sederci distanti, da una parte all’altra della sala. Cinema pieno, platea attenta e rapita da quel concerto che riprendeva vita come per magia: qualcuno canticchiava a bassa voce sulle note di Bocca di rosa o di Via del campo.
Non vado in libreria dal 9 marzo. La città era già deserta; la libreria sotto le due torri, di solito nota per quella fila lì, davanti le casse, e i suoi soliti e regolari visitatori, pareva addormentata. Certo: qualcuno ci lavorava ancora, cercando di fare del suo meglio, più del solito. Eppure si avvertiva già una precarietà soffocante, la sensazione che il tuffo verso l’incertezza non avrebbe tardato di molto.
Ho comprato un libro in quel lunedì 9 marzo, data di uno degli ormai noti Dpcm dell’emergenza Covid-19: non l’ho ancora iniziato, non so perché.
Non vado in biblioteca dal 29 febbraio. Dovevo restituire un libro, questa volta finalmente nei termini previsti. Ricordo di averlo sfogliato un’ultima volta, di aver preso il solito caffè macchiato in vetro nel mio solito bar, e di aver registrato la restituzione: adesso non c’è bisogno del contatto con un bibliotecario, l’operazione è tutta automatica. Eppure, la biblioteca vicino il Nettuno è sempre stata il palcoscenico di centinaia di contatti di ogni tipo. Lì ho letto migliaia di pagine e passato centinaia di ore, conoscendo, anche solo con uno sguardo complice, spaccati della più varia umanità.
Sarei dovuto andare a vedere e sentire un concerto all’Auditorium e poi una “prima” al Teatro Comunale: avevo già trovato la compagnia giusta, avevo già scelto gli spettacoli. Ho ancora con me un bel libretto e qualche dépliant con le date segnate: li prendo sempre, li conservo da qualche parte e li ritrovo, prima o poi.
Avrei dovuto prendere il biglietto per il concerto di Brunori Sas: i posti ancora c’erano e mi ero ripromesso che no, stavolta non avrei aspettato fino all’ultimo, per poi rimanere, inevitabilmente, deluso e senza biglietto. Il concerto sarebbe stato all’Unipol Arena, lo stesso luogo dove, qualche settimana prima, mi ero recato munito di carta d’identità e penna assieme a centinaia di altri come me: c’era un concorso da fare, una preselettiva da superare.
La Cultura, con la c maiuscola, è un’esperienza da vivere in privato, leggendo un buon libro nella propria stanza o sotto un ombrellone. Ma è anche, e sto iniziando a capirlo come non mai in questi giorni, un’esperienza collettiva. Mi mancano i luoghi della Cultura, i suoi templi e i suoi palcoscenici. Sento il bisogno, quasi fisico, di tornare in sala a vedere un film: non importa quale, basta che non sia relegato al mio piccolo schermo da 13 pollici del pc. Sento il bisogno di toccare i libri, in biblioteca e libreria; non ho mai avuto nulla contro gli e-book: anzi, ne leggo molti. Eppure, ho bisogno di quel luogo lì forse perché, semplicemente, fa parte di me e lì io mi ci rivedo.
Sono necessità e pensieri secondari e marginali, lo so bene: viviamo un momento drammatico e pericoloso, fatto di sofferenze e sacrifici difficili da immaginare e che non saprei nemmeno trascrivere.
Tuttavia, anche questi bisogni, per adesso secondari, sono vita. Sono necessari. E dovranno tornare, come e più di prima, più belli che mai.
Alessandro Milito
(www.bottegascriptamanent.it, anno XIV, n. 150, marzo 2020)
La quarantena dei
“marginali”: dove
sono finiti ora?
Diario ai tempi del Coronavirus:
storie di quotidiana “Resistenza”
Martedì 24 marzo 2020
Dove sono finiti tutti gli altri? Perché, al di fuori di quella cerchia di parenti e amici che anche in questi giorni, in qualche modo, riusciamo a vedere e sentire, c’è un intero mondo là fuori, da qualche parte. Dove sono finiti? Cosa stanno facendo in questi giorni, come stanno vivendo questi interminabili momenti di clausura che si susseguono uno dopo l’altro, identici, statici, angosciosi?
Che fine hanno fatto gli ultimi, gli outcast di Dickens, i derelitti di De André, e tutto quell’universo mondo in cui entriamo in contatto quotidianamente ma solo di sbieco, senza mai approfondire realmente? Che fine ha fatto questo pezzo di umanità? Sono pensieri che lentamente e con forza crescente stanno occupando le mie giornate di quarantena, proprio quando la dimensione individuale della mia esperienza inizia a lasciar spazio a riflessioni più ampie e generali. Dalla quarantena individuale alla quarantena sociale. Questi pensieri trovano un ottimo e illuminante riflesso in quelli che mi ha inviato Fulvio, direttore di Bottega editoriale. Ed è a questi pensieri, sapientemente tratteggiati, che voglio lasciar spazio questa sera, per dare ancora più profondità a questo diario.
C’è una categoria di persone che sta particolarmente soffrendo, nella quasi totale indifferenza, queste giornate di autoreclusione: “i marginali”.
Mi riferisco a quella serie di persone che talvolta per ragioni di immigrazione irregolare, talaltra per ragioni di disturbi psicologici, talaltra ancora per ragioni di contingenza imprevedibile, vivono, appunto, ai margini della nostra opulenta e indifferente società.
Roma ne era piena, ora sono semplicemente scomparsi.
Mi riferisco ai mendicanti, ai senza dimora o, più semplicemente, ai venditori di fazzolettini agli incroci delle strade, o quelli di rose nei ristoranti.
Dove sarà adesso quel ragazzo bengalese che, all’incrocio di via di Porta Furba con via Tuscolana, metteva a frutto gli “interminabili rossi” dei semafori per vendere ai frettolosi automobilisti i propri fazzolettini?
E cosa pensare di quel signore romano con problemi mentali che girovagava per le strade parlando, fra sé e sé, a voce alta e che un giorno mangiava una pizzetta in un bar e un altro in un kebab?
Dove si sarà rifugiato il giovane sudamericano che alla fermata metro “Flaminio” vendeva giochi per bambini?
E quella donna africana che nel Centro storico cercava di “piazzare” le rose alle coppiette?
E quel ragazzo africano che stazionava dinnanzi al “mio” supermercato di Torpignattara che soppesava la moneta che riceveva sorridendo a 100 denti bianchissimi quando avvertiva il peso di una moneta “pesante”?
Dove sarà quel giovane uomo cinese che, a Trastevere, correva come un ossesso fra un ristorante e un altro a prendere e a portare mille cose con gran soddisfazione dei titolari che ne apprezzavano la produttività, ma che ben si guardavano dal regolarizzarlo?
E quella donna che su via Casilina Vecchia, era costretta a vendere il proprio corpo? Ora, fortunatamente, non c’è nessuno schifoso che può insultarla nel corpo e nell’animo approfittando della sua debolezza economica. E per questo ne sono felice. Ma che ne sarà stato di lei?
Di cosa vivranno tutti loro e i loro figli?
Un soffocato urlo di disperazione si eleva verso di noi. Ascoltiamolo. Come? Inducendo per esempio il governo a dare direttive per la requisizione di alberghi ove collocare queste fasce marginali della popolazione nonché a pensare di fornire anche un minimo di sussistenza generale.
Bisogna pensare dunque, oltre che ai sussidi già previsti per le varie categorie anche forme di supporto a tutto quel mondo invisibile e marginale che è quello degli incapienti.
Ma va fatto subito e con operatori di strada: perché quello è uno spaccato di umanità che non ha il commercialista o il consulente legale e che non è nemmeno aduso a frequentare gli altezzosi impiegati Inps o gli svogliati addetti dei Caf.
Nell’assordante silenzio e menefreghismo generale c’è però qualcuno che si è giù mosso: fra gli altri (non tanti, però), evidenzio, su scala nazionale, l’appello di Medicina democratica e, a Roma, l’impegno costante della Comunità di Sant’Egidio e la lettera aperta alla sindaca Raggi elaborata dal Focus-Casa dei diritti sociali.
Sosteniamoli!
Le parole di Fulvio trasmettono tutta quella accorata e premurosa frustrazione che ognuno di noi, tra le pieghe della propria monotonia quotidiana, ogni tanto dovrebbe far propria.
Ho sempre ammirato la bellezza e la potenza di queste parole: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.»
Anche e soprattutto in momenti drammatici come questi, in cui la nostra libertà e la nostra individualità sono messe a dura prova, dobbiamo avere il coraggio di spostare il nostro sguardo sugli altri. Su chi è ai margini da sempre: e lo è ancor più oggi. Dobbiamo adempiere a quei doveri inderogabili di solidarietà che la nostra Repubblica e la nostra Costituzione ci richiedono: solo così sapremo costruire un dopo più bello e più umano. Per tutti, nessuno escluso.
Alessandro Milito
(www.bottegascriptamanent.it, anno XIV, n. 150, marzo 2020)
Il Diario di oggi
si sdoppia: largo
a Valeria Nigro
Diario ai tempi del Coronavirus:
storie di quotidiana “Resistenza”
Lunedì 23 marzo 2020
Quando ho iniziato a scrivere questo Diario ero preoccupato ma anche piuttosto incuriosito, devo ammetterlo. Anche io ho subìto il fascino dell’incognita, la voglia di capire e scoprire come avrei vissuto rinchiuso in casa mia, per diversi giorni. Mi avevano immediatamente rapito alcuni piccoli, bellissimi gesti che riuscivo a rubare guardando lì fuori: il vicino che prende il flauto e improvvisamente si mette a suonare, la mamma che fa ballare il suo bimbo sul terrazzo, l’inno di Mameli (!) cantato senza alcun timore retorico. Sin da subito avevo capito che vedere la città in questo modo, così deserta e assente, sarebbe stato un qualcosa da ricordare in futuro, in giorni (si spera!) migliori.
La sensazione di vivere un momento unico, un periodo da registrare e di cui scrivere, è ancora molto forte in me. Noto allo stesso tempo, ed è inutile negarlo a me stesso, che lentamente mi sto abituando a questa nuova routine. Non che la cosa mi piaccia: tutt’altro. Eppure, la necessità di andare avanti, di continuare comunque ad aprire e chiudere la giornata, ha creato un’insospettabile corazza. Certo: si tratta di una protezione fragile e incerta, della quale si farebbe volentieri a meno. Però c’è, è lì.
Io sono molto fortunato: vivo questa quarantena in compagnia dei miei storici coinquilini, amicizie ultraventennali. Non potrei mai definirmi solo. Quella corazza la riesco a indossare anche per merito loro, per la loro presenza. Eppure, non si tratta delle uniche presenze di questi giorni. Oltre alle persone che quotidianamente ho la fortuna di sentire, ce ne sono tante altre. Persone che mi inviano e raccontano le loro storie, nelle quali riesco a trovare un rifugio dalla noia casalinga.
Ho la fortuna di leggere tanti pensieri, racconti, poesie, spunti: tutti frutti di questa bella e terribile voglia di scrivere quando ogni cosa diventa più difficile. Leggere per esempio della «curva dell’umore» di Valeria Nigro che vive a Roma e da lì racconta il saliscendi dei suoi pensieri e delle sue emozioni.
Valeria è una collaboratrice di Bottega editoriale che ha risposto al mio appello, nel suo particolarissimo modo, con le sue personalissime parole. Di questo le sono grato: questo Diario, nato come una riflessione serale in stato di quarantena, può diventare un palcoscenico molto più frequentato, rumoroso e, a modo suo, gioioso. Ecco perché voglio cedere la parola a lei. Leggendola mi sono chiesto quanto potenziale abbiano queste giornate così strambe. Giorni pieni di momenti ripetuti chissà quante volte, automaticamente e senza pensarci troppo, ma che solo adesso sembrano assumere un significato del tutto nuovo, una dignità propria. Entriamo nella quarantena di Valeria: così simile alla mia, alla nostra, ma pur sempre così diversa: unica.
Li considererei un piccolo traguardo, i primi dieci giorni, se sapessi esattamente quanto manca alla fine di questa storia, ma non è così, quindi rimangono un semplice numero in un continuum progressivo.
È giorno di spesa. Io e i miei genitori ci siamo dati come regola di uscire una volta a settimana per l’acquisto di generi alimentari. Mi sono offerta volontaria, in una situazione che mi faceva sentire un po’ Katniss Everdeen in Hunger Games quando urla la famosa frase «I volunteer!» e non sembra neanche tanto un’esagerazione.
Mi sono preparata: scarpe comode, tuta da ginnastica, capelli legati, mascherina e guanti, e sono uscita. È stato bello, per un attimo, avere il sole in faccia e ricordarsi come si cammina verso un obiettivo. C’era il gatto di quartiere che mi ha riconosciuta e mi si è strusciato su una gamba.
Chissà anche lui da quanto tempo non poteva farlo.
La Curva dell’umore è schizzata verso l’alto.
È tornata a scendere quando mi sono resa conto che non c’era anima viva per strada. L’edicola sotto casa era aperta, non ci sono mai andata se non per comprare i biglietti dell’autobus, ma mi è venuto spontaneo salutare il proprietario rinchiuso nella sua cabina. Lui ha sorriso e mi ha salutata con la mano guantata. La Curva è tornata a salire.
Arrivata davanti al supermercato ho pensato, per un attimo, che non ci fosse nessuno neanche lì, finché non mi sono guardata intorno. Le persone c’erano, ma erano talmente sparse per il parcheggio da sembrare vaganti e mascherati zombie solitari, armati di carrello.
La guardia giurata mi vede e mi porge il numeretto. Sento il bisogno di chiedere “Chi è l’ultimo?” come dal dottore, ma dovrei tirarmi giù la mascherina e mi passa la voglia.
L’attesa è frustrante. Fanno entrare quattro persone alla volta e ho paura che qualcuno possa perdere la pazienza, creare scompiglio, reagire con violenza. Ma mi ripeto che è solo paranoia e che gli altri sembrano forzatamente pazienti, esattamente come me.
Una donna sbatte il tacco per terra, un uomo fuma una sigaretta dopo l’altra intossicando l’aria, un altro fa dei sospiri talmente rumorosi da sembrare un treno a vapore.
La Curva scende sempre di più.
Una ragazza con la faccia conosciuta – compagne di liceo ma mai amiche – mi saluta.
«Entro con te» dice e io annuisco, ancora senza parlare.
Pian piano vediamo la gente entrare e uscire, fino all’arrivo del nostro turno.
Appena entro sento un forte odore di disinfettante a cui, per forza di cose, abbiamo fatto l’abitudine. Quell’odore di Amuchina con un mix di candeggina.
L’ eau de toilette più in e ricercata del 2020.
Alla frutta ci lanciamo uno sguardo. Rimaniamo a distanza, ma mi attende mentre prendo frutta e verdura. Io aspetto lei mentre sceglie i cereali per la colazione.
Vederla lì, ad aspettarmi, mi fa salire un po’ la Curva dell’umore.
C’è un silenzio innaturale nel supermercato e forse, per bilanciare la mancanza di rumore da parte della clientela, hanno anche abbassato la musica. Ma ringrazio per l’ennesima canzone anni Settanta di Radio Italia.
Cerco la farina, ma lo scaffale è terribilmente vuoto. Mi viene un accenno di ansia, ma mi ripeto che non siamo in guerra, che i beni arriveranno e che per questa settimana siamo a posto.
Passeggio per gli scaffali prendendo il necessario e, al contempo, tenendo sotto controllo ogni persona nei miei dintorni, ma sono tutti a debita distanza.
La ragazza, di cui mi sforzo di ricordare il nome ma senza successo, mi passa accanto. «Cassa?» mi chiede e io annuisco.
Ci avviamo ma io rimango un paio di metri dietro di lei, perché uno dei commessi, con mascherina e guanti, ci dice di mantenere le distanze e che le casse sono piene. Non più di due persone alla volta.
Una signora, da distanza consentita, chiede di poter passare avanti. Ha in mano solo quattro prodotti, pane e qualche affettato.
«E certo, e tu vieni a fare la spesa pe’ ’ste quattro cose?» domanda una donna in fila davanti a lei.
«E queste me servivano» risponde l’altra, con faccia tosta.
Continuano a battibeccare e a me viene da ridere. La Curva dell’umore sale un po’.
Trovo divertente che sia servita una pandemia mondiale per far passare gli italiani dal «Don’t ask, don’t tell» americano al «If you see something, say something» inglese.
Durante la serata di ieri, il sindaco aveva tenuto a farci sapere attraverso il gruppo comunale su Telegram che erano arrivate ben cinque segnalazioni ai carabinieri per un assembramento in piazza. Si congratulava per la serietà.
Speriamo di non esagerare nel senso opposto.
Arriva il mio turno e la cassiera mi saluta con un buongiorno strozzato dalla mascherina verde e un movimento della testa; la ragazza, ormai verso l’uscita, mi fa un cenno con la mano e se ne va.
Breve ma intenso, penso, con un sorriso.
Esco con due buste piene che adesso mi dovrò trascinare su per la salita che porta a casa mia. Uscire a piedi non sembra più un’idea geniale adesso, ma quei trenta minuti di cyclette che ho iniziato a fare nel primo pomeriggio, dopo aver visto sessioni di workout su Instagram e il vicino di casa che nel giardino tira su casse d’acqua, mi aiuta a non arrivare senza fiato, anche con l’impedimento della mascherina. La Curva dell’umore rimane stabile.
Neanche il tempo di entrare in casa e mia madre mi ricorda di andare a lavarmi le mani.
«Cantati da sola “Buon compleanno”, due volte» mi dice, ridendo. Non so dove ha sentito che in trenta secondi si canta due volte “Buon compleanno” e considerando che domani è davvero il mio compleanno, lo trova abbastanza divertente. Tanto da ripeterlo due/tre volte al giorno.
Le do soddisfazione, mi lavo le mani e canto a voce molto alta, giusto per infastidirla. La Curva dell’umore ha un fremito su e giù: su perché mia madre riesce sempre a strapparmi un sorriso, giù perché mi ricordo del mio imminente compleanno in quarantena.
Mamma mi ha commissionato di comprare le fragole e saranno l’ingrediente principale della mia torta, domani.
Non sono un’amante delle feste di compleanno – e neanche delle fragole, a dirla tutta, ma non mi lamento – specialmente la mia. Ma il mio ragazzo aveva preso un giorno di ferie e io avevo organizzato la giornata al Bioparco di Roma, il pomeriggio una visita prenotata alla Galleria Borghese, perché era da troppo che non vedevo David con la testa di Golia del Caravaggio e il Ratto di Proserpina di Bernini.
Beh, sarà per un’altra volta.
Un chilometro di strada provinciale separa me e il mio ragazzo, ma basta per dire che ci troviamo in due comuni differenti e non possiamo vederci, neanche dandoci appuntamenti romantici allo stesso supermercato come qualcuno fa.
Ma domani ho tanti impegni. Mattina videochiamata Whatsapp con i miei parenti; pomeriggio “
Pensando a questi impegni inderogabili la mia Curva dell’umore sale, finché non mi siedo sull’angolo opposto del divano, in confronto a dove è seduto mio padre. Oggi è la sua festa e ieri, io e mamma, abbiamo impastato e preparato i bignè di San Giuseppe, come da tradizione.
Per quanto io stia attenta, mantengo comunque una certa distanza. Mio padre è uno di quelli più a rischio per i motivi che abbiamo imparato a conoscere.
È una delle ragioni per cui ho preso seriamente fin da subito la questione “Coronavirus”, fin da quando a gennaio, scherzando – ma mica tanto – dicevo a mamma: «Me sa che tocca fa’ scorte de Amuchina e farina.»
In tv c’è un ciclo infinito di telegiornali e speciali, speciali e telegiornali e talk show politici dove non c’è traccia di politici ma uno squadrone di opinionisti, infettivologi e virologi.
Vedo la Curva dei contagi, e la mia Curva dell’umore va giù.
Papà a un certo punto sbuffa: «Non ce la faccio più co’ sti speciali» mi dice.
Apre YouTube e mette un piccolo spezzone di un vecchio spettacolo di Aldo, Giovanni e Giacomo. Ridiamo e la mia Curva dell’umore va su.
Mamma sta preparando la torta dietro di me e mi chiede di tagliare le fragole.
«Dimmelo, no, che me la devo fa’ da sola la torta!» mia madre mi minaccia col cucchiaio di legno, colpendomi il sedere. La Curva sale ancora.
La sera, a cena, evitiamo i telegiornali come la peste – modo di dire particolarmente divertente in questo momento, per chi ha un certo black humor, come me – e a un certo punto mamma si alza e spegne le luci.
«Alexa ¬– urla, non sono mai riuscita a farle capire che non è necessario – riproduci Inno di Mameli».
Alexa inizia e si sposa benissimo con il dirimpettaio che, dal suo balcone, inizia a sventolare la bandiera dell’Italia.
Mi viene da ridere, la prendo in giro, perché in fondo sono una snob, ma lei si diverte e saluta tutti. Va bene così.
Ogni giorno è una lotta continua per tenere su il morale, per ricordarmi senza sosta che non sarà così per sempre. A volte penso che darei qualsiasi cosa per uscire a bere un bicchiere di vino con il mio ragazzo e le mie amiche, ma poi mi ricordo che io ho ancora mamma e papà con me, cosa che non tutti possono dire. E tra poco tutta la famiglia allargata sarà di nuovo unita.
Nel frattempo, come si suol dire, teniamo botta e, come dicono tutti, andrà tutto bene.
Riprendo “la parola” sulla chiusa incoraggiante di Valeria facendola mia, tutti chiusi dentro le nostre case ma comunque insieme.
Alessandro Milito
(www.bottegascriptamanent.it, anno XIV, n. 150, marzo 2020)
Un conflitto appena
iniziato e per cui
ancora non c'è fine
Diario ai tempi del Coronavirus:
storie di quotidiana “Resistenza”
Domenica 22 marzo 2020
Improvvisamente una voce squarcia il silenzio: urla BASTA, BASTA, BASTA, tre volte, quasi disperata; poi svanisce. Mi affaccio dal balcone: qualcun altro fa lo stesso. Ci guardiamo, cerchiamo di capire da dove sia arrivata quella voce lì. Niente da fare: un ultimo sguardo d’intesa, un dignitoso cenno di saluto e si rientra nella propria forzata intimità domiciliare.
In questi giorni capita spesso di sentire, leggere e dire a se stessi: siamo in guerra. Siamo in guerra contro un nemico invisibile, questo è il nostro conflitto mondiale. Non ho ancora deciso se fare mio questo paragone. Di certo questo è l’evento più totalizzante e potente che abbia mai investito la mia generazione e quella dei miei genitori: impossibile starne fuori, impossibile far finta di nulla. La vita di ognuno di noi è stata improvvisamente travolta da un fatto enorme, totalmente inaspettato e imprevedibile nei suoi sviluppi. Volenti o nolenti, siamo tutti in grado di indicare con precisione un prima e un dopo. Ciò che ieri ci sembrava assolutamente necessario e indispensabile all’improvviso ci appare piccolo, superficiale, sostituibile; mentre alcune cose che abbiamo dato per ovvie, banali e semplici, oggi vengono illuminate e svelate da una luce tutta nuova.
Siamo in guerra, ci diciamo. Il guaio è che è una guerra senza fronte, senza eserciti e campi da battaglia sui quali misurarsi. Non si vede un obiettivo tangibile, afferrabile e raggiungibile. In questi giorni stiamo ridisegnando le nostre sensazioni, stiamo costruendo un’altra barriera di pensieri e sentimenti. L’euforia e la macabra adrenalina, tipiche dell’inizio di ogni conflitto, sono già svanite. Sembrano già lontani i momenti degli applausi collettivi, dei canti e delle suonate, tutti insieme sui nostri balconi e dalle nostre finestre. Certo, qualche irriducibile c’è ancora: ma le sue note hanno un sapore tutto diverso, un retrogusto di malinconia difficile da ignorare. Siamo entrati nella seconda fase di questa grande prova collettiva: il conflitto è iniziato, sappiamo cosa ci siamo lasciati alle spalle ma non siamo in grado di vederne ancora la fine. Non sappiamo come definire il nostro futuro a medio termine, figuriamoci un avvenire più lungo. I dati sono ogni giorno più insensibili e crudi, le rinunce non sembrano avere gli effetti sperati: stiamo combattendo, sappiamo che abbiamo appena iniziato.
Il mio conflitto personale ha già tracciato una prima cicatrice: un mal di testa costante, a intensità varia, sempre pronto ad aumentare e mai ad andar via del tutto. Incomincio a provare un costante rifiuto per ogni schermo, che sia la televisione, il computer o lo smartphone. Tutti oggetti, è bene ricordarlo, fondamentali, mai come adesso; ma quelle cornici cominciano a diventare fin troppo strette.
In compenso sto sfruttando queste giornate per far ordine dentro di me, ristabilire alcune priorità, capire chi mi manca e vorrei vedere e rivedere per davvero, il prima possibile. Un’occasione del genere è unica e, si spera, irripetibile; ognuno di noi può decidere come e perché sfruttarla. Rimane anche oggi, ancor di più, la ferma convinzione di quanto sia importante interrogarsi, capirsi e trascrivere ciò che si percepisce.
Allo stesso tempo sta iniziando a nascere, dentro di me e con insistenza crescente, un nuovo tipo di ansia. Non si tratta di un’ansia necessariamente negativa, anzi: sarebbe il caso di indagarla e di renderla più operativa. L’ansia è quella del cittadino di una repubblica democratica e parlamentare. Sia chiaro: l’emergenza è reale, mai come adesso capiamo il senso di quel «casi straordinari di necessità e urgenza» che permettono all’Esecutivo di farsi Legislatore, seppur per un periodo limitato e sempre con la necessità di un controllo successivo. Eppure, l’emergenza che diventa quotidiano rischia di sedimentarsi e di andare ai intaccare valori e garanzie che abbiamo, tutti, il dovere di difendere. Sempre. Sono pensieri che sarà bene approfondire, barriere che bisognerà ergere se necessario.
Questo weekend di quarantena sta per finire e non sembra nemmeno essere iniziato. Che senso ha parlare di fine settimana quando la settimana stessa sembra non avere più un suo corso, una sua direzione? Mentre scrivo la mia regione ha chiuso le sue frontiere: non si può più entrare né uscire dalla Calabria fino al 3 aprile. Un'altra piccola, irreale barriera che si aggiunge tra me e casa mia.
Forse è proprio vero: non sarà una guerra ma si tratta comunque di un conflitto, strano e irreale. Un conflitto che, a mano a mano, sta cambiando noi stessi e la nostra stessa concezione di spazio e di distanza. Rivedersi, ritornare, riabbracciarsi avrà un significato ancora più vero e profondo.
Alessandro Milito
(www.bottegascriptamanent.it, anno XIV, n. 150, marzo 2020)
Ciò che mi manca
è proprio tutto ciò
che voglio indietro
Diario ai tempi del Coronavirus:
storie di quotidiana “Resistenza”
Venerdì 20 marzo 2020
Mi mancano le piazze, i viali, i vicoli, quelli pieni di gente, in cui quasi non si respira.
Mi manca il rumore della città, garanzia di vita.
Mi mancano i portici di Bologna, chilometri e chilometri di rassicurante bellezza.
Mi mancano le Torri, il centro del mio palcoscenico quotidiano, mai così distanti come ora.
Mi manca la passeggiata, senza meta e senza pretese.
Mi manca il bar, il rito gentile della tazzina al bancone o al tavolino poco distante.
Mi manca l’aperitivo, la ricompensa di una giornata di lavoro, la solita serata, le solite persone
Mi mancano le librerie, la biblioteca, perdersi tra i libri; entrare, guardarli, sceglierne tanti, prenderne solo uno o nessuno: la migliore garanzia di ritorno.
Mi mancano i giardini, i parchi, la panchina, il verde che pretende il suo spazio nel bel mezzo della città.
Mi manca la cena fuori, la scelta infinita del locale, la prenotazione, la recensione finale.
Mi manca il buio della sala, l’affollata intimità del cinema, la Cineteca.
Mi manca il cinema all’aperto, Piazza Maggiore, la certezza che non troverai posto se non vai a occuparlo un’ora prima.
Mi mancano i treni, l’aereo, il pullman, il viaggio verso l’altrove e il ritorno in Calabria.
Mi manca la fila: non quella silenziosa e triste di quest’oggi al supermercato.
Mi manca il sipario che si chiude e si riapre, l’applauso, il grazie collettivo agli attori, alla magia collettiva, alla finzione che sa farsi realtà.
Mi manca la manifestazione, la piazza piena, le bandiere, la passione, l’ideale.
Mi manca la Politica, l’iniziativa, l’attività, il banchetto, la conferenza, l’incontro.
Mi manca la mia Città, perché è lei, lei sola Casa mia.
Mi manca il lungomare di Crotone, quel golfo che è sempre lì ad aspettarmi e ad abbracciarmi.
Mi manca il mare, il mio mare, perché sì, ho bisogno di sentirlo, di beccarmi in faccia la sua brezza o il suo vento forte, di odorarlo, di guardarlo e di confrontarmi con lui.
Mi manca toccare, spintonare, irritare, abbracciare, baciare.
Mi manca la mia Libertà, poter scegliere dove, come e cosa fare, quando mi va e con chi voglio.
Mi manchi tu, mi mancate tutti voi.
Alessandro Milito
(www.bottegascriptamanent.it, anno XIV, n. 150, marzo 2020)
La spazzatura
la fedele amica
della quarantena
Diario ai tempi del Coronavirus:
storie di quotidiana “Resistenza”
Giovedì 19 marzo 2020
Sono le 19,30, sono “uscito da lavoro” e sono tornato a casa. Peccato che questo passaggio sia avvenuto solo ed esclusivamente da un punto di vista simbolico: mi trovo sempre seduto alla mia scrivania, nella mia stanza che ormai è un po’ ufficio, un po’ conference room, un po’ camera da letto. La testa sembra esplodere: a breve si staccherà e decollerà, beata lei che può volare e andare chissà dove. No, io sono bloccato qui e sembra di soffocare. Devo assolutamente uscire, stavolta per davvero.
Ecco subito che entra in gioco una fedele, insospettabile alleata: la spazzatura. Chi l’avrebbe mai detto che ci saremmo battuti per avere il privilegio di uscire e andare a buttarla? Sì, la spazzatura (in bolognese il rusco), è garanzia di libertà. La prendo ed apro la porta di casa. Scendo le scale: no, non esiste che prenda l’ascensore, non voglio rinunciare a nessun passo in più che potrei fare. Arrivo quindi al portone del condominio: una delle tante, incredibili frontiere di questi giorni. Appena lo apro vengo investito da un’aria fresca e gentile, diversa da quella che mi ha accompagnato per tutta la giornata. Forse, per la prima volta, inizio a capire davvero il concetto di “ora d’aria” legato all’universo carcerario.
Questa volta nessun canto, nessuna chitarra a dettar legge e ritmo da un balcone. No: stasera è solo silenzio: surreale, diverso, impaurito. I cassonetti della spazzatura sono esattamente di fronte al mio portone: che fortuna, che comodità! Il gesto anarchico della giornata sarà far finta di non vederli, fare il giro del palazzo, puntare i cassonetti e, solo allora, salutare con rammarico l’amica spazzatura.
Il mio quartiere è una zona residenziale della Bologna bene, niente a che vedere con il popolare, studentesco e terrone San Donato, palcoscenico della mia passata vita universitaria. Questo per dire che no, la mia zona non ha mai brillato per particolare vivacità. L’abitante medio di questi isolati è un bolognese (strano ma vero, esistono anche bolognesi a Bologna), dall’età e dal reddito sensibilmente più elevati dei miei. Eppure mai avrei immaginato di vedere queste case così mute, illuminate ma spente allo stesso tempo. Sembra quasi di passeggiare nella Berlino Est de Le vite degli altri: da un momento all’altro una pattuglia della Stasi, la temibile polizia politica della Repubblica democratica tedesca, potrebbe arrivare, caricarmi su una camionetta e portarmi via. Mi viene da pensare: magari! Almeno la mia giornata acquisirebbe più senso.
Proprio la mancanza di senso è uno dei principali tormenti quotidiani. Perché stiamo scontando questa pena, senza giudice, senza processo? Quando finirà? Il guaio è che è appena cominciata.
Quando risalgo le scale, ritornando nel luogo in cui sconto i miei arresti domiciliari, penso a tutto questo. Strano: chi l’avrebbe mai detto che buttare la spazzatura mi avrebbe portato a un trip mentale simile. Piccoli, particolari e fastidiosi effetti da quarantena. Poi, all’improvviso, il lampo di genio: la “campana” di raccolta del vetro è in fondo alla strada, è più lontana: da domani sotto con le bottiglie.
Alessandro Milito
(www.bottegascriptamanent.it, anno XIV, n. 150, marzo 2020)
Andare a fare la spesa:
un insolito e prezioso
momento di libertà
Diario ai tempi del Coronavirus:
storie di quotidiana “Resistenza”
Mercoledì 18 marzo 2020
Mi è sempre piaciuto andare a fare la spesa. Ho sempre avuto un debole per i supermercati: quegli scaffali pieni, i colori, i rumori ed anche gli odori di quei luoghi così comuni, che si differenziano tra di loro per qualche piccola, marginale differenza.
Ma le spese di questi giorni sono diverse: tutto è diverso. Lo noto sempre di più, ho iniziato a farci più attenzione. Gesti che qualche settimana fa sembravano meccanici, spogli, quotidiani, oggi si presentano sotto una veste tutta nuova. Nel cassetto dei pensieri strani che porto con me ogni giorno, un posto particolare ne occupa uno che fa più o meno così: «Ma quanta roba c’è? Che fortuna che abbiamo». Sì, lo so: è insolito. Eppure molto spesso mi capita di riflettere su che immenso privilegio sia avere tutti quei beni di consumo, banalmente tutto quel cibo, a disposizione. Se ci pensiamo per un istante, è davvero una quantità enorme: la plastica dimostrazione del nostro benessere occidentale.
Per questo fa impressione vedere il supermercato ai tempi dell'#iorestoacasa. Non che sia vuoto, quello no; ma tra uno scaffale e un altro, capita di cadere in qualche buco, creato dal saccheggio (per adesso) educato di tanti di noi. Incredibile constatare, avere davanti agli occhi, l’idea che qualcosa possa essere finita e che non tutto possa essere immediatamente disponibile. Certo, questa idea astratta l’avrò pure avuta in testa, da qualche parte, ma non ho mai pensato che potessi vedere tutto ciò per davvero, concretamente. Come se certe immagini fossero relegate a racconti altrui, «vite che non sono la mia», per citare un grande scrittore.
Ora fare la spesa non mi piace più. Non mi piace la fila, silenziosa e triste, fatta all’esterno del supermercato; ognuno rinchiuso nei suoi pensieri, nel suo personale «quando finirà?». Non mi piace quel gesto lì, diffidente e sospetto, di chi sposta rapidamente il suo carrello non appena capisce che ti stai avvicinando. Non mi piacciono le cassiere o i cassieri, barricati dietro una barriera di plastica. Guanti e mascherine prima che esseri umani. No, non è corretto: cassiere e cassieri mi piacciono: è ciò che sono costretti a fare che non mi piace. Anche loro, senza alcun dubbio, sono i protagonisti di questi giorni, la prima linea del fronte, la prima trincea.
Eppure fare la spesa è uno dei pochissimi momenti di libertà rimasti. Libertà di movimento, per andare al supermercato e per muoversi tra gli scaffali. Libertà di scelta, limitata ai prodotti di cui far scorta. Libertà: comincia a venire fuori, sempre di più, quanto diamine sia fondamentale.
Alessandro Milito
(www.bottegascriptamanent.it, anno XIV, n. 150, marzo 2020)
La videochiamata:
vecchi riti, sapori
del tutto nuovi
Diario ai tempi del Coronavirus:
storie di quotidiana “Resistenza”
Martedì 17 marzo 2020
La videochiamata: non è una novità. Il mio legame con Crotone e i miei genitori si basa anche su videochiamate serali, migliorate negli anni per qualità e nitidezza. Ho videochiamato più volte i miei amici, sparsi qua e là per la penisola, e così hanno fatto loro, con le loro famiglie.
Eppure, quelle di questi giorni non sono le solite videochiamate. No, non lo sono affatto.
Sono giorni di chiassose e confuse videochat di gruppo. Gli schermi dei nostri smartphone, tablet e pc si accendono e, per qualche minuto o per qualche ora, si trasformano in vere e proprie piazze digitali. Anche i più restii e scettici si sono dovuti convertire: l’alternativa è non vedere più quel volto, quella persona. Non vedere amiche e amici, fidanzate e fidanzati, genitori e parenti che magari, solo qualche giorno fa, popolavano il quotidiano di ognuno di noi.
Di fronte a questo dilemma, sono in molti a scaricare forzatamente la nuova, ennesima applicazione o a resuscitare quella dimenticata in memoria, da qualche parte. Ed ecco nuove parole, nuove espressioni, farsi largo con forza, con la vivacità che solo gli affetti sanno regalare: «ci sei?»; «aspetta, non ti vedo»; «perché si vede nero?», «scarica questa così ci vediamo» e tante altre.Tutti insieme, uniti da quell’impacciata intimità che le connessioni incerte riescono a regalare.
Connessi: strano come un aggettivo, così tanto usato e letto in questi anni, riesca ad assumere solamente oggi un sapore nuovo, autentico.
Le tecnologie, che tanto hanno segnato i nostri destini individuali e collettivi nonché la nostra stessa epoca, possono avere un ruolo determinante: fin qui, nulla di strano. La situazione però diventa più complessa e stimolante se ci fermiamo a riflettere su un altro concetto: la tecnologia può essere buona, può essere alleata. Può essere realmente necessaria.
A pensarci bene, non è poco. Non lo è se consideriamo il dibattito critico che va avanti da qualche anno, improntato a un revisionismo e a una maggiore diffidenza verso tutto ciò che è social, interconnesso. Niente a che vedere con l’ingenuo ottimismo tecnologico degli anni Novanta o dei primi anni 2000. Si tratta di una autocritica necessaria e doverosa ma che, in questi giorni, viene bilanciata da un nuovo messaggio, più buono, più rassicurante: forse non tutto è da rivedere, non tutto è da bocciare. Forse questi strumenti, dai quali a volte e legittimamente dobbiamo preservarci, se ben usati possono essere incredibilmente utili e giusti.
Penso a tutto ciò mentre rivedo sullo schermo amici che da troppo tempo non avevo avuto il modo di incontrare. Strano: la quarantena ci avvicina anche a quelle persone che, per vari motivi, non vedevamo da un po’. Del resto c’è poco da stupirsi: come resistere a quell’impulso di condividere con lui, con lei, con gli altri un pezzo di tutto questo? Come resistere a un caloroso, sorridente e digitale «come stai?»
Alessandro Milito
(www.bottegascriptamanent.it, anno XIV, n. 150, marzo 2020)
Quando il confine
tra casa e ufficio
sparisce di colpo
Diario ai tempi del Coronavirus:
storie di quotidiana “Resistenza”
Lunedi 16 marzo 2020
Smart working, lavoro agile: così lo chiamano. Eppure di agile c’è ben poco in questi giorni. Anche la passeggiata mattutina per andare a lavoro sembra un privilegio di un’epoca passata se paragonata agli sterili tre passi che devo fare per spostarmi dal letto alla scrivania: la mia postazione di lavoro. L’idea, il principio, non sono affatto sbagliati, anzi. Certi lavori, certe professioni, non richiedono necessariamente la presenza fisica del lavoratore nei locali aziendali o negli uffici: ciò che si può fare lì si può fare anche a casa. Ne conseguono diversi vantaggi. Si dorme un po’ di più: il tempo che dedicavi per raggiungere il luogo di lavoro può essere utilizzato per spostare la sveglia in avanti; si pranza a casa, con la possibilità e la speranza di poter mangiare meglio, abbandonando sbrigativi tranci di pizza e altre razioni da battaglia. Si resta a casa, si continua nella costruzione delle due parole d’ordine di queste giornate pazze: distanziamento sociale.
Distanziamento sociale significa non potersi rapportare direttamente con i colleghi, significa rinunciare all’intimità di certi momenti che solo la fisicità dell’ufficio riesce a costruire. Ecco il primo degli svantaggi di questo smart working forzato: la dimensione del lavoro si confonde e si perde, entrando in contatto con i confini di casa propria. Viene a mancare la prima dogana del nostro quotidiano: la linea di demarcazione tra ciò che è rifugio e riposo e ciò che è lavoro, fatica e impegno. Ciò significa che è difficile capire quando concretamente si “attacca” e “si stacca” da lavoro: tutto diventa un unico, inconfondibile momento intervallato solo dall’andare a dormire e svegliarsi la mattina dopo.
La giornata prende le sembianze di un tunnel lungo e spoglio: ci si sveglia, si fa colazione, si accende il computer. Ecco quindi la “call” di lavoro e di coordinamento (non sarà meglio dire “chiamata” o “videochiamata”?). Poi la pausa pranzo, sbirciando fuori dalla finestra: ancora quel maledetto cielo azzurrissimo, pare che marzo a Bologna non sia mai stato così bello, pensa un po’. E di nuovo sedia, scrivania, computer.
Oggi non ho partecipato al rito collettivo delle 18,00, non ho letto né commentato il quotidiano bollettino di guerra. Ho ascoltato quelle parole, ormai entrate nel flusso quotidiano di ognuno di noi: “guariti”, “terapia intensiva”, “contagiati”, “deceduti”; ma le ho ascoltate in sottofondo, quasi stupendomi di come potessero rimanere lì in disparte, come se nulla fosse. Mi sto abituando al fatto che "lì fuori" è in corso una battaglia di cui non si vede la fine?
Alessandro Milito
(www.bottegascriptamanent.it, anno XIV, n. 150, marzo 2020)
Tra smart working
e videochiamate,
siamo tutti vicini
Diario ai tempi del Coronavirus:
storie di quotidiana “Resistenza”
Domenica 15 marzo 2020
Finisce questo weekend di quarantena. Guardo un video: in una via Rizzoli deserta una volante della Polizia Municipale annuncia all’altoparlante che «sono vietate le visite a familiari e amici». Domani ricomincerà la settimana lavorativa, con la differenza che questa volta non dovrò tornare in studio ma avrò pochi passi da fare: dal letto alla mia scrivania. Si chiama smart working, ma questa è un’altra storia.
Oggi è stata una giornata sfacciatamente primaverile: un sole e un azzurro arroganti, quasi provocatori, che invitavano a uscire di casa. Io sono uscito di casa, stamattina: avevo una situazione di necessità da risolvere. Dovevo andare a comprare il giornale, piccolo rito sopravvissuto che oggi assume ancora più valore. Le edicole sono state inserite tra le attività commerciali che svolgono un servizio essenziale e, pertanto, devono rimanere aperte. L’edicolante, assieme al farmacista e al cassiere, è una delle figure portanti di queste giornate, un soldato in trincea che, con mascherina e guanti, ti porge il giornale (avendo cura di non toccarti). L’Italia non è la Cina: l’informazione è un bene essenziale e deve continuare a circolare. Questo è un aspetto su cui dovremo riflettere in questi giorni e in futuro. Qualcosa di cui essere, dopotutto e nel profondo, fieri.
Preso il giornale si fa qualche passo all’aria aperta ma, poco dopo, bisogna tornare a casa. L’hashtag del momento è #iorestoacasa, anche il Dpcm del Governo è stato denominato così.
Oggi è una giornata di festa: è il compleanno di mio padre e bisogna ritagliarsi un momento di intimità in qualche modo.
Il primo compleanno festeggiato in quarantena, con una videochiamata e troppi chilometri di distanza. La scena è dolce e perfettamente chiara nella sua semplicità: le vie dell’affetto sono infinite. Rimane sospesa una domanda, tra una candelina soffiata e un dolce che io non ho potuto mangiare: quando ci rivediamo?
Poi alle 18,00 un altro appuntamento, un “classico” di queste giornate: il comunicato di Angelo Borrelli della Protezione Civile, accompagnato da Silvio Brusaferro dell’Istituto superiore di Sanità. Una coppia insolita ma efficace nella sua terribile routine. I due annunciano il bollettino di guerra contro il Nemico. I dati non sono rassicuranti, è ancora presto per capire se le misure adottate hanno avuto l’efficacia che tutti speriamo. I loro volti sono freddi e stanchi, le loro parole misurate e scientifiche: l’emotività non è ammessa. Eppure, in qualche modo perverso, quasi ci si affeziona a questo rito trasparente e macabro.
Mentre dalla tv è tutto un «modellare la curva» e «rischiamo di creare scenari particolarmente critici», dalla finestra si sente cantare. Sì, qualcuno sta suonando: possibile che sia Rino Gaetano?
E quindi, con Borrelli che legge l’aumento dei ricoverati in terapia intensiva, ci si sposta un attimo sul balcone per avere la conferma. Ma il cielo è sempre più blu qualcuno canta; una mamma fa ballare il suo bimbo su un balconcino poco distante.
Sono immagini agrodolci, a loro modo dignitose e commoventi. Sono le immagini di questi giorni che, ognuno di noi, in qualche modo, sta registrando.
Alessandro Milito
(www.bottegascriptamanent.it, anno XIV, n. 150, marzo 2020)
Non si può fare
finta di nulla.
Scrivere ci aiuta
Diario ai tempi del Coronavirus:
storie di quotidiana “Resistenza”
Sabato 14 marzo 2020
Sono estroverso, sono socievole, mi piace la gente.
Sono quello che ti dà una pacca sulla spalla di troppo.
Sono uno che ti parla, anche da vicino, scuotendoti.
Ho un tono di voce più elevato del dovuto.
Mi piacciono i rumori della città, la folla che si riversa sui viali e nei locali.
Adoro le biblioteche, le librerie, i cinema e i teatri.
Vivo a Bologna, sono nato a Crotone.
Ritorno spesso, o quando è possibile, in pullman, in aereo, se c’è.
Sono uno che sa apprezzare l’intima solitudine, dalla quale però deve uscirne, dopo un po’.
Sono uno che dopo una giornata in casa si sente in apnea, con un cerchio alla testa.
Sono una vittima, a modo mio, nel mio personalissimo modo, di quello che accade qui, adesso: marzo 2020.
Proprio ora, in questo momento e per chissà quanto.
Sì, è vero: se ci pensi troppo fa male; ma sei costretto.
No: è impossibile far finta di nulla, la senti, anche se non vuoi, la cosa che sta succedendo e i suoi effetti, dentro e fuori di te.
Sì: bisogna pensarci, a giuste dosi.
E bisogna scriverne. Dobbiamo trascrivere, per quanto possibile, le nostre sensazioni, le nostre paure.
Tutto ciò che stiamo provando e che proveremo in questi giorni. Ognuno di noi può lasciare traccia di queste giornate raccontando la sua storia personale, un piccolo ma importante mattoncino di quel muro collettivo che stiamo cercando di costruire contro il Nemico invisibile. Ognuno può raccontare una storia, la sua; trascriverla, conservarla e poi ricordarla e rileggerla, un giorno.
Io giovedì sera tornavo a casa da lavoro. Una passeggiata non tanto lunga né spiacevole: venti minuti di camminata dai portici del centro di Bologna verso i viali, un po’ più in là. Una passeggiata che di solito avrei fatto senza pensarci troppo, sempre che non avessi deciso di prendere l’autobus: tre fermate, meno di dieci minuti. Non questa volta. Questa volta è stato diverso. Una città difforme, spenta, senz’anima, ogni passo accompagnato da un’angoscia sottile e cattiva, come se fosse proprio l’assenza di vita e rumore a opprimere e soffocare. E poi i viali, quelle luci blu, quegli uomini in divisa e mascherina. Spiegare perché ci si sta muovendo: strano, vero? Abbiamo così nelle vene la Libertà, la giusta arroganza di poter fare ciò che ci pare e di andare dove meglio crediamo, che ci siamo dimenticati di come questa possa essere limitata, violata.
E così, da un giorno all’altro, devi spiegare dove stai andando e perché. Le opzioni non sono molte: a) comprovate esigenze lavorative; b) situazioni di necessità; c) motivi di salute; d) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. C’è un mondo al di fuori di queste caselle, costruite con un burocratese incerto, che suscita una triste diffidenza.
E poi il supermercato: la fila opprimente per entrarci, gli scaffali tristi, sui quali si sono già posati occhi preoccupati e svelti; le mascherine, la cortesia egoista di chi vuole e deve starti lontano. E poi di nuovo, lì fuori, altre luci: stavolta la Polizia Municipale. E il rientro a casa, le mani da lavare (le avrai lavate bene?).
Il giorno dopo è diverso e porta altre sensazioni da decifrare. Pensieri ed emozioni nuove, sì, ma accompagnate da veri e propri nuovi riti: il comunicato della Protezione Civile delle 18,00, il nostro bollettino di guerra; la conferenza di Conte, quando c’è; le videochiamate, mai così tante. La tecnologia, i social, Whatsapp accompagnati in questi anni da un crescente sentimento di (legittima) diffidenza, si riscoprono mezzi utili: possiamo farne un buon uso e rivalutarli il giusto.
Poi eccolo lì, il gesto che non ti aspetti e che ti riscalda col suo rumore gentile: qualcuno suona. Sì, esatto, qualcuno ha preso un clarinetto e si è messo alla finestra e sta suonando. Non è solo: un’altra finestra, qualcuno con un flauto. Un balcone: c’è un ragazzo con una tromba. E cos’è questo rumore? Davvero qualcuno sta usando pentole e cucchiai per unirsi all’orchestra? E cosa sono queste parole? Davvero è l’inno italiano? Davvero è Bella ciao, Romagna mia, O Sole mio, sono davvero applausi questi? Stiamo cantando tutti insieme dai balconi, ci stiamo aggregando senza che il Nemico possa farci del male?
Sì, è esattamente così. E noi non siamo fatti per stare soli. Siamo animali sociali, stiamo vivendo questa cosa, tutti insieme.
Ne verremo fuori ma, per ora, resistiamo. E scriviamo: ci sarà molto da raccontare.
Alessandro Milito
(www.bottegascriptamanent.it, anno XIV, n. 150, marzo 2020)