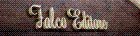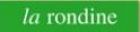Società di prodotti editoriali, comunicazione e giornalismo.
Iscrizione al Roc n. 21969.
Registrazione presso il Tribunale di Cosenza
n. 817 del 22/11/2007.
Issn 2035-7370.
Direttore editoriale: Mario Saccomanno
A. XVIII, n. 200, maggio 2024
 L’amore in tempi di guerra:
L’amore in tempi di guerra:una pubblicazione in anteprima
di Mariangela Monaco
L’ingaggio: un romanzo breve denso di sentimenti
in una Polonia devastata da conflitti politici e razziali
Sai Karl,
mi sento già un po’ meglio scrivendoti queste righe prima della mia inevitabile dipartita. Stamane ho avuto un accesso di tosse convulsa, mi dimenavo ed annaspavo, stavo diventando paonazzo e, nella tragicità dell’evento, qualcuno vedendomi avrebbe potuto sganasciarsi dal ridere, ma, credimi, non l’avrei biasimato; io stesso mi sentivo ridicolo a rincorrere brevi sprazzi di vita quando avrei potuto facilmente porre fine a questo calvario dopo la diagnosi infausta.
Sapessi che trambusto stamattina, le infermiere erano già impazzite per conto loro ed i dottori sbraitavano a destra ed a sinistra: «Presto, perdio, ha un altro attacco!». Ossigeno, iniezioni, mi hanno rigirato come un calzino mentre con gli occhi sgranati distinguevo con orrore i miei rantoli profondi e gutturali che echeggiavano nella stanza.
Ieri ho mandato a chiamare il mio notaio, sai, per il testamento, anche se, come ben potrai immaginare, non lascio granché: la mia modesta abitazione con i balconi rossi nella periferia di Varsavia, ormai malandata e fatiscente, e la mia collezione di lettere spedite dai nostri soldati ai loro parenti durante la Seconda guerra mondiale, acquistate parecchi anni or sono in una polverosa asta di provincia; per me hanno avuto un grande valore affettivo e la prima missiva è quella di Ivan, nostro fratello sepolto nel cimitero di Powazki.
Vorrei che fossi tu a conservarle per me, sperando che questo ti possa gratificare ed al tempo stesso anche far piacere.
Dicevi sempre: «chi ha paura di vivere ha paura anche di morire», ma, con questa mia missiva, desidero, tra le altre cose, farti sapere che io non ho paura di morire, Karl, ma ho avuto invece, credimi, paura di vivere: la guerra, la fame, gli stenti e la solita, quotidiana incertezza per il domani che mi schiacciava ed annientava e che veniva rimossa di continuo con la nostra voglia di svago.
Sai chi ricordo di quei tempi con nitidezza? Una ragazza bionda ed esile di nome Elsa, che abbelliva il suo unico paio di scarpe arrotolando le carte delle caramelle, ricavandone una specie di treccia colorata che poi posizionava sopra la fibbia per farle sembrare da sera. E l’inganno riusciva, se non si guardavano troppo da vicino.
Quando ho conosciuto Sara, il conflitto era appena terminato ed il desiderio di ricominciare era nell’aria, un paese da ricostruire, la Polonia a terra e macerie ovunque.
I tedeschi se n’erano andati dopo distruzioni, incendi e saccheggi. Interi quartieri erano stati inceneriti da quadre speciali di lanciafiamme, il ghetto era stato raso al suolo per lasciare posto ad una radura sinistra. Serpeggiava il malumore ed una preoccupazione profonda segnava ciò che rimaneva degli abitanti.
Lungo le strade dissestate non c’era voglia di parlare, ci si incontrava, ci si scrutava, una veloce stretta di mano dopo qualche parola scambiata a fatica e poi ognuno tornava alle sue magagne, sgattaiolando tra quelle che erano un tempo le vie austere ed illuminate di Varsavia. Il rumore dei passi si accompagnava ovunque, come un rintocco sinistro, al rotolare dei sassi dalle macerie. Ruderi e mura bombardate conferivano alla città un’aria spettrale.
Nel gennaio del ’45, quando i sovietici entrarono in Varsavia, l’imponente termometro di piazza del castello, rimasto inspiegabilmente illeso dopo i bombardamenti, segnava meno venti gradi. Una corrente polare proveniente dal Mar Baltico aveva soffiato incessantemente per settimane costringendomi a mettere dei fogli di giornale sotto il cappotto per cercare un maggior riparo. Ma il freddo era pungente, attanagliava. Con il bavero del paltò alzato e le mani affondate nelle tasche osservavo i soldati sudici e cenciosi dell’Armata Rossa entrare in quello che restava di Varsavia: detriti ovunque, fame e sofferenza.
Davanti a me c’era Elsa, avrei riconosciuto i suoi capelli ovunque. Erano sciupati e sfibrati dall’incuria. Quando si girò, senza alcuna allegria riuscii a scorgere nel suo sguardo, una enorme tristezza mista a preoccupazione. I suoi lineamenti aristocratici non avrebbero potuto trovare una peggiore collocazione nel misero scenario che ci faceva da sfondo. Ci osservammo per qualche istante. I nostri miseri indumenti, che ci tenevamo stretti, ricadevano miseramente sui nostri magri corpi messi a dura prova dal gelo e dalla fame.
Le sorrisi teneramente, aveva un’aria indifesa, così diversa e lontana da quella allegra ragazza intenta ad abbellire le scarpe da ballo. Aveva cercato di ricomporsi sotto il mio sguardo attento e per un istante, prima di salutarmi, i suoi occhi sembravano aver ritrovato la solita vivacità. Un bottone, lasco da alcuni giorni, mi cadde sulla scarpa e lei lo raccolse con solerzia. Un semplice gesto che mi aveva aperto il cuore.
Quel cappotto sgualcito ed i miei pochi indumenti… Ricordo i miei sommari rammendi serali con fili simili ma visibilmente diversi. Le tasche si bucavano continuamente in punti diversi sotto il peso delle chiavi ed il resto. Cercavo di tenermi stretto quei pochi indumenti che possedevo ripiegandoli con cura ogni sera vicino al letto. Maglie dai bordi lisi, bucherellate in vari punti, che indossavo una sopra l’altra, calzini consunti ed una sciarpa verde che finii per attorcigliare al collo, incrociandola sul davanti, anche mentre dormivo.
Ti ho mai detto, Karl, che ho salvato la vita ad un ebreo? Non un fine letterato, né un giudice dall’impeccabile reputazione o un grande fisico, ma un semplice sarto di nome Stephan, d’indole accomodante e servizievole, che confezionava camicie di seta con abile maestria, tanto da meritare un particolare riconoscimento come “ago d’oro” di Varsavia. Ne cucì una per me, ricordi?
Alla fine della guerra, salutandoci, mi ringraziò, in lacrime, baciandomi ripetutamente le mani con vigore; i nazisti avevano fatto irruzione un paio di volte nella mia abitazione ma non erano mai riusciti a trovarlo, ben nascosto com’era dentro una piccola botola in soffitta. Appena sentivamo le SS salire le scale, Stephan si precipitava di filato in camera per rinchiudersi rapidamente in quello spazio angusto, appena sufficiente ad accoglierlo.
Probabilmente i soldati non pensarono mai di guardarci perché consideravano quel buco troppo stretto ma lui era piccolo di statura con ossa minute e ci si infilava abbastanza agilmente con l’aiuto di una scala che prontamente nascondevo, prima di aprire loro la porta; sapevo bene che aiutando Stephan rischiavo di finire in un campo di concentramento. Le leggi naziste non perdonavano: se un ariano avesse aiutato un ebreo lo sarebbe diventato egli stesso. Una equazione semplice ma allo stesso tempo terribile e spietata.
Prima di Stephan in quel buco ci tenevo tre barattoli di vernici ed un pennello messi lì per non rischiare di urtarli accidentalmente.
L’ultima volta i militari si presentarono in due. Un giovane ufficiale alto e biondo in impeccabile uniforme che accompagnava il suo comandante riconoscibile dal caratteristico anello stilizzato portato all’anulare destro. Avevo letto qualcosa su di lui, teneva dei corsi riguardanti la storia, i compiti e la preparazione per il giuramento alle SS. Dopo aver appreso, ponendomi alcune domande, che ero l’unico abitante della casa, iniziò a gironzolare per l’appartamento, lanciando rapide occhiate torve e diffidenti. Passeggiava rigido, distendendo forzatamente le gambe e facendo echeggiare sul pavimento il tacco degli stivali in pelle.
Poi si fermò, colpito da qualcosa e piegò la testa nel tentativo di cercare la giusta inclinazione.
«Apra quella valigia», mi urlò in faccia.
Mi affrettai ad eseguire l’ordine percependo la sua impazienza nel vedermi alle prese con la serratura bloccata. Tossì, e si schiarì la gola, iniziando a colpire imperiosamente e con regolarità la sua mano con i guanti dondolandosi avanti ed indietro sui tacchi fissandomi malevolo. Immagino sospettasse l’esistenza di un doppio fondo nella valigia. L’afferrò, lanciandola al centro della stanza, scambiando con il giovane ufficiale uno sguardo di intesa. Prese subito a rovesciare rumorosamente il contenuto di ogni cassetto. Vidi le mie cose, se pur non di valore, cadere a terra ammucchiate. Sbiancai e feci un passo indietro di fronte a tanta violenza. Stephan mi confessò, in seguito, che anche lui nella botola aveva avuto un sussulto e che era riuscito ad intravedere, attraverso una fessura, le mani del comandante strette dietro la schiena mentre supervisionava, approvando con dei cenni del capo, le gesta dell’ufficiale. Mi confessò anche che, ad un certo punto, gli era venuto un formicolio alla gamba destra e che nemmeno un veloce massaggio, approfittando della loro distrazione, gli aveva giovato granché.
Poi il comandante si avvicinò cauto alla scrivania – sai, quella in mogano appartenuta a papà – e si fermò proprio lì davanti, allineando gli stivali. Sebbene datata e tarlata aveva il pregio di spaziosi cassetti laterali. Ogni volta che mi ci sedevo, mi sembrava quasi di vederlo, a sgridarmi se tornavo a casa, trafelato, sporco e sudato dopo una partita di pallone. Vidi i miei appunti, riguardanti alcune versioni di latino e testi di greco, volare in aria; baccano, rabbia e gli occhi furenti del comandante puntati su di me.
«Che cosa sono?» mi chiese imbestialito con una manciata di fogli in mano.
Mi profusi in spiegazioni balbe sulla necessità di tenermi allenato traducendo testi classici ma questo non bastò ad evitare che il mio lavoro di settimane andasse in pezzi. Stavo apportando delle modifiche ad una traduzione da Catullo. Tutto perduto in pochi istanti. Se ne andarono via urlando, lasciando la porta spalancata, con me attonito ad osservarli. Per il resto del giorno rimasi accanto alla stufa, scosso da violenti brividi. Era quello il mio modo di reagire a situazioni in cui ero costretto a subire e basta.
«Ancora un po’ e sarebbe servito un argano per tirarmi giù» mi confidò sollevato dopo essere uscito dalla botola. Stephan…
Se ripenso al suo sorriso sdentato o a quando si massaggiava la fronte, in silenzio ed in disparte, guardando la foto dei suoi cari… Chissà cosa pensava?
Forse si cullava nell’illusione di sapere i suoi familiari al sicuro, magari in un rifugio. Non mi sono mai spinto a chiederglielo, sebbene percepissi la sua speranza affievolirsi ogni giorno di più, sapendoli in mano ai tedeschi. Con il capo chino quei lunghi silenzi scandivano i minuti e le ore al posto delle lancette di un orologio, come fossero rigidi signori compassati, vestiti della sua malinconica tristezza.
Ricordo i nostri brevi dialoghi bisbigliati, le magre cene consumate in silenzio, la sua riconoscenza, che leggevo costantemente in quegli occhi tristi. Da bravo sarto occupava le giornate facendo rammendi di precisione; riuscì anche a ricavare abilmente una giacca di lana da una vecchia coperta utilizzando le parti meno consunte. Con le parti lise restanti ricavò due paia di pantofole.
Un giorno, terminata la guerra, mi confidò «Sai la prima cosa che voglio fare qual è? Correre su un prato fuori città ed urlare così tanto da perdere la voce».
Sorrisi, augurandogli ogni bene. Molto tempo dopo venni a sapere che aveva aperto una piccola sartoria a Cracovia e che aveva avuto un figlio da una deportata russa che gli restò fedele fino alla sua morte.
Sai bene, Karl, come in passato abbia più volte cercato di esternarti le mie preoccupazioni sulla possibile ascesa al potere di Hitler ma se inizialmente mi avevi ascoltato o avevi finto di farlo in maniera piuttosto controllata, rivolgendomi sorrisi tolleranti, in seguito e non di rado, avevi preso a sbuffare spazientito ritenendo i miei ragionamenti contorti ed allarmistici. Non solo contestavi fieramente i miei timori sul futuro della Germania, sotto la guida di un esaltato, ma le tue parole erano pregne di quella arroganza e sufficienza che avevo sempre creduto non appartenerti. Così, un po’ alla volta, finii con il confidarmi sempre meno, tenendomi tutto dentro. Dopo ogni notiziario ragionavo sull’accaduto, interrogandomi in silenzio e quando ti vedevo lì, chino a lucidare il tuo distintivo del Circolo simpatizzante Nazional-socialista, mi chiedevo come ti procurassi i soldi per quelle cene sempre più frequenti o per quelle scarpe robuste e calde. Le tue risposte insofferenti e sempre più evasive, ma sempre meno credibili, mi convinsero che qualcosa di poco pulito stesse succedendo; finché un giorno non ti vidi più.
L’armadio vuoto e la camera liberata da tutte le tue cose mi lasciarono attonito sulla soglia. Mi avvicinai alla finestra e guardai fuori: la neve scendeva implacabile ed i passanti, con le ciglia imperlate, avanzavano a fatica per la ridotta visibilità. Ogni cosa era ricoperta da un grazioso mantello bianco che s’ispessiva e si consolidava; ogni discussione sulla razza sembrava così lontana, di un altro mondo o dimensione che per un momento mi dimenticai che tu non eri più lì con me. In piedi con la mano appoggiata sul davanzale, scrutavo affascinato i fiocchi di neve scendere con eleganza indisturbati. Era come se la neve cercasse di lavare l’amarezza, rallegrando il mio cuore intristito.
Le discriminazioni razziali crebbero incessantemente fino a quando, dopo la Notte dei cristalli, l’antisemitismo esplose ed i giudei, ritenuti gli agenti patogeni responsabili di tutti i mali della Germania, venivano scovati come scarafaggi in nome del mito della razza.
Credo di non raccontarti nulla di nuovo, vero, Karl?
Ascoltavo il fuhrer e guardavo con incredulità le folle galvanizzate pensando incredulo «Non daranno mica ascolta a questo qua?».
Purtroppo non solo è stato ascoltato, ma anche obbedito concedendogli quella cieca fiducia che solo grandi uomini meritano.
Hitler, agitandosi tutto, urlava al microfono dal suo pulpito «Il fatto che mi abbiate trovato fra milioni di persone è un miracolo. Il fatto che io abbia trovato voi è la fortuna della Germania. L’ebreo è sempre e solo un parassita nel corpo delle altre nazioni».
«Cristo Santo!» pensavo sbigottito.
***
Con Sara ci fu subito intesa. Mi capiva, nonostante fossi poco loquace e spesso nervoso; la voglia di stare insieme era insopprimibile e al contempo assolutamente sconsiderata ma eravamo giovani e tutto era splendido. Anche il dopoguerra, nonostante la drammatica situazione.
Nel nostro angusto appartamento in affitto, in un palazzo antico nel quartiere Praga, uno dei pochi che non fosse stato distrutto dalla furia nazista, faticavamo a sostentarci nonostante lavorassimo entrambi, anche se occasionalmente.
Lei svolgeva un lavoro piuttosto insolito, presso una ditta di carburanti: doveva controllare i libri contabili redatti dalla segretaria del principale, che sbagliava grossolanamente i conteggi ma veniva puntualmente perdonata grazie alle sue fantasiose prestazioni nella camera da letto del capo. Una volta la vidi, non era nemmeno un granché, con quei suoi cappellini assurdi e variopinti che mi ricordavano più un’anziana zitella conciata a festa, che una seduttrice.
Sara partiva da casa a piedi, di solito all’imbrunire, e rimaneva in ufficio da sola lavorando alacremente finché non aveva terminato di mettere in ordine tutti i documenti contabili. Annotava scrupolosamente gli impegni del giorno dopo e preparava l’elenco delle telefonate che la segretaria ufficiale, per così dire, avrebbe dovuto fare.
Si adattava, Karl, aveva forse altra scelta? Non riusciva a trovare altro nonostante la sua eccellente preparazione ottenuta presso la” Scuola di contabilità e bilancio” di Varsavia.
E veniamo a me ed alla mia laurea in lettere classiche, presa a pieni voti, che si rivelò in quel periodo quasi inservibile se non per le occasionali ripetizioni di greco date al figlio unico e viziato di una famiglia altolocata, che in seguito si trasferì.
A sera tardi, dopo aver consumato la cena che avevo provveduto a tenerle in caldo, osservavo con tenerezza Sara seduta alla luce fioca di una candela, scrivere e riscrivere conti su conti che puntualmente non tornavano. La vedevo sfiorire ed invecchiare giorno dopo giorno, logorata da pensieri e preoccupazioni e forse dal rimpianto di avere lasciatole comodità della casa paterna.
Fu in quel periodo che mi accadde quello che sto per raccontarti e ti prego fin d’ora di non considerare questa storia il vaneggiamento di un malato terminale o peggio ancora, i deliri di un allucinato perché mi ferirebbe.
Posso anticiparti che ho trascorso gli anni seguenti ad interrogarmi su quanto avessi visto e chiedendomi con chi avrei potuto confidarmi senza rischiare di essere deriso dal mio interlocutore; così scelsi il silenzio, almeno fino ad oggi, e forse ho fatto bene.
Ebbene, avevo appena ceduto due zloty all’edicolante di piazza Krasinski che stavo leggendo i titoli a caratteri cubitali della prima pagina riguardanti l’esproprio a negozianti ebrei di attività passate agli esercenti polacchi, quando un frustino mi sfiorò; sentii l’alito del cavallo, scudisciato senza risparmio dal vetturino e feci un balzo indietro.
La gente mi guardava. Per darmi un contegno fissai una locandina di colore giallo in bella mostra su un treppiede, che annunciava l’imminente arrivo in città di un regista in cerca di comparse per un film intitolato “Le forbici della contessa”.
La trama era incentrata su una contessa, altera e distaccata, che rimane commossa dalla dedizione e l’impegno profusi dalla sua sarta personale. Decide così, come riconoscimento per i suoi servigi, di regalarle un paio di forbici, tempestate di rubini e brillanti, che in seguito la sarta venderà per garantire un matrimonio sfarzoso alla figlia petulante.
La sceneggiatura era senz’altro frivola, una pellicola d’altri tempi, senza pretese, che puntava essenzialmente a distrarre ed a divertire. Dopo lunghi anni di inattività cinematografica, per via della guerra, bisognava dare nuovo slancio al settore ed il film in questione, fu uno dei primi, se non addirittura il primo, a non avere toni propagandistici in favore del nazismo.
Parlai a Sara di questa opportunità, lei sorrise, tra il divertito ed il sorpreso, incitandomi.
«Dai, che vengo a vederti!». Scoppiai a ridere. Non so perché, Karl, ma risi fragorosamente forse pensando che qualcosa di nuovo e di interessante stava succedendo nella mia vita, sempre uguale e piatta.
Chissà, magari il regista avrebbe potuto, tramite un giro di amicizie, indirizzarmi a chi sarebbe stato in grado di offrirmi un’occupazione stabile dopo le riprese. Con un po’ di fortuna avrei potuto permettermi un appartamento più spazioso per me e Sara.
Così il giorno dopo, sfoderando una spavalderia che non mi apparteneva ed un linguaggio forbito, ottenni facilmente il ruolo di comparsa. Ne fui così felice mentre percorrevo la strada verso casa pensando che avrei potuto finalmente fare una spesa decente.
Il regista era un omino gracile, con i baffi, basso di statura e forse per questo sentiva il bisogno di imporsi sugli altri agitandosi di continuo. Non con la protagonista però. Con lei era ossequioso ed accomodante e la disparità di trattamento era così evidente che saltava all’occhio immediatamente.
La prima volta che vidi Ellen Hutter, la protagonista del film nei panni della contessa Matrioska rimasi colpito dalla sua semplicità: fisico armonioso, capelli biondo-cenere portati sciolti sulle spalle, lineamenti regolari ed un modo affabile di rapportarsi agli altri.
Mi soffermai a lungo sui suoi occhi vivi che avevano qualcosa d’insolito, difficile da individuare; poi un giorno, mentre discuteva con il regista alcune scene, mi avvicinai con cautela, scrutandola meglio e, riuscii a notare che l’iride azzurra era circondata da un anello blu mare, che conferiva allo sguardo una particolare intensità.
Mi tenni a distanza ma nemmeno la sorpresa di vedere Filip offrirmi una delle sue sigarette, introvabili se non al mercato nero, riuscì a distrarmi; coprii la fiamma del fiammifero con la mano ed inspiravo fino a far diventare la punta della sigaretta incandescente senza distogliere lo sguardo da Ellen. Si muoveva con grazia ed ascoltava attenta replicando solo di tanto in tanto alle istruzioni del regista che, al contrario, si dimenava in frenetici gesticolii. Poi, prendendola sotto braccio, la condusse con entusiasmo nei camerini. Li aprì tutti e si fermò davanti ad uno in particolare, quello che sarebbe diventato il suo.
Quando, infine, approfittando di una pausa, mi presentai fui certo di scorgere un’ombra fugace sul suo viso quando pronunciai il mio cognome. Nonostante fosse piuttosto diffuso a Varsavia e non ci fosse somiglianza tra di noi, Karl, sono sicuro che c’inquadrò subito. Naturalmente allora non sapevo nulla.
Strinsi conversazione con lei usando come pretesto il mio fortuito ingaggio come semplice comparsa. I dubbi sul mio talento recitativo m’impedivano di aspirare a ruoli più impegnativi e, quando glielo confidai, sussurrandolo, lei sorrise imbarazzata non aspettandosi, una tale dichiarazione. Le piaceva stare ad ascoltarmi perché dai miei modi trasparivano un sincero rispetto e stima nei suoi confronti.
Ellen agli studi cinematografici era sempre puntuale, indossava abiti ordinari e talvolta perfino trasandati. Salutava tutti con un cenno della mano e poi si chiudeva frettolosamente in camerino, dove la truccatrice e la sarta la aspettavano per compiere la trasformazione. Abiti d’epoca tempestati di pietre colorate, presi a noleggio, erano appesi nei suoi grandi armadi.
Ciò che mi colpiva di più di lei era la sua assoluta rapidità nel memorizzare le battute del copione, anche quelle cambiate dal regista qualche minuto prima di girare.
I suoi “Va bene, sono pronta. Giriamo!” pronunciati con sicurezza e padronanza non li ho mai dimenticati. Il tono fermo ma cortese della sua voce è ancora vivo nella mia memoria.
Quando il regista parlava con me, mi dava sempre indicazioni frettolose: «Lei, signore con la giacca, si metta lì», oppure, «Adesso lei, per cortesia, vada vicino al suo collega e finga di conversare ma, mi raccomando, non gesticoli troppo. Deve fare da sfondo, non catturare l’attenzione».
Ricordo di aver pensato che uno dei vantaggi di aver fatto la comparsa è avere avuto l’occasione di indossare dei vestiti che mi restituivano la dignità di uomo. Quel tessuto così morbido… a volte mi ritrovavo ad accarezzarlo inconsapevolmente.
Dopo una settimana, il regista decise di farmi dire qualche battuta, forse perché qualcuno gli aveva riferito che ero laureato in Lettere. Dovevo interpretare uno degli invitati al Gran Galà in onore della contessa.
Mi diedero uno smoking nero della mia taglia, di buona fattura, e si raccomandarono di non dimenticarmi di mettere un fazzoletto di seta bianco nel taschino: a loro dire un gentiluomo si riconosce da come è piegato ed inserito con cura.
La scena si girava in una villa di campagna, poco fuori Varsavia; dovevo salire con nonchalance i tre gradini davanti all’ingresso, avvicinarmi alla contessa che mi attendeva sulla soglia e dirle: «Mia cara, la trovo sempre più giovane. Qual è il suo segreto?». Le parole dovevano essere pronunciate con lentezza e la “erre” doveva essere leggermente biascicata in modo da riprodurre il modo di parlare di un dandy.
Con l’aiuto di Sara provai e riprovai, ma fui un disastro fin dall’inizio. Mi emozionavo, scordavo la battuta e poi non mi muovevo nel modo giusto.
«Mia cara, qual è il suo segreto? La trovo sempre più giovane!» recitavo fiero.
«No! Hai invertito di nuovo!», mi riprendeva lei.
Uscivo dalla porta, Sara fingeva di essere la contessa; rientravo, mi avvicinavo, ma sbagliavo sempre qualcosa ed anche se facevo tutto giusto la pronuncia della “erre” non era biascicata. Sara mi scrutava pensierosa, massaggiandosi le tempie. Non riusciva a capacitarsi del perché non riuscissi ad interpretare decentemente quella scena.
«Vuoi che ci scambiamo il ruolo per un momento? Tu interpreti la contessa ed io l’invitato?»
«No, vedrai che domani, dopo una buona dormita, ce la farò» risposi in balia del più cupo avvilimento.
Inutile dirti che quella notte la trascorsi in bianco guardando il soffitto e ripetendomi di continuo quella battuta. Mi rigiravo nel letto, rimpiangendo la mia disinvoltura nelle recite di Natale, quando da bambino ricevevo calorosi applausi dai miei genitori. “Come diavolo ci riuscivo”, mi chiedevo preoccupato.
L’indomani ero lì, davanti ai gradini della villa, e di fronte ad Ellen pronto a girare la scena. L’aria frizzante e lo smoking leggero mi stavano facendo rimpiangere la coperta di lana che avevo tanto strapazzato la notte prima, alla ricerca di qualche ora di sonno. Quel sole, di un autunno inoltrato, non riusciva più a scaldare. In molti battevano i piedi tutti infagottati.
«Ciak, si gira» annunciò all’improvviso il regista.
Cercai di tenere sotto controllo la tensione e pronunciai quella frase che era ormai diventata un’ossessione. Poi mi avvicinai per stringere a mano alla contessa che me la stava porgendo con naturalezza.
Karl mi percorse un brivido. Quella mano era morbida come il velluto ma così fredda da ricordare il ghiaccio.
Avevo provato la stessa sensazione l’anno prima, quando io ed alcuni amici ci eravamo messi intesta di costruire un pupazzo dopo un’abbondante nevicata, ma avevo dimenticato i guanti e volendo comunque dare il mio contributo, maneggiai neve per un’ora senza alcuna protezione.
Il giorno seguente, decisi di prestare la massima attenzione ad ogni discorso su Ellen, non tanto per soddisfare la mia curiosità, anche se in parte era vero, ma perché sentivo che quella ragazza nascondeva qualcosa oltre al fatto, lo ammetto, di essermi sentito molto attratto da lei fin da subito.
Mi accorsi che non la vedevo mai mangiare, così pensai di portarle dei biscotti, certamente non buoni come quelli che si vendono adesso. Nel dopoguerra, in una Varsavia affamata, i panifici erano gli unici negozi attivi ed i biscotti in questione erano preparati con l’avena. Non erano male e ricordo che erano troppo costosi per le mie esigue finanze.
Entrai negli studi salutando affabilmente, con il vassoio in mano, invitando tutti ad assaggiarli; mi avvicinai ad Ellen ma lei con uno sguardo seccato fece un cenno di rifiuto con la mano, allontanandosi. Questo non era da lei. Era pallida e nervosa, come se avesse discusso animatamente con qualcuno e ne portasse visibilmente i segni sul volto.
L’indomani Ellen arrivò puntuale, come al solito. Salutò imboccando spedita il corridoio verso il camerino. Per un po’, la seguii con la coda dell’occhio e poi mi decisi ad avvicinarmi alla sua porta con l’intenzione di chiederle come stava, il patetico interessamento di una comparsa verso un’attrice. Mi fermai però ad una certa distanza per non destare sospetti e decisi di aspettarla rimanendo appoggiato allo stipite della porta proprio davanti alla grande finestra degli studi.
Nell’attesa, il pensiero andò a Sara che quella mattina mi aveva annunciato di avere un ritardo di circa una settimana e di esserne preoccupata. Riuscivamo a malapena a sostentarci ed un figlio avrebbe complicato tutto.
Scoraggiato da una improvvisa presa di coscienza della mia mancanza di
intraprendenza che mi avrebbe, quasi di certo, condotto ad un goffo insuccesso, preferii unirmi agli altri membri del cast impegnati a ripassare le battute, a chiacchierare o a studiarsi il calendario delle riprese.
Passai vicino a Jacob, il giocherellone del gruppo, che stava raccontando una barzelletta con il chiaro intento di ridicolizzare l’“Heil Hitler”: «Due amici entrano in una birreria ed uno dei due, rivolgendosi al barista gli chiede perentorio Drei Litern alzando la mano chiudendo le dita sul palmo, in modo che il numero tre fosse chiaro». Davvero incredibile Jacob, snocciolava le barzellette come le preghiere di un rosario. Un’altra ancora recitava «Hitler visita un manicomio, e tutti i pazienti lo accolgono con il bravo saluto tedesco tranne uno. Allora Hitler gli si avvicina e gli chiede “Perché tu non fai il saluto come tutti gli altri?” E quello di rimando “Mio fuhrer, perché io sono l’infermiere, non sono mica matto!”». Jacob… Ho sempre pensato che dovesse fare il comico professionista e non il maggiordomo compassato della contessa.
Ricordo che stavo ancora ridendo, quando vidi Ellen ondeggiarmi davanti con una larga gonna di velluto color smeraldo dai ricami in oro ed attraversare lo studio diretta verso il regista che la aspettava per discutere alcune scene. Si muoveva con impaccio per la veste ingombrante attenta a non urtare nessuno ma non si accorse di avvicinarsi troppo ad una caraffa d’acqua che cadde producendo un tonfo chiassoso andando in frantumi. Lo stupore subitaneo che apparve sul suo viso la rendeva adorabile ai miei occhi soprattutto quando si profuse in sincere scuse cercando, di raccogliere i cocci e tamponare con un panno il vestito bagnato. La sua voce melodiosa rotta dall’imbarazzo era per me un’altra sfaccettatura del suo potenziale e stupefacente fascino. Poi, quando fu rassicurata sullo scarso valore della caraffa, lentamente si ricompose calandosi nuovamente nella parte mentre il regista aveva preso a darle velocemente nuove indicazioni. Una vigorosa pacca sulla spalla datami da Filip, mi riportò alla realtà ed all’inizio delle riprese. Per la prima volta mi ero incantato ad osservarla indugiando sul suo viso espressivo e le sue movenze eleganti. Mi girai di scatto infastidito: «Se non hai niente altro da fare che dar pacche sulle spalle alla gente, un lavoro te lo trovo io» gli feci sapere fingendomi serio.
«Avevi l’aria inebetita, non so se mi spiego…» Si giustificò scandendo le parole e sorridendo. Liquidai la questione con un cenno spiccio della mano, senza badare a ciò che diceva.
Filip aveva colto nel segno ed in seguitomi sorpresi spesso di avere lo sguardo calamitato su di lei. Cercai di stare più attento e di tenermi occupato quando Ellen era nelle vicinanze. Filip era stato il primo a notarlo ma sapevo, conoscendolo, che non lo avrebbe raccontato a nessuno.
In quei giorni Sara si tratteneva sempre più spesso in ufficio fino a tardi; la sua collega era – credimi – pretenziosa e cattiva: oltre ad evidenziarle un mare di errori, Sara doveva anche sopportare, senza ribattere, la sua lingua tagliente e rientrava a casa tardi, triste e sconfortata. Si accasciava esanime sulla vecchia poltrona, chiudeva gli occhi, e stava lì per qualche secondo prima di raccontarmi la sua difficile giornata.
Una volta persi le staffe a causa di quella variopinta imbecille ed insistei per avere un colloquio con il suo capo, ma Sara m’implorò di non farlo, temendo di finire in mezzo alla strada, ricordandomi quanto la nostra condizione fosse difficile.
Il giorno seguente mi recai agli studi. Ero nervoso, camminavo di fretta senza badare ai passanti ed intruppai in un’anziana signora che per un pelo non colpì la mia testa con il bastone. Arrivai agitato, avevo anche rischiato di essere investito da una berlina senza accorgermene. Vidi Ellen al centro di una tranquilla conversazione attorniata da comparse, attori e controfigure mentre il regista imprecava sottovoce, indaffarato con la bobina della macchina da presa che non riusciva ad inserire correttamente.
La scena andò benissimo: Ellen recitò alla perfezione ed il regista fu visibilmente soddisfatto riservandole i più dolci dei complimenti. Io annuivo in completo accordo.
Durante la pausa la vidi entrare nel suo camerino. Mi feci coraggio, uscii dallo studio con una scusa ed aggirai in fretta l’isolato. Una spessa coltre di nebbia avviluppava i pochi passanti imbacuccati ed entrai, senza farmi notare dal guardiano, momentaneamente distratto, dalla porta di servizio. Imboccai il corridoio nel senso contrario rispetto a lei, mi avvicinai al suo camerino ed afferrai la maniglia con decisione. Esitai per un attimo riflettendo sull’apparente insensatezza del mio gesto e poi, spinto dall’incoscienza, spalancai la porta.
Rimasi senza fiato con la testa che mi girava.
La vidi, Karl, era seduta davanti allo specchio con indosso solamente una camiciola dal filato sottile che lasciava – puoi credermi –, pochissimo all’immaginazione. Una gradevole fragranza mi riempì le narici, inebriando i miei sensi. Teneva una spazzola in mano, che posò con circospezione sopra il mobiletto del trucco non appena mi vide. Girandosi verso di me lentamente, assunse una aria sbarazzina di rimprovero: «Ah, ma è curioso il nostro professore…», esclamò calma scandendo le parole una ad una con sorpresa e divertimento.
Non replicai mari masi lì ad osservarla. Non l’avevo mai vista in abiti così così discinti e notai quelle gambe dritte, snelle e sensuali; i lunghi capelli erano raccolti all’insù da un simpatico fermaglio a farfalla.
Spinto da un insolito coraggio che ancora oggi non so spiegarmi, mi avvicinai prendendole le mani invitandola con un cenno ad alzarsi. Lei mi assecondò con sguardo interrogativo senza dir nulla e la baciai con una intensità ed una passione il cui ricordo è sempre rimasto molto vivo negli anni.
Lei si è sciolta contro di me e nel mio intimo esultai. Affondai la mano nei suoi capelli stringendola sempre più al mio corpo. Rimase in silenzio, anche quando la tenni semplicemente stretta sussurrandole teneramente il suo nome.
A pensarci bene, non so ancora cosa mi spinse a compiere un simile gesto. Forse il fatto che Ellen fosse un esempio di bravura o la sua rara e semplice bellezza che la rendeva affascinante, o quel modo di parlare particolarmente affabile, diretta ma cortese, che aveva attirato fin da subito la mia attenzione.
In breve tempo ci innamorammo e, meschinamente, mi dimenticai di Sara che ogni sera mi aspettava fino a tardi, da sola, nel nostro appartamentino per cenare insieme.
«Come mai sei rientrato così tardi oggi?» mi chiedeva Sara, vedendomi arrivare di sera tardi, con il buio. Poi si alzava per andare a prendere con solerzia le pietanze tenute in caldo.
«Mah, sai, il regista è pignolo, rigira le scene più volte finché non sono perfette. Inoltre, una delle attrici ha avuto un malore e noi abbiamo dovuto aspettare che si riprendesse», le rispondevo vago entrando nell’appartamento senza guardarla, per paura che potesse scorgere qualcosa nella mia espressione che potesse smascherarmi.
In realtà non sapevo più cosa inventarmi: una volta le raccontavo che i costumi si erano strappati ed avevamo dovuto aspettare la sarta, un’altra che il regista che non era sicuro di come girare una scena e non era convinto del finale. Questa ultima comunque era l’unica verità che le raccontavo.
Sara non mi faceva mai domande, era incinta ed intenta a confezionare dei completini per il bambino. Questo aggravava la mia colpa fino all’infamia.
Stare con Ellen era rischioso e meraviglioso allo stesso tempo. Quando ero con lei mi dimenticavo di tutto e godevo della sua gradevolissima compagnia come un bambino alle prese con la cioccolata.
Il mio primo regalo per lei fu uno scaldamani: una specie di ruota metallica di piccole dimensioni che racchiudeva all’interno un minuscolo serbatoio con del liquido infiammabile. Quando glielo porsi lei mi buttò le braccia al collo e mi stampò ridendo una serie di baci su tutta la faccia. Quando era molto felice non riusciva a contenersi ed io ero arrivato a viziarla come fosse una bambina.
Nei pomeriggi, liberi dagli impegni sul set, ci accomodavamo davanti al caminetto nel suo piccolo appartamento sulla Vistola, dignitoso nonostante i bombardamenti massicci, e restavamo lì, stretti, quasi con la paura di perderci. Ci capivamo, ci amavamo e sembrava che questo ci bastasse.
Mi raccontò di aver iniziato a recitare per caso e che grazie alla sua voce calda era stata selezionata per la pubblicità radiofonica di un profumo alla gardenia. Così era stata notata dal regista, che si trovava lì per scambiare quattro chiacchere con un amico, che le aveva chiesto i recapiti per poterla chiamare.
«Così, questo è il tuo primo film», le chiesi.
«Si, certo», mi rispose sorridendo. “Quasi da non crederci” pensai.
Dopo circa tre mesi finimmo di girare. Il regista era soddisfatto ed il film fu avviato alla distribuzione. Per festeggiare ci invitò tutti a bere un bicchierino al bar di fronte agli studi. I soldi scarseggiavano per cui prevedibilmente il suo invito fu accolto con entusiasmo. Inoltre le amicizie nate durante le riprese avevano contribuito a creare un clima sereno e di collaborazione insieme ad uno spirito cameratesco. Quell’uscita era il riconoscimento ufficiale del regista al nostro impegno.
Il vociare scherzoso animava l’allegra compagnia: c’era chi abbottonandosi il cappotto si chiedeva dove avesse riposto i guanti; chi invece riavviava i capelli davanti ad uno specchietto da borsetta. Osservai Jacob scaldare l’ambiente con qualche allegra battuta dando pacche sulle spalle ad una comparsa che, scherzosamente, reagì mostrando un rigido e sdegnato autocontrollo con tanto di occhiataccia mentre fingeva vanitoso di spazzare via qualche granello di polvere immaginario dalla manica del cappotto con lo scopo di inviare i presenti ad un maggior rispetto per la sua persona. Facendo credere di essere un duca, ultimo discendente di un antico casato, ammonì Jacob facendo oscillare il dito indice «Ragazzo, la classe non è acqua. Osserva». E si incamminò con il petto in fuori verso l’uscita a passo lento e solenne volendo dare a bere tutti che i suoi semplici abiti erano solo una copertura per il ricco e nobile possidente che mostrava di essere. Infine chiese semiserio ma perentorio a Jacob: «Allora, ragazzo, d’ora in poi mi chiamerai “Sua Grazia”». Jacob allora, stando al gioco, a testa bassa prese a rigirare il berretto fra le mani fingendo imbarazzo: «La sua presenza, nobiluomo mi confonde». Quindi scattò verso l’uscita per spalancare il portone degli studi con estrema sollecitudine al fine di ottenere l’approvazione della comparsa nella parte del duca. Appena fuori dagli studi Jacob prese a spintonare divertito la comparsa «Sua grazia… ma come ti vengono in mente certe cose…».
«Si, forse è meglio “sire”» rispose la comparsa annuendo alla sua logica rimanendo impettito. Jacob raccolse allora una manciata di sassolini e, con soddisfazione divertita, cominciò a tirarli uno ad uno con una certa mira sulle scarpe della comparsa che prese a salterellare cercando di schivarli invocando dopo un po’ ridendo la resa.
Una piacevole scenetta che raddoppiava l’ilarità tra i presenti.
«Vai avanti, adesso vengo, questi vestiti sono difficili da togliere» mi pregò Ellen con un cenno della mano mentre si avviava frettolosa verso il camerino.
«Non ci penso nemmeno – le risposi – ti aspetto». Sentendo quelle parole che rilevavano tutto il mio attaccamento ad Ellen, Filip mi guardò compassionevole, abbassando il capo, mentre Jacob aveva sussultato. Capii in quel momento che i suoi sospetti erano stati confermati. Sono convinto da sempre che i comici abbiano una sensibilità particolare. Non mi disse nulla, né allora né in seguito nemmeno incidentalmente. L’ho molto apprezzato. Ellen mi raggiunse con il consueto sguardo amorevole di cui solo io, fino a quel momento, avevo conosciuto appieno il significato ed insieme ci avviammo al bar.
Se me lo avesse permesso le avrei cinto le spalle, ma la sua natura riservata gli impediva approcci troppo espliciti per paura di insospettire i presenti o peggio ancora, dare adito a pettegolezzi.
Ero convinto che lei mi stesse camminando accanto e raggelai sentendo dietro di me uno stridio di ruote ed un grido acuto. Mi girai sgomento e la vidi riversa su di un fianco inerte sul selciato.
Impallidii.
Un uomo scese immediatamente dalla macchina ripetendo isterico con la testa fra le mani, che proprio non l’aveva vista, che dovevamo credergli, che non era stata colpa sua. Mi chinai fulmineo per prendere tra le mani il volto di Ellen chiamandola e scuotendola; quel corpo senza vita abbandonato tra le mie braccia lacerò per sempre qualcosa in me.
Iniziò così uno dei periodi più bui della mia vita che non avrei potuto superare senza Sara, ne sono convinto. Cominciai a perdere il mio abituale buon umore per lasciare il posto ad una persona diversa, silente e riflessiva.
Girovagavo per casa come una anima in pena. Mancavo di concentrazione, liquidavo i miei interlocutori con risposte secche per tornare subito dopo alla logica distorta dei miei ragionamenti. “Avrei dovuto abbracciarla – continuavo a ripetermi – così avrebbe camminato al mio fianco, senza lasciarla indietro. Avrei dovuto impormi con fermezza opponendomi alla sua proposta di raggiungermi. E quell’idiota di autista, poi, che è venuto pure a dirmi di non averla vista. Queste erano le cose che pensavo di continuo. Me ne stavo in contemplazione pensoso alla finestra senza guardare nulla veramente. Mi massaggiavo la fronte, ossessionandomi all’idea di non possedere niente che me l’avrebbe ricordata che, niente a supporto dei nitidi e cari ricordi che albergavano nella mia memoria. Il mio aspetto divenne trasandato, il mio sguardo assente.
Sara non fece mai domande credendo che quel cambiamento dipendesse dalle preoccupazioni riguardanti la nascita del bambino, prevista di lì a poco.
Il nostro film, a seguito della morte di Ellen, ebbe un successo superiore alle aspettative e, anche se la trama non aveva nulla di sensazionale, piacque comunque ed i giornali ne parlarono a lungo tessendo lodi al regista ed alla protagonista.
Una notte non avevo sonno, mi rigiravo di continuo nel letto senza darmi pace. Rimuginavo sull’incidente e sulle poche parole dette dal medico quando tutti noi della troupe eravamo corsi increduli in ospedale «Non ha sofferto. È morta sul colpo». “Già – pensai – bella consolazione!”
Mi alzai dal letto ed uscii. Il quartiere appariva vuoto e silenzioso immerso nell’oscurità a tratti interrotta da una luna splendente sbucata all’improvviso da dietro le nubi. Attraversai ciò che rimaneva del ponte Poniatowsky e mi diressi verso il centro di Varsavia. Camminavo lentamente, con fare per nulla circospetto, i pensieri mi tenevano compagnia. Passai davanti alla sinagoga di via Grobelna, doloroso esempio della furia distruttiva nazista perpetrata a danno degli ebrei polacchi. La stessa sorte era toccata al tempio di Piazza Tlomackje, che i tedeschi minarono e fecero saltare in aria. Una massa di detriti era tutto ciò che rimaneva.
Sbucai nell’ampia e suggestiva piazza del mercato: un tempo circondata da splendide dimore rinascimentali e barocche, ora un luogo spettrale.
Le finestre, rotte nella migliore delle ipotesi, sembravano enormi occhi che mi scrutavano e mi seguivano.
A un isolato di distanza c’era il cinema, un imponente fabbricato in mattoncini rossi, malconcio ma funzionante. La facciata era intatta.
Mi fermai ad osservare la locandina pubblicitaria del film. “Le forbici della contessa”, scritto in un elegante corsivo gotico inglese.
Ellen indossava un abito sontuoso, in broccato beige, dal generoso décolleté e le maniche a sbuffo.
Era stupenda. I miei occhi lucidi tradivano emozione e deglutii a fatica. Dietro di lei, nella foto appariva il personaggio della sarta, seduta su una piccola sedia, intenta ad ammirare le preziose forbici che teneva in grembo.
Non so per quanto tempo rimasi lì, ricordo solo che ad un certo punto fui investito da una folata di vento freddo che mi riportò alla realtà. Mi alzai il bavero della giacca e tornai verso casa attraversando Via Szeroka, dove molte persone vivevano nelle cantine, fiocamente illuminate, sotto le macerie delle loro case; nonostante l’ora tarda si poteva intravedere ancora qualche luce accesa.
Sospiravo profondamente ogni volta che pensavo a lei, alle sue mani su di me, al suo corpo incantevole, a quando ci tenevamo stretti l’una all’altra ed annusavo la fragranza dei suoi capelli divenuta per me familiare ed inconfondibile. Mi lasciai andare ad un pianto disperato.
Piangevo e camminavo. Mentre le lacrime, scendendo, mi rigavano il viso, oltrepassavo il negozio di Milosz, con ogni tipo di vasellame, ceramiche, brocche in vetrina, ed a quello dell’artigiano Schwarz, abile nella concia delle pelli. Si, pensavo, Varsavia risorgerà dalle macerie. Ero invece dubbioso sulla mia personale possibilità di reagire alla tragedia immane della perdita di Ellen.
Sara ebbe un parto difficile dopo un travaglio di sedici ore in cui non mi fu permesso di starle accanto. Alla fine un’infermiera venne a rassicurarmi: «È andato tutto bene, è un bel maschietto. Sua moglie è molto stanca e deve riposare ma può entrare un momento. Stia solo attento a non far rumore».
Mi alzai con trepidazione, cercai di parlare ma non emisi alcun suono, così mi limitai a seguire l’infermiera attraverso un largo corridoio silenzioso e deserto. Afferrai i bordi lisi del cappello e lo infilai sotto il braccio. Si fermò davanti ad una porta bianca e afferrò la maniglia, facendomi cenno di entrare.
La guardai con riconoscenza e, dopo averle bisbigliato un saluto di commiato, entrai: la stanza era buia ma, a poco a poco, grazie alla flebile luce di una lampada accanto al letto riuscii a riconoscere Sara, stesa ed immobile; mi accomodai sulla poltroncina per i visitatori, cercando di non fare rumore. Fissavo Sara, rammaricato di non riuscire a scorgere sul suo volto alcun cambiamento di espressione. Dormiva profondamente.
Il mio respiro irregolare ed affannato rivelava una profonda preoccupazione.
Fu in quel momento che vidi Ellen riflessa nel vetro di fronte a me. Mi sorrideva. Aveva i capelli sciolti come quando l’avevo conosciuta, lo sguardo benevolo e rassicurante. Era stupenda come sempre.
Strabuzzai gli occhi davanti a quella visione che svanì gradatamente fino a scomparire, lasciando il posto a dei rami di pino che sbattevano sul vetro sotto il giogo del vento.
Sia chiaro, Karl, Ellen era lì, davvero.
Non so cosa mi accadde, sarà stata la grande emozione di rivedere Ellen o di osservare Sara immersa in un sonno profondo, o la felicità di essere diventato padre, mi misi a piangere, un pianto silenzioso e dimesso, mentre sentivo dei brividi percorrermi la schiena. Le lacrime scendevano copiose ed inarrestabili. Ellen mi aveva amato pur con i miei sbalzi d’umore, con le mie preoccupazioni che dovevano trasparire più di quanto immaginassi, con la mia inettitudine per la recitazione e la mia scarsa propensione a raccontare le circostanze e gli eventi che avevano scandito la mia vita. Eppure aveva compreso i miei silenzi, aveva scandagliato nel profondo del mio animo trasformandosi in una adorabile compagna.
Sara tornò a casa felice, il bambino era davvero grazioso ed io appagato nel guardarli; la vita aveva ripreso il suo corso: lavoravo come insegnante di latino a Varsavia in una scuola privata per signorine perbene.
Potevo finalmente contare su di uno stipendio mensile, essenziale per crescere il bambino. Pensavo ancora ad Ellen. L’avevo anche sognata tra le mie braccia mentre le chiedevo disperatamente perdono per la brusca interruzione dei nostri interludi amorosi.
Una mattina, mentre ero intento a correggere con le mie allieve una versione di Cicerone scorsi attraverso il grande finestrone dell’aula una macchina della polizia polacca. Ne uscirono due uomini in divisa che si diressero con passo deciso verso l’ingresso della scuola. Non diedi peso alla cosa ma dopo pochi minuti, qualcuno picchettò in modo discreto alla porta dell’aula.
«Professor Bauer, mi scusi, vuole raggiungermi un momento nel mio ufficio, per cortesia?», mi chiese seria la direttrice con aria preoccupata.
Dopo un rapido congedo dalle mie alunne, la raggiunsi nel suo ufficio, dove ad aspettarmi trovai i due poliziotti.
Meglio che ti eviti i dettagli di quell’incontro, durante il quale non feci altro che assicurare di non sapere dov’eri. Quando scoprii che Ellen era tua moglie per poco non trasecolai.
«Ammettiamo pure che io le creda quando afferma di non sapere dove sia suo fratello, che in qualità di criminale non ha nessun interesse a farsi trovare ma che lei voglia convincerci che Ellen Hutter non le abbia detto di essere sua cognata… Non le sembra troppo?» Concluse, soddisfatto della sua logica, colui che immaginavo essere il capo fra i due.
Ribadii con fermezza la mia assoluta estraneità ai fatti e giurai di non essere a conoscenza di nulla. Caspita, proprio non sapevo niente.
E mentre mi guardavano entrambi con fare sornione e condiscendente come si guarderebbe un bambino pescato con le mani dentro la marmellata ma che giura di non avere visto marmellata in giro, visibilmente infastidito ribattei: «Scusi, perché, sua moglie le racconta sempre tutto?» fissandolo con aria di sfida.
Allora vidi distintamente un lampo selvaggio nei suoi occhi, la mascella irrigidirsi e lamano destra chiudersi a pugno, fui sicuro che mi avrebbe steso a terra, magari rompendomi qualche dente; invece si limitò ad informarmi stizzito che sarebbero ritornati dopo un paio di giorni. A loro dire, avrei potuto ricordare qualcosa di importante e di utile per le indagini.
Tornai in aula, recuperai i libri e mi allontanai dalla scuola, ormai deserta, sconvolto e avvilito.
Incrociai Hans, l’anziano postino, che salutandomi da lontano mi fece cenno di fermarmi, così lo aspettai di fronte al panificio sotto casa.
«Dato che ti ho visto, te la consegno adesso» e, frugando nel suo vecchio e consunto borsello, tirò fuori una busta che mi consegnò, felice di essersi risparmiato un altro giro quella mattina; il cielo era grigio, gonfio d’acqua.
Maneggiai la busta ed era ormai troppo tardi per chiamare Hans quando mi accorsi che le lettere erano due ed erano così incollate da sembrare una sola.
La prima missiva era per me, la solita variazione di orario comunicata anche per posta, l’altra lettera era indirizzata a te e ad Ellen.
Rimasi immobile con quella lettera tra le mani. Non sapevo cosa fare ma dopo aver riflettuto qualche minuto, decisi di leggerla.
Mi sedetti su di una panchina, aprii la busta con impazienza e ne lessi velocemente il contenuto: una certa signorina, Anna Novak, richiedeva cortesemente, ma con urgenza, la restituzione delle chiavi del cottage sul lago Nysa.
Il contratto era scaduto e l’importo per i giorni eccedenti sarebbe di certo stato addebitato, ma per poter di nuovo affittare il villino bisognava provvedere al più presto alla riconsegna delle chiavi. Si scusava anche per non essere riuscita a non trovare un altro modo per comunicare data la mancanza di notizie di entrambi i coniugi da molto tempo.
Nel pomeriggio decisi di fare un salto agli studi. Spiegai al guardiano, facendo trapelare di proposito una certa inquietudine, che non riuscivo più a trovare dei guanti a cui tenevo particolarmente ed ero quasi certo si potessero trovare all’interno degli studi da qualche parte.
Dopo una iniziale riluttanza, il guardiano acconsentì ad accompagnarmi all’ingresso ed aprì le porte dello studio dandomi solo dieci minuti per trovare i guanti. Aveva finito il turno e stava per andarsene.
Mi precipitai nel camerino di Ellen. Frugai ovunque, finché nel fondo di un piccolo cassetto trovai una chiave con la scritta “Cottage 5” che portava sul retro il nome dell’agenzia immobiliare. La afferrai ed uscii ringraziando soddisfatto il guardiano. Ellen teneva tutte le chiavi nel camerino; diceva che conservarle dove trascorreva la maggior parte del tempo, la rassicurava perché, secondo lei, chiunque avrebbe potuto mettersi in testa di entrare nel suo appartamento, considerando la mancanza di abitazioni decenti.
Una volta rientrato, mentre Sara riordinava la cucina, diedi un’occhiata all’atlante per controllare la distanza tra Varsavia ed il lago Nysa: trecentoventi chilometri.
“Dannazione! – pensai – sarebbe stato impossibile andare e tornare in giornata con quei bus scalcinati”. Riflettevo febbrilmente, dovevo controllare quel cottage prima che quei due poliziotti tornassero. Il giorno dopo sarebbe stata la mia giornata libera. Se fossi partito all’alba sarei arrivato lì a notte fonda ed avrei potuto entrare nel cottage senza essere notato.
«Sara, ascoltami. Questa mattina, a scuola, mi ha chiamato il regista informandomi di voler girare un nuovo film sul lago Nysa e chiedendomi di raggiungerlo per valutare insieme delle antiche iscrizioni rivenute sul posto. Vuole che gliele traduca per capire se può ricavarci delle scene interessanti. Naturalmente si accolla tutte le spese. Io gli ho risposto che non posso lasciarti sola, ma lui ha insistito dicendo che è importante. Tu che ne pensi? Se non vuoi resto a casa».
«Ma no, vai, io me la caverò», rassicurò lei.
Come la conoscevo bene, sapevo che avrebbe acconsentito ancora prima che aprissi bocca.
Dopo un’ora ero già nell’autobus, lento, polveroso, malandato. Le ruote sussultavano sulle strade dissestate rendendo il viaggio oltremodo scomodo.
Arrivai a notte fonda con la schiena dolorante e gli occhi cerchiati ma soprattutto ignorando che avrei dovuto camminare ancora per mezz’ora seguendo le indicazioni per il lago.
Per non dare nell’occhio mi addentrai lungo un sentiero in salita, illuminato dalla luce discreta della luna; era stretto e sconnesso, pieno di ghiaino scivoloso. In certi punti attraversava un boschetto di faggi e mi dovetti far strada a fatica scostando i lunghi rami frondosi. L’aria era gelida ma profumava leggermente di muschio.
Dopo una ripida discesa sbucai in una radura dalla quale era ben visibile il cottage, una costruzione graziosa di piccole dimensioni acquattato a qualche metro dal lago. La luna tracciava sulla superficie del lago una suggestiva scia argentea che conferiva al circondario un che di magico. Il cielo era limpido e le stelle sembravano cucite sopra un enorme arazzo nero. Ricordo di essermi soffermato a guardare le tendine colorate alle finestre. Avevano una aria così familiare ed accogliente che abbandonai ogni timore e mi avvicinai.
Con la chiave aprii la porta. Accesi una piccola Abatjour verde con paralume tondo poggiata sopra un piccolo tavolino e tirai le tende. L’interno del villino era ordinato ed essenziale: un caminetto in pietra, un salotto, una piccola cucina ed un antico secretaire che attirò subito la mia attenzione. Provai ad aprirlo ma era chiuso.
Di colpo mi tornarono in mente le parole del nonno che per hobby, dopo la messa domenicale, si divertiva a restaurare mobili antichi. «Ragazzo mio, ricorda, c’è solo un posto nel quale si possono nascondere le chiavi di un secretaire» e lo rividi indicarmi quel punto sotto il mobile, nell’angolo.
Karl era vero! Sentii lo scatto ed uscì una piccola chiave dorata che mi affrettai ad inserire nella serratura. Vi trovai una lettera incompleta. Era di Ellen scritta su una carta color avorio.
Karl,
mi dispiace doverti comunicare che tra di noi è finita.
Non verrò con te in America. A causa delle discussioni a cui mi hai obbligato, qui in questo cottage, mi sento emotivamente sconvolta.
Ho le mani gelate, divento scontrosa, e non riesco a toccare il cibo per il disagio.
Eppure sai bene che sto girando un film e ho bisogno di calma.
Ho incontrato una persona che mi ama e mi comprende. Non so dirti dove questa relazione mi porterà, ma con lui sto bene, come probabilmente non sono mai stata con te. Fra qualche settimana il film sarà finito e ti prego di non cercarmi più.
Penso di avere diritto a un po’ di serenità e se…
La lettera terminava così.
Mi accasciai sul divano per qualche istante, strofinandomi la fronte, stanco e pensieroso, cullato dallo sciabordio dell’acqua del lago.
Ecco il perché delle mani gelate, della continua inappetenza, dell’atteggiamento ritroso e scostante; era tutto causato dalle continue discussioni con te.
Non avevo mai rivelato ad Ellen di essere sposato e di stare aspettando un figlio. Me lo aveva chiesto, s’intende, ma l’avevo sempre depistata raccontandole di una breve relazione insoddisfacente avuta anni prima con una insegnante di scienze naturali.
Ma, se Ellen fosse vissuta, che cosa avrei fatto? Sarei riuscito ad abbandonare mia moglie e mio figlio per lei?
Ellen aveva scelto di vivere con me e questo mi commuoveva e mi lacerava allo stesso tempo. Non ne avevamo mai parlato ma ora so che lei aspettava il termine delle riprese per affrontare l’argomento.
Curiosai ancora e dopo un rapido sguardo mi accorsi di una busta appoggiata sopra l’imponente credenza. Intenzionato ad andare fino in fondo, mi alzai di scatto per recuperarla.
Notai sbalordito la scrittura di Sara.
“Cristo – pensai – lei che c’entra?”
La aprii e cominciai a leggerla con bramosia:
Gentile signorina Ellen Hutter,
noi non ci conosciamo e la prego di perdonare fin d’ora la mia audacia nello scriverle.
Sono la moglie del Professor Bauer, che recita come comparsa nel suo film.
Sa, quando il marito dimentica per una settimana di fila di richiudere il
dopobarba o la porta di casa quando esce, l’intuito amoroso di una moglie si mette in allerta.
Così, una mattina, nascosta in un vecchio cappotto lungo e grigio e indossato un berretto, per non dare nell’occhio, l’ho spiata attraverso un vetro appannato degli studi. Lei è molto bella, signorina.
Fu quando vidi mio marito che capii tutto: lui la stava guardando come faceva con me all’inizio, quando ci siamo conosciuti. Aveva lo stesso guardo carezzevole, le stesse premure e non mi staccava mai gli occhi di dosso.
Ormai non conto più le tante bugie fantasiose che mi ha raccontato Peter per riuscire a starle vicino.
Non sono attraente come lei, non dispongo di denaro, né faccio l’attrice, ma ritengo di amare profondamente e di comprendere mio marito pur con tutti i suoi difetti, bugie comprese.
Quando non se ne accorge lo scruto e colgo tutto il suo struggimento, la sua apatica sofferenza anche nei semplici gesti quotidiani, mentre corregge i compiti distraendosi di continuo o quando parla perdendo il filo del discorso o si abbandona pensieroso sulla poltrona, in silenzio.
A volte non mi sente neppure quando lo chiamo o gli rivolgo qualche semplice domanda.
È assente, distratto, combattuto. Lo avverto di continuo.
È un rapporto impari quello fra noi due, ne sono consapevole: lei è una bella attrice in procinto di diventare famosa, e io, una semplice contabile.
Probabilmente Lei si chiederà come mai non ne abbia parlato con lui: perché ho paura di perderlo. Sì, signorina, è così, ho aspettato che l’attrazione tra voi due passasse e quando ho visto che non è così, ma anzi aumentava, mi sono decisa a scriverle questa lettera come tentativo estremo.
Le sto scrivendo con umiltà, porgendo al suo cospetto il cuore ferito di una moglie In pena. Rifletta su questa relazione, la prego.
Le auguro ogni bene e le migliori soddisfazioni nella sua vita.
Anna Benski, moglie del professor Bauer.
“Che stupido – mi dissi – ed io che credevo di avergliela data a bere!”
Confrontai le date delle due lettere, era la stessa. Allora pensai: “ma come è possibile che Ellen abbia scritto la lettera dopo aver letto quella di Sara?”
E poi capii. Ellen non aveva potuto terminare la lettera perché in quel momento sei arrivato tu, con in mano la busta di Sara che avevi posato sulla credenza senza dargli la giusta importanza.
Tu eri l’unico, infatti, a poter ritirare la posta agli studi, in qualità di proprietario. Già, che sciocco che sono.
Quando il regista ci diceva: «Anche se c’è il guardiano, il signor Al Kerruba si raccomanda di chiudere bene alla sera». Non avrei mai pensato che il nome del proprietario fosse l’anagramma del tuo.
Così, né tu, né Ellen riusciste a leggere la lettera di Sara.
Chiudesti il cottage e partisti in fretta per l’America: forse qualcuno ti aveva riconosciuto e fosti costretto ad organizzare la tua fuga.
In seguito mi misi sulle tue tracce portandomi dietro una foto, scattata prima della guerra, in cui comparivamo entrambi abbastanza vicini. Stavamo bevendo una bibita, seduti in un bar del centro insieme a due conoscenti. Apparivi sorridente ed elegante con il gomito appoggiato sul bracciolo della poltroncina. La cravatta di lana, giallo ocra, in tinta con i calzini ed il fazzoletto sul taschino dava un tocco di raffinatezza al gessato grigio. Partire con solo quella foto non era molto, lo sapevo, ma grazie ad alcune notizie apparse sul giornale e qualche breve conversazione con chi ti aveva conosciuto mi convinsero di essere sulla buona strada. Quella piccola indagine mi permise di dipingere un quadro piuttosto preciso anche se non dettagliato della tua vita.
Ciò che scoprii su di te mi fece provare una profonda vergogna. Sara sapeva cosa stessi facendo e forse aveva ragione a consigliarmi bonariamente di lasciar stare, di non rivangare il passato perché mi avrebbe portato solo dispiaceri e delusioni; lei riusciva a guardare oltre la voglia di ritrovarti. Io però credo che sopravvivere ad una guerra significhi anche imparare ad affrontare il passato e le sue sinistre sfaccettature.
Cercai il luogo, dove vivevano Elsa e sua madre, ricordi ti ho parlato di lei. Era in periferia, si stava facendo buio ed ero quasi stremato a furia di seguire sommarie indicazioni percorrendo strade dissestate mentre una pioggia gelida, scendendo implacabile, mi colpiva inclemente la faccia. Trovai riparo in quella specie di baracca dove mancava tutto. Panni stesi lungo un filo sopra una piccola stufa in ghisa ed un gatto che mi venne incontro arruffando il pelo mi diedero subito l’idea dell’indigenza in cui le due donne vivevano. Sopra al fornello a petrolio in una vecchia pentola malconcia bollivano rape e patate. Il vapore saliva a sbuffi e si dissolveva appannando i vetri di una piccola finestra che si affacciava in via Pawiak.
«Vieni avanti», mi invitò con voce malferma la madre di Elsa. Non sapevo che la sua famiglia fosse ebrea. Mi raccontarono di essere riuscite a sopravvivere grazie al documento ariano, falso naturalmente. Per ottenerlo la madre di Elsa aveva dovuto impegnare tutti i suoi averi in oro e mobilia compreso un copriletto interamente fatto a telaio. Ma la falsità di tale documento non ti sfuggì, quando il fratello di Elsa, per una tragica fatalità, te lo porse in treno. Lo uccidesti prima ancora che cominciasse a capire quello che gli stava succedendo.
Uscii esausto dalla loro casa e mi trascinai a casa in preda alla vergogna di chi non ha giustificazioni. Poi seguirono altre persone, altre storie ed altro dolore. Ad ogni nuova scoperta stavo peggio così decisi di smetterla.
In via Pawiak c’era il ghetto grande, un rettangolo lungo quattro km e largo due e mezzo costruito dai tedeschi sotto le parvenze di un campo di quarantena, recintato da un muro di pietre e mattoni alto quattro metri, lungo diciotto km e privo di giardini e viale alberati che i tedeschi ebbero cura di escludere. L’aria era irrespirabile.
In meno di un ventesimo del territorio metropolitano venne concentrata la metà della popolazione di Varsavia: quattordici persone a vano. Si viveva per le strade specie d’estate con il caldo. Gas e luce mancavano per settimane. Si moriva come mosche.
Lì si trovavano orrende prigioni in cui erano rinchiusi cinquecento bambini sotto i dodici anni che tu andavi ad ispezionare regolarmente. Piccole mani brulicanti ti imploravano, ti supplicavano, voci bianche rotte dal pianto ti pregavano invano. I bambini al di sotto dei due anni furono i primi a morire, poi toccò agli altri per denutrizione e per tifo esantematico. Uno sterminio rapido e senza deportazione nei campi. Il carro dei morti passava davanti alle celle due volte al giorno, si sentivano i bambini piangere disperatamente ma nessuno poteva farci alcunché.
Come riuscivi a dormire alla notte? E so anche quello che facevi sul “ponte maledetto” di via Chlodna quando montavi di guardia. Ogni giorno uccidevi qualcuno dei passanti, a caso, a chi capita, capita, tanto da guadagnarti l’appellativo di “Frankenstein” da parte degli ebrei.
Che cosa raccontavi ad Ellen, di lavorare all’interno dell’ufficio propaganda tedesca?!
Nella disperazione del ghetto lasciasti malignamente in vita un ragazzo ben piantato, piuttosto in carne che suonava il violino per guadagnarsi qualche zloty unicamente perché pensasti che sarebbe stato divertente vederlo dimagrire giorno dopo giorno. La vita nel ghetto era carissima. Un paio di scarpe usate poteva arrivare a costare 2000 zloty e quel ragazzo finì per vendere le sue in cambio di un po’ di cibo. Avvolse i piedi negli stracci e, dopo aver venduto anche il violino per un tozzo di pane, si accovacciò su di un gradino dove morì pelle ed ossa. Una sadica soddisfazione sul tuo volto nel veder infine realizzata una premonizione scontata.
Bene, credo di averti detto tutto. Dopo aver letto la lettera di Sara, la guardai con occhi diversi e calcolai meglio quello che dovevo riferirle quando effettivamente avevo bisogno di assentarmi qualche ora. È stata una buona compagna ed una buona madre; abbiamo trascorso degli anni felici insieme.
Sono certo che questa lettera ti arriverà in un modo o nell’altro con una preghiera: di riconciliarti con il ricordo di Ellen.
Era una creatura sensibile e straordinaria ma si sentiva sola. Eravate troppo diversi, e, di certo, le crudeltà a cui la guerra ti ha abituato, vi avevano allontanato.
Il giorno prima di morire, mentre mi versavo da bere nel suo appartamento, mi abbracciò improvvisamene da dietro appoggiando la testa amorevolmente sulla mia schiena mormorandomi qualcosa all’orecchio: «Mio adorato professore, me lo daresti un figlio?» chiese tirando un profondo sospiro.
Ebbi un lieve sussulto. Rimasi immobile ed in silenzio mentre le emozioni più diverse mi attraversavano. Non avrei mai pensato che me lo avrebbe chiesto. La sentivo avvinghiarsi a me sempre di più, mi commossi e, infine, scostando la testa di lato, riuscii a sussurrarle con un filo di voce: «Va bene». Davvero non avrei potuto negarle nulla.
Ma tu, dimmi Karl, le hai negato anche questo? O dopo l’orrore inflitto a quei bambini nel ghetto, ti sei imposto di non avere figli?
Prima o poi, questa lettera ti giungerà, lo so. Conservala, rileggila e chiediti se la tua vita avrebbe potuto essere diversa, vissuta meglio, se noi avremmo potuto essere amici. Io lo avrei voluto ed anche Ellen, puoi credermi.
Vivi a lungo Karl. Penso che sia la punizione più giusta per te.
Tuo fratello gemello, Peter Bauer.
Varsavia,17 settembre 1984
Mariangela Monaco
(bottegascriptamanent, anno XII, n. 131, agosto 2018)
Elisa Guglielmi, Ilenia Marrapodi