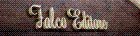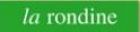Società di prodotti editoriali, comunicazione e giornalismo.
Iscrizione al Roc n. 21969.
Registrazione presso il Tribunale di Cosenza
n. 817 del 22/11/2007.
Issn 2035-7370.
Direttore editoriale: Mario Saccomanno
A. XVIII, n. 200, maggio 2024
 Contropotere
Contropoteresiciliano
di Anna Del Monaco
La mafia tra storia
e voglia di riscatto.
Un libro Pellegrini
La mafia è una forma di esercizio del potere che si basa sul consenso prodotto da un’omogeneità culturale storicamente consolidatasi in Sicilia attorno a un complesso di valori antitetici a quelli dello stato di diritto. Ogni suo progetto di riscatto coinvolge l’uomo comune, quello che insieme agli altri uomini forma la società civile; concreatore, partecipe e vittima, ancorché inconsapevole, di un sistema di modi di sentire, pensare e agire che sono l’humus dal quale la mafia come struttura di potere trae alimento, vitalità e forza. Sottolineare tale connessione e individuare, se esistono, princìpi d’azione e strategie che possano sgretolare e abbattere la fortezza della cultura mafiosa è lo scopo delle pagine scritte da Alberto Rosati in Mafia e cultura mafiosa (Pellegrini editore, pp. 192, € 18,00).
Un problema anzitutto culturale
Arbitrio, corruzione, violenza, omertà e delitto sono sempre esistiti e continuano a esistere in ogni comunità di stampo mafioso, anche fuori dalla Sicilia. Prima che un sistema di potere, la mafia infatti è una “cultura”, nella quale Cosa nostra affonda le proprie radici, traendone linfa e alimento. Fuorvianti gli stereotipi della piovra che soffoca nel suo abbraccio tentacolare una Sicilia sana ma atterrita, o delle lacrime di coccodrillo a ogni delitto eccellente, e ancor più inutile il continuo bussare alle casse dello stato in atteggiamento tra il parassitario e il malandrino, che non si sa se più miserabile o protervo. Così non si verrà mai a capo di nulla e Cosa nostra resterà una malattia impossibile da estirpare. È tempo di riconoscere che il germe del contagio si diffonde, si moltiplica, si perpetua trasmettendosi ai giovani con la forza irresistibile dell’esempio sociale. Occorre una rivoluzione culturale che dissolva la mentalità mafiosa, le cui modalità sono tutte da approfondire, e forse anche da inventare, ma della quale non è più lecito ignorare la necessità. Se fosse un fenomeno senza radici nel sociale, la mafia avrebbe i giorni contati, al pari delle Brigate rosse che, prive di legami col tessuto della società, furono isolate e sconfitte. Sono le relazioni esterne dei mafiosi a costituire in definitiva la loro forza, la loro capacità di adattamento, di radicamento e diffusione; perché la mafia senza collusioni, senza scambi di favori con pezzi della politica, delle istituzioni, della economia e della imprenditorialità, senza complici, adepti o favoreggiatori non sarebbe stata e non sarebbe tutt’ora mafia.
L’omertà
Le persone tacciono perché provano un senso forte di paura che poco avrebbe in comune col condividere atteggiamenti mafiosi. In realtà il discorso è più complesso. L’omertà nasce come strumento di autodifesa all’interno di una cultura contrassegnata da un forte senso di appartenenza a varie tipologie di società ristretta (consorteria, confraternita, setta nelle città, famiglia, comunità, villaggio nelle campagne) e conseguente rifiuto di ciò che appaia diverso ed estraneo: a cominciare dalle istituzioni pubbliche, percepite non come garanzia ma minaccia. Sicché testimoniare significa tradire gli interessi del gruppo, abbandonarne l’alveo protettivo, spogliarsi della propria identità e offrirsi inermi alla sanzione della vendetta. L’atteggiamento omertoso è quasi sempre frutto di un meccanismo di autocensura che scatta a livello istintivo inibendo a priori la trasgressione. E quando è il timore a dettarla, la scelta dell’omertà si radica pur sempre in un retroterra culturale più o meno consapevolmente condiviso, perché la minaccia della ritorsione è accettata e ritenuta legittima in quanto è sentita parte di un complesso normativo (non scritto) volto a colpire comportamenti antisociali. Proprio come la previsione della pena in uno stato di diritto. Lo scioglimento nell’acido che la cupola decreta per l’“infame” è, sul piano sostanziale, il perfetto equivalente della pena che lo stato irroga a chi violi le sue norme.
Tornando a casa una sera di sabato, Tararà – come narra Pirandello nella novella La verità – «trova uno scandalo»; che però non consiste in un complesso di fatti, nella scoperta in flagrante dell’adulterio della moglie e nel suo arresto, ma nel racconto che ne diffondono in giro i vicini. Gli altri, la gente, l’occhio della gente, ecco l’ossessione del siciliano/Tararà: il senso paranoico degli “altri”, che ne condiziona ogni atteggiamento e giudizio, consuma lo scambio tra il piano della realtà e quello dell’apparenza; e l’apparenza diviene, sotto ogni aspetto, realtà. Non sono le corna, nella loro oggettività corposa, a causare il disonore e perciò il delitto, ma ciò che appare agli altri. Ma la novella non si limita a fissare con evidenza incisiva questo tratto del costume siciliano; ci offre anche non equivoci indizi sulle sue radici: dalla figura di Tararà, dalla bestialità del lavoro che svolge, evocata dal lezzo suo e dei contadini che assistono al processo, dal rassegnato fatalismo nei confronti di una giustizia incomprensibile ma ineluttabile, emerge uno scenario di ancestrale servaggio materiale e spirituale che rinvia con forza al susseguirsi plurisecolare di dominazioni straniere e domestiche, oppressive e spoliatrici. Facendo terra bruciata delle possibilità di benessere materiale, hanno confinato la signoria dei siciliani al regno dell’apparenza.
Certi caratteri sono così radicati nella coscienza collettiva del popolo siciliano da indurre a pensarli iscritti nel suo patrimonio genetico, nel “siciliano” modo di pensare. Di tali modi di pensare, sentire e agire si dovranno indicare le radici storiche se si vuole in qualche misura comprenderli. Non sarà difficile scoprire, ancora una volta, la psicologia di un popolo condannato a confrontarsi per millenni col padrone di turno…
Sulla stessa linea si muove il giudice Falcone, secondo il quale «la doppia morale, o doppiezza dell’anima siciliana, è un retaggio della storia».
«L’essere, il sentirsi colonia»: ecco lo statuto mentale del popolo siciliano, costretto a sopravvivere elaborando, nel corso del tempo, un’identità collettiva che eleva il mimetismo a struttura della personalità.
È dunque un prospetto di sicilianità a infervorare il sangue del problema? La pensava così, da sostituto procuratore, Antonio Ingroia quando avvertiva che scrivere di una mafia alle corde fa il gioco dei clan.
Il clientelismo di una regione “autonoma”
Prendendo in considerazione Pirandello, esempio perfetto per approfondire il contesto stesso: per inciso e, con una punta di malizia, c’è da presumere che, se fosse vissuto sino al crollo del fascismo, non avrebbe perso l’occasione di “convertirsi” alla democrazia (forse anche cristiana), pronto ad affibbiare qualche buon colpo (di penna) al decaduto destinatario del suo peana.
La compravendita di voti, i buoni spesa e benzina in cambio di appoggio politico, le suppliche, le promesse, le pressioni, le minacce, i ricatti, le somme iperboliche bruciate in pochi giorni nelle più oscene invenzioni propagandistiche, l’abuso di denaro pubblico per creare e rafforzare clientele, il clima di strisciante illegalità che contrassegna le campagne elettorali per il rinnovo dell’Assemblea regionale testimoniano soltanto lo sfrenato accattonaggio, il degrado morale, l’infimo livello al quale si riduce la contesa politica in Sicilia. Tutto ciò vuol dire che esiste un linguaggio comune, una mentalità diffusa, una omogeneità culturale di fondo intessuta di malcostume, arroganza, privilegio, arbitrio, violenza in cui un’intera società, senza distinzioni di ceto o di funzione, continua a riconoscersi. Non si dimentichi Totò Schillaci, l’eroe del mondiale di calcio “Italia ’90”, per il resto bravo, giovane e palermitano purosangue al pari di tanti altri, il quale, al termine di un Bologna - Juventus del 1990, all’avversario che lo ha provocato non urla, come sarebbe “normale” in uno scatto d’ira: «T’ammazzu!», ma «Ti fazzu ammazzari!» (la possibile variante «Ti fazzu sparari!» non modifica i termini del problema).
Prima che un contropotere criminale, la mafia è una caratteristica endogena, che permea le strutture sociali tramite un sistema di valori impresso nella coscienza collettiva, si conforma all’evolversi dei processi economici e, là dove opera, li condiziona e distorce. Ciò perché l’azienda mafiosa gode, rispetto a quelle normali, di specifici vantaggi competitivi, tra cui figurano ingenti risorse finanziarie provenienti dai mercati illeciti; forti poteri economici locali essendo quasi del tutto monopolio lavorativo; e un forte potere politico derivante dai rapporti che la mafia intrattiene “per sua natura” con le istituzioni; infine la minaccia o l’uso della violenza per estromettere i concorrenti.
In realtà, come potrebbe Cosa nostra ottenere questo risultato se la società civile, ignorando i princìpi dello stato di diritto, non fosse, con azioni e omissioni, in larga misura complice? Non potrebbe. Cioè non esisterebbe.
Il potere mafioso trova il terreno ideale nei contesti in cui siano presenti fenomeni di criminalità economica, di lobbying illecito, di malaffare politico-amministrativo; e, più in generale, nella cultura del clientelismo come humus adatto alla sua incubazione e al suo sviluppo.
Incipit con flashback dal modello unico di elezioni regionali siciliane. All’approssimarsi di ogni elezione regionale, ancora una volta, si scatena l’orgia frenetica dei lavori pubblici: l’elemosina che a scadenza periodica i ras siciliani vecchi e nuovi concedono ai clienti di seconda e terza schiera affinché li ricordino nelle loro preghiere e, soprattutto, nel voto. Così il sistema si alimenta e si riproduce; sino alle prossime elezioni, quando la farsa si replicherà con minimi ritocchi alla sceneggiatura e ai protagonisti.
Connivenza con la malavita, abuso del denaro pubblico, disprezzo della legge: non c’è nulla di nuovo sotto il sole di Sicilia.
Non c’è dubbio che il centralismo di Palermo sia ancora più opprimente di quello di Roma, con doppi e tripli controlli, conflitti di competenza tra stato e regione, pratiche che rimbalzano di qua e di là per anni. Lentezze e vessazioni della macchina burocratica regionale si sommano alle inefficienze dell’apparato statale. Il risultato è che l’autonomia siciliana produce frutti che non potrebbero essere peggiori. Tutto ciò che arriva in Regione si blocca. La conclusione? Per i corrotti personaggi che presiedono alle sorti degli operatori economici siciliani, completare una pratica in cinque minuti o in cinque anni è la stessa cosa, mentre invece per le imprese, un mese in più o in meno spesso significa sopravvivere o fallire.
Affiora qui uno dei problemi più gravi della società siciliana, perché l’affermarsi degli istituti autonomistici e lo sviluppo dei relativi apparati hanno favorito il diffondersi capillare di un ceto di burocrati che, dai gradi infimi ai più elevati, usa l’autorità di cui dispone per intessere una fitta trama di rapporti interpersonali di stampo feudale basata sullo scambio istituzionale di favori.
In Sicilia, la cultura della transigenza, del privilegio e del sopruso, radicatasi attraverso secoli di complesse vicende storiche e di feroci conflitti sociali, è ormai regola di coscienza e obbligo morale. La mafia, quella che taglieggia e uccide, non è null’altro che il prodotto naturale e l’esito più coerente e definitivo del sistema culturale in cui la società siciliana continua nel suo complesso a riconoscersi.
Quando si sente questo “sicilianismo” d’accatto scagliarsi contro il mondo cinico e baro che complotterebbe a respingerla nella più abietta miseria – stato assenteista, sfruttamento di manodopera a buon mercato ecc. –, è impossibile trattenersi dal ridere: il pensiero corre al fiume di miliardi ingoiati negli ultimi settant’anni dall’isola, ed è inevitabile chiedersi che fine abbiano fatto quando, correttamente impiegati, sarebbero bastati a redimere per saecula saeculorum non una ma tre Sicilie.
È questo oggi, come ieri il feudo, il vero terreno fertile di coltura della mafia. Se ben s’intende la storia della Sicilia, ritenere le tirannidi straniere e domestiche corresponsabili in ugual misura del corrompersi della coscienza civile è giudizio da modificare; perché tutto dimostra che i primi nemici della Sicilia, e i più protervi, sono – oggi come ieri, ancora e sempre – i siciliani.
Anna Del Monaco
(www.bottegascriptamanent.it, anno IX, n. 98, ottobre 2015)
Elisa Guglielmi, Ilenia Marrapodi