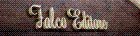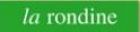Società di prodotti editoriali, comunicazione e giornalismo.
Iscrizione al Roc n. 21969.
Registrazione presso il Tribunale di Cosenza
n. 817 del 22/11/2007.
Issn 2035-7370.
Direttore editoriale: Mario Saccomanno
A. XVIII, n. 200, maggio 2024
La figura del padre
nella società odierna
tra visioni sessantottine
e pensiero femminile
di Giovanna Bruco
Da Longanesi editore, il romanzo quarto classificato al Premio “Strega”:
una positiva evoluzione del tema “figli che subiscono le colpe dei padri”
In un momento storico in cui la disaffezione alla politica spinge alcuni intellettuali a riproporre vecchi miti, una scrittrice di formazione classica poteva cedere allo sgambetto che i vecchi padri non si stancano di fare alle donne. Su la Repubblica del 24 marzo 2013, dopo aver sostenuto che il paese è impaurito a causa de Il padre che non c’è, Eugenio Scalfari ha indorato la pillola lasciandosi sfuggire che «la causa della scomparsa della figura del padre è l’emancipazione della donna e la perdita della trascendenza […] ma ci sono e sempre più ci saranno donne in grado, come e più degli uomini, di darsi carico dell’altrui, molto più dell’uomo».
Un “darsi carico dell’altrui” che, seguito da «la nostalgia del padre è motivata dal bisogno di sicurezza psicologica che egli diffonde. Senza di lui il mondo diventa insicuro […]. Non a caso venivano chiamati “padri fondatori” coloro che stabilivano le regole della convivenza sociale e politica», ci ha fatto pensare alla fatica delle donne destinate da sempre a eseguire gli ordini imposti dalla razionalità maschile. L’idea che la sicurezza psicologica possa venire anche da un pensiero femminile, che dalle “regole” della convivenza sociale è sempre stata esclusa, continua ad essere assente.
Quando poi Scalfari prosegue a dire che senza il padre «non ci saranno più neppure i figli, i fratelli […] al posto del padre, della madre, dei fratelli, si è insediata la cultura del branco […] che è un prodotto della modernità e al tempo stesso è lo sbocco più arcaico che mai si potesse immaginare», il palese riferimento all’antropologia freudiana di Totem e Tabù, per la quale all’origine della civiltà ci sarebbe l’omicidio del padre primigenio da parte del gruppo dei figli-fratelli, è tornato a riproporre l’ineluttabilità della violenza nella natura umana ormai smentita dalla scienza moderna (Boncinelli, De Waal, Montalcini, Tattersall).
Leggere che il branco «contiene una socialità negativa e distruttiva che si basa sull’ideologia del più forte […]. Gli “ultrà” delle curve sud ne sono l’esemplificazione più frequente e più primitiva» ma non dei voti che questi portano ai padri della politica, e che «le capacità affettive delle donne […] costituiscono una delle risorse essenziali della carità volontaria […] del moderno umanesimo» francamente non ci ha commosso.
Dunque spostiamoci sul libro di Romana Petri, Figli dello stesso padre (Longanesi, pp. 304, € 16,40), dove affetti vincenti introducono ad un esame più appropriato della figura del padre.
Se in certe interviste l’autrice sostiene che le protagoniste del suo romanzo sarebbero un po’ delle Cassandre, destinate a non lasciarsi ascoltare dagli uomini, che restano le figure centrali del romanzo, la sua scrittura ha saputo dissociarsi dalla logica di una facile razionalità diffusa.
Diversamente dai primi due classificati allo “Strega” 2013, Walter Siti con Resistere non serve a niente – la cui indagine narrativa prefigura un aldilà della democrazia come «un inferno contro natura che chiede di essere […] (forse e radicalmente) negato» – e Alessandro Perissinotto con Le colpe dei padri – dove il persistere della dissociazione del protagonista, che si martirizza alle prese con le sue doppie identità senza proporre vie d’uscita alla vischiosità della nostra società attuale, non si discosta da quanto rappresentato dal protagonista del romanzo di Siti – ciò che, a dispetto del titolo, tiene inchiodati a Figli dello stesso padre è una dimensione interna di rifiuto di inaccettabili intrichi che, dal privato, si estendono inevitabilmente alla dimensione sociale. Come avvenne nel ’68.
Nel libro della Petri, il timore del pericolo di far tornare il ’68, che ha ampiamente ispirato i vincitori del premio, giustamente non c’è. Perché fu un movimento senza pensiero di cui ci dice subito la copertina, azzeccatissima, dove l’uomo senza testa, che volta le spalle, braccia e mani abbandonate lungo i fianchi in evidente segno di sconfitta, è l’emblema di quell’anno. Del “vietato vietare” che sfociò in una libertà euforica e masturbatoria.
Ben rappresentata dal protagonista Giovanni, il padre assente intorno al quale ruota tutto il romanzo, la “libertà” sessantottina non si curava della realizzazione della donna, senza la quale non può esistere una identità maschile. Costanza, la madre di Emilio, il secondo figlio dello “stesso padre”, rimane incinta proprio nel ’68, quando ancora non c’è il divorzio. Germano, il primogenito avuto da Giovanni dalla smaliziata Edda, che diventerà amica di Costanza quando anche lei verrà abbandonata, ha già otto anni. Incontriamo Giovanni nelle prime pagine a casa del vecchio eccentrico padre suo, che si è accompagnato a una seconda moglie di nome Lia, «donna fascinosa prematuramente invecchiata» che la vita «se l’era annichilita restando accanto a quell’uomo che non le rivolgeva quasi mai la parola». Con Giovanni, Lia parlava delle plastiche che si era fatta perché le stessero meglio gli orecchini, e scopriamo subito la sua diversità dalla madre di Giovanni, che non si curava ed era stata abbandonata, e che nella narrazione è destinata a restare nell’ombra. La sua incapacità di reagire agli annullamenti la sentiamo tutta nell’immaturità del figlio. Quando leggiamo che Lia «fumava in modo disperato» mentre chiedeva a Giovanni se continuava ad andare dallo psichiatra e quali medicine gli facesse prendere per confrontarle con quelle che prendeva lei, ci ricordiamo del tipico esemplare del ’68 che combatteva le proprie impotenze rifugiandosi nell’alcol e negli psicofarmaci. Più avanti, Germano adulto ce lo confermerà definendo suo padre come uno che «faceva di tutto per farsi male fino a riuscirci». Sui particolari della sua morte l’autrice sorvola come fosse cosa scontata. Come se Giovanni fosse per tutti già morto quando era ancora in vita. Ma ecco che, a quattro anni dalla sua scomparsa, qualcosa sembra aver lavorato sulla discordia che aveva lasciato nei figli, tra i quali, adesso adulti, vecchi rancori cercano una esplosione di affetti diversa. Germano, il dionisiaco prediletto dal padre farà onore al suo nome e diventerà fratello di Emilio, il rivale, quello non voluto dal padre, che aveva sofferto per la solitudine della madre vedendola fare tutto da sola e che, dopo otto anni di «psicoterapia d’oltreoceano», è riuscito a costruirsi una famiglia ordinata, programmata sullo stile di Pittsburg, con due figli che lo aiutano a dipingere il recinto del giardino nei giorni di festa e una bella moglie inglese. Anche se dai «modi ordinati ma taglienti» che non sa provare emozioni, «“È il suo lato british” pensava ogni volta con un po’ di pena nel cuore», tanto da cercare di evitarne anche a lui quando è costretto a spiegarle cos’è che lo spinge a volare dal fratello, che lo ha invitato alla mostra più importante della sua vita, intitolata Rigor mortis come a esorcizzare il pericolo di una morte psichica, che il padre gli aveva lasciato dentro.
Due bei figli nonostante il ’68, ci vien da dire. Perché sappiamo che il padre non è quello biologico ma quello che risponde. Ed entrambi lo hanno rispettivamente trovato: Germano in Duarte, il nuovo uomo di sua madre che, con affettuose strategie, ha stimolato la sua volontà portandolo a realizzarsi come artista, ed Emilio nel professore di matematica che gli ha dato dieci dopo averlo ringraziato per quel che aveva saputo dirgli sulle formiche e confermato che la matematica era un’arte. Emilio diventerà difatti un brillante matematico.
Dunque a ben guardare il libro della Petri, dove i figli sembrano venuti su assai meglio che nelle famiglie “normali” non allargate, diversamente dai primi classificati al Premio “Strega”, è tutto modernamente proteso al superamento dell’Edipo purtroppo ancora assai caro all’inconscio maschile sembrerebbe meno evoluto. Nel romanzo le due madri, che dall’uomo senza testa e, di conseguenza, senza cuore, hanno saputo separarsi anche se costrette a viaggiare verso l’autonomia guidando per «sessanta chilometri col pianto del figlio nel motore», non ci hanno evocato per niente le tragedie greche. E ne siamo contente visto che i ponti con queste sono l’ultima cosa di cui le giovani donne hanno oggi bisogno.
Inevitabile a questo punto rilevare che chi recensisce i libri per mestiere, non sempre, riesce ad approfondire il tessuto più vero del testo.
Michele Lauro su Panorama, risalendo al lavoro di Massimo Recalcati Il complesso di Telemaco. Genitori e figli dopo il tramonto del padre, in cui l’autore spiegherebbe l’intuizione di Goethe che «nel bene e nel male, per possedere davvero ciò che abbiamo ereditato dal padre dobbiamo riconquistarlo», sostiene che questa è anche alla base di Figli dello stesso padre della Petri. E sempre sull’onda di Recalcati che ci dice che tutti i figli sono stati come Telemaco, ovvero hanno aspettato il ritorno del padre e lacanianamente afferma: «Telemaco, diversamente da Edipo e Narciso che sono dei senza nome si nutre del Nome. Fa esistere insieme a Penelope il Nome del Padre», anche Bruno Quaranta così ripesca dalle formule lacaniane: «Figli dello stesso padre, il loro arrancare, duettare, danzare, bighellonare, infine ri-nascere nel nome del Padre».
Anche se l’autrice dice di essersi formata sull’Iliade e su l’Odissea, al contrario di questo auspicato “ritrovamento”, a noi è sembrato invece che tutto il libro si articoli sulla dinamica della separazione dal padre in questione per una conquista da parte dei figli di una identità completamente altra e diversa.
La memoria, fantasia inconscia dell’autrice, legata al ricordo di quanto studiato, deve aver certo elaborato che Ulisse è stato considerato il prototipo del criminale di guerra per l’inganno perpetrato a Troia. E che il figlio, nell’Odissea, organizza un omicidio di massa per restaurare l’autorità regale. Il gesto apparve smisurato anche nell’antica Grecia avvezza a crimini efferati, tanto che Ulisse fu processato ed esiliato per ben dieci anni. Secondo la Telegonia, dopo che Odisseo fu ucciso per sbaglio dalla lancia di Telegono, il figlio avuto da Circe che poi sposò Penelope, anche Telemaco, diventato re, sposò Circe. Dietro il Telemaco che aveva atteso il ritorno del padre riappare il figlio-Edipo, che vuole mettersi al posto del padre. E dunque anche continuando a porsi come un battitore libero della psicanalisi, mettendosi nel suo libro Patria senza padri nella condizione filiale di “un novello Telemaco”, Recalcati non riesce a districarsi dallo spaesamento della politica servendosi dell’operazione linguistica lacaniana che non fa che risalire a Freud. Le errate ipotesi freudiane, per le quali i sogni sono desideri e, al contempo, espressione della più feroce pazzia, non consentendo quella interpretazione che distingue il narcisismo patologico e l’odio per gli altri dal movimento proteso verso la conoscenza che porta alla trasformazione, impediscono il rifiuto del disumano nell’uomo.
Ma se le confuse scuole psicanalitiche possono favorire qualche riflessione cosciente, che incontra false linee di pensiero, non è difficile poi riscontrare che non riescono a condizionare l’ispirazione di una scrittura che vola dettata dal pensiero non cosciente. La riconquista di una affettività fanciullesca vissuta con tutto il corpo dai due figli, protagonisti nella narrazione della Petri, non ha niente a che fare con i falsi miti.
E la psichiatria moderna legata alle teorizzazioni di Massimo Fagioli ce ne dà una spiegazione molto chiara. Perché nella sua Teoria della nascita e castrazione umana c’è la scoperta di un piccolo ma fondamentale e scientifico trucco che capovolge il pensiero greco. Prima si fa l’amore con la madre, e poi si “uccide” il padre. Nel senso di saperne prendere le distanze. Così l’uomo non rischia più di violentare la donna portandosi dentro il cadavere con cui si è identificato. E questo è quello che intuisce anche l’autrice quando leggiamo che Germano dice alla madre: «Se tu muori io mi uccido».
L’amore di Germano per Edda non è morboso. Il loro stare a letto insieme a parlare «mettendosi a coltellino» non teme l’incesto. Perché con Duarte la madre Edda ha trovato una sessualità sana che può trasmettere al figlio. Così come è successo ad Emilio, amato da Costanza, che l’ha voluto “nonostante” il padre, trasmettendogli una certezza di rapporto che si è trasformata in convinzione che tra lui e suo fratello si può costruire qualcosa. È per questo che decide di andare alla sua mostra dove rischia il malessere dello smarrimento come perdita momentanea della sua apollinea perfezione. Dunque un libro che chiaramente si lascia alle spalle le colpe dei padri per una resistenza che serve ad andare verso la trasformazione. Nella sigaretta che Germano sbriciola tra le mani alla fine del libro c’è l’impossibilità del ritorno del ’68. Se ne libera come da una droga mentre il suo pensiero si muove verso una immagine nuova di donna suggeritagli dal fratello con cui ricreare la propria nascita. E l’instancabile Emilio? Avevamo letto che dopo l’incontro con Germano avrebbe amato Jenny in maniera diversa. Ci piace pensare che riosservando le formiche qualche volta possa chiedersi: “Che sulle orme di Esopo si fosse poi sbagliato anche La Fontaine?”.
Giovanna Bruco
(www.bottegascriptamanent.it, anno VII, n. 74, ottobre 2013)
Elisa Guglielmi, Ilenia Marrapodi