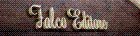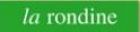Società di prodotti editoriali, comunicazione e giornalismo.
Iscrizione al Roc n. 21969.
Registrazione presso il Tribunale di Cosenza
n. 817 del 22/11/2007.
Issn 2035-7370.
Direttore editoriale: Mario Saccomanno
A. XVIII, n. 202, luglio 2024
 Da Paisà a Salò e oltre :
Da Paisà a Salò e oltre :un’opera monumentale,
che riscopre capolavori
della filmografia italiana
di Guglielmo Colombero
Nel suo nuovo saggio, edito da Avagliano, De Benedictis ci racconta
trent’anni di cinema attraverso i volti dei protagonisti e le loro storie
Maurizio De Benedictis, docente di Storia del Cinema alla facoltà di Lettere e filosofia dell’Università “La Sapienza” di Roma, ha già pubblicato Il cinema americano (Newton & Compton, 2005), Acting. Il cinema dalla parte degli attori (Avagliano, 2005) e il romanzo L’estate di Greta Garbo (Avagliano, 2006).
Da Paisà a Salò e oltre. Parabole del grande cinema italiano (Avagliano, pp. 590, € 25,00) è un saggio monumentale su tre decenni di cinema italiano: chi scrive, quel periodo lo ha vissuto intensamente, e lo ha simbolicamente sotterrato il 2 novembre 1975, insieme al corpo martoriato di Pier Paolo Pasolini scambiato per un cumulo di immondizia ai margini dell’idroscalo di Ostia, e non può che turbarsi fino alla commozione nello sfogliare le pagine di questo volume. E chiunque ama il cinema, e in particolare quello italiano, la cui lenta agonia (preannunciata dal collasso economico di Novecento di Bernardo Bertolucci) ebbe inizio pochi mesi dopo la scomparsa di Pasolini, non può che esprimere una immensa gratitudine a chi, come il professor De Benedictis, mantiene viva la memoria storica di quel periodo con un’opera così concettualmente rigorosa e, nel medesimo tempo, brulicante di passione, da custodire gelosamente nell’archivio ideale di chi non intende né rimuovere né dimenticare, e, anzi, punta disperatamente i piedi contro lo tsunami putrido e ormai dilagante dell’idiozia televisiva, che in una delle sue tante lucide profezie Pasolini definiva definì “delittuosa”.
Rossellini, De Sica, Zavattini: il moralista, il seduttore, l’anarcoide
Nel primo capitolo, Autori d’immagine, De Benedictis prende le mosse da Roberto Rossellini (definito artefice dell’immagine «autoptica»), per il quale l’Italia è «il paese più cattolico e anche il più sacrilego; il paese del tanto peggio - tanto meglio: in cui, toccando il fondo, si distrugge il circuito di cultura, civiltà, benessere, e poi lo si ricostruisce. Il paese dove – e qui siamo in un punto illuminante – il realismo nasce da un attaccamento alle cose morboso, parossistico, quasi mistico. Ciò che forse spiega una parte dell’energia realista rosselliniana «[…] che sa arrivare al particolare più eccentrico, anche al paradosso surreale, per indagare come funziona il motore dei fatti e rendere l’immagine più idonea». Impossibile dimenticare la maestria con cui Rossellini riusciva a infondere nello spettatore il profondo disagio emanato dai rituali del potere in quel gioiello di tecnica cinematografica che è La presa di potere di Luigi XVI: realizzata nel 1966, questa opera più junghiana che storica è la sontuosa pietra tombale del neorealismo, ma ne rappresenta anche il canto del cigno. L’immagine «amorosa» di Vittorio De Sica invece «procede tra un compiacimento edonistico e l’amore per il proprio oggetto, cioè per i personaggi. Questi vengono accompagnati da un fluido, carezzevole moto della cinepresa, che richiama il gesto tra affettuoso e ironico del De Sica attore, morbido dicitore dall’inflessione partenopea». Un aneddoto particolarmente significativo su De Sica è riportato dall’autore rievocando le riprese de La ciociara con Sophia Loren che, dopo l’atroce stupro suo e della figlia ad opera dei soldati marocchini, pronuncia la battuta “Noi ci abbiamo solo voglia de dormì”: «Nel caos del set, De Sica bestemmia in modo atroce (ne chiede perdono a Dio) per ottenere la calma, il silenzio in cui possa dirigere la condensazione dell’acme – volontà insieme di dissolvimento e di recupero – di quella frase sulle labbra dell’attrice».
Co-fondatore del neorealismo insieme a De Sica e Rossellini, Cesare Zavattini, l’indimenticabile sceneggiatore di Sciuscià, di Ladri di biciclette, di Miracolo a Milano e di Umberto D, solo da ottuagenario riesce a girare il suo primo film da regista, La veritàaaa!, in cui l’Italia è vista come «un manicomio – con tanto di simboli storici, da Garibaldi al papa – che va avanti tra frenate repressive, autocensure e slanci d’immaginazione fino all’assurdo. Una società che vuol vivere anche delle eccentriche schegge schizzate dalla propria frantumazione». Profeta inascoltato come Pasolini, Zavattini gli sopravvisse solo perché le sue pulsioni sessuali erano più prevedibili e meno pericolose (ci ha lasciato in un giorno di ottobre del 1989, tre settimane prima che cadesse il Muro di Berlino: chissà come avrebbe commentato quel crollo fatidico un vecchio comunista emiliano come lui…), ma fu altrettanto odiato dai potenti, dato che non si era mai stancato, nemmeno in tarda età, di fustigare la ripugnante ipocrisia clerical-fascista della classe dirigente subentrata a Mussolini ma sotto non pochi aspetti (a cominciare da quello mediatico: e purtroppo è una constatazione che vale tuttora) di tendenza altrettanto dispotica.
Il sincretismo visivo di Visconti e la simbologia felliniana
«Nell’immagine viscontiniana», scrive De Benedictis (etichettandola come «antropomorfica»), «una complessità preformata – di letteratura, teatro, melodramma, pittura e musica – trova ambienti e presenze umane delicate e sode, istintive e riflessive, corpi di muscoli e di pensieri su cui ribollire come il mare schiumoso negli scogli del film siciliano». Luchino Visconti fu un titano del cinema italiano: l’impresa di fondere il cinema al melodramma attraverso una trasfigurazione sensuale delle sfumature cromatiche in Senso resta ineguagliata (memorabili sia la schiena nuda di Alida Valli che emerge come una ninfea carnosa dal biancore delle lenzuola che la fucilazione finale di Farley Granger al livido chiarore delle torce), come pure l’identificazione del bianco e nero duro e tagliente di Rocco e i suoi fratelli con l’alienazione urbana degli immigrati meridionali a Milano (l’abbraccio sepolcrale con cui Annie Girardot accoglie le coltellate di Renato Salvatori restò impresso nella mia memoria di ventenne come una marchiatura a fuoco: la famosa e contemporanea sequenza della doccia in Psycho non è nulla a confronto). L’immagine di Federico Fellini è invece definita «simbolica»: De Benedictis innesta il cinema felliniano sul ceppo letterario di Carlo Emilio Gadda, e il teorema che ne risulta è intrigante: «Fellini amava Quer pasticciaccio brutto de Via Merulana e poi lesse con istruttivo divertimento Eros e Priapo, satira del narcisismo patologico italiano nella persona del duce Mussolini (per Gadda ogni italiano era un ducetto). […] Gadda colpisce nel duce e nel fascismo il gallismo e l’esibizionismo priapico, la vocazione alla chiacchiera tronfia e vacua, la smargiassata virilistica e la sostanziale vigliaccheria, la trasformazione delle donne e degli stessi uomini in “uterinità” senza cervello: in breve, il narcisismo patologico come marchio riassuntivo del carattere nazionale». Non vi fa pensare a un certo personaggio dell’attuale mondo politico che, guarda caso, per Mussolini ha sempre manifestato una certa ammirazione?
I feticci di Pasolini e il tecnicismo di Antonioni
Il cinema di Pier Paolo Pasolini – che per De Benedictis rappresenta l’omega della sua trattazione (il neorealismo di Paisà ne è invece l’alfa, ovviamente) – emerge per la prima volta nel focus sull’immagine «feticistica» dello scrittore e regista friulano: «nello schermo della frontalità pasoliniana, tra l’incoscienza del mito e la coscienza della storia, cogliamo non simboli ma feticci (attinenti a quel suo feticistico amore per la realtà). Il simbolo è un significato generale attribuito a qualcosa: il feticcio è propriamente questa cosa, il potere più o meno “magico” che promana dalla sua singolarità e separatezza. L’immagine dei film di Pasolini seziona in tal modo la realtà, passando dall’adesione passionale al rigetto indignato e furioso, fino a quella sorta di distruzione dell’oggetto e di autodistruzione di se stesso – come autore e individuo – che avvengono nell’ultimo film […]. E tale appare il destino dell’Italia dentro l’immagine pasoliniana dei corpi: spazi, cose dell’esordio sul sottoproletariato romano – depositario, nella sua miseria anche morale, di una incosciente vitalità – fino, appunto, all’orrore dell’ultimo film: in cui i feticci per eccellenza, cioè i corpi dei ragazzi, vengono umiliati e infranti». Sicuramente un’ininterrotta pulsione di morte scorre come un fiume carsico nell’intera filmografia pasoliniana: dal ladruncolo che trova serenità solamente dopo morto in Accattone alla comparsa affamata che muore d’indigestione ne La ricotta, dall’agonia del ragazzo detenuto in Mamma Roma, all’urlo silenzioso di Susanna Pasolini (mater dolorosa atrocemente predestinata nella vita reale a sopravvivere a entrambi i figli) davanti al Cristo morente in Il vangelo secondo Matteo, dalla soppressione simbolica dell’autore identificato con il corvo parlante divorato da Totò e Ninetto in Uccellacci ed uccellini al suicidio di Giocasta in Edipo re, dalla catalessi vegetativa di Anne Wiazemsky in Teorema alla fine struggente dei due burattini gettati nella discarica di Che cosa sono le nuvole, dallo smembramento delle vittime sacrificali di Medea al supplizio del cannibale Pierre Clementi divorato dai cani in Porcile, dalla disperata tenerezza di Lisbetta che custodisce nel terriccio di un vaso di fiori la testa dell’innamorato ucciso dai fratelli ne Il Decameron al rogo dello sventurato condannato per sodomia ne I racconti di Canterbury, dalla fanciulla nuda e incatenata tagliata a pezzi da un demone crudele ne Il fiore delle mille e una notte fino al girone del sangue di Salò. Nessuna morte fu più annunciata di quella di Pier Paolo Pasolini…
«Nel cinema italiano autoriale l’assunzione della tecnica come esponenza della modernità ha il suo massimo rappresentante in Michelangelo Antonioni», premette De Benedictis nel paragrafo dedicato all’immagine «tecnica» del maestro ferrarese. L’autore puntualizza che «dopo Il deserto rosso il lavoro del regista s’era internazionalizzato: in cerca di nuovi spazi per apologhi su un vuoto di tipo postmoderno e postindustriale, in cui esibire suggestive tecniche di ripresa. Il clou del film è sfoggiato da scene di questo tipo: l’ingrandimento fotografico nello studio del protagonista in Blow-up (vero manifesto del regista, questo “progetto” fotografico racchiudente in sé una realtà, che non è più in cambiamento ma in fuga evanescente); il ralenti della distruzione della villa – e dell’american way of life in essa contenuto – in Zabriskie Point». Fu infatti sconvolgente per un cinephile ancora inconsapevole come il sottoscritto, inabissarsi nella lenta vertigine suscitata delle inquadrature inquietanti e sofisticate di Antonioni, e scoprire l’essenza del cinema autoriale già all’epoca insidiato dall’appiattimento televisivo. L’epilogo di Zabriskie Point coincise anche con la scoperta della musica dei Pink Floyd, mentre la sequenza di Blow-up in cui David Hemmings fa l’amore con due ragazze in mezzo alla carta colorata mi rivelava che l’erotismo cinematografico più conturbante non scaturiva dalla nudità esibita ma, al contrario, da quella mimetizzata nella scenografia pop…
Il cinema italiano rinasce sulle macerie della guerra
Il secondo capitolo, intitolato La damigiana di Fellini in Paisà (la prima sequenza girata dal giovane Fellini fu appunto quella in cui, per sfuggire al tiro dei cecchini, alcuni partigiani fanno passare una damigiana piena d’acqua da un marciapiede all’altro, trainandola con delle funi), è incentrato sulla genesi del neorealismo: scrive De Benedictis che il 1946, l’anno in cui fu girato Paisà, è «un anno mirabile, di espansione del portato culturale della Liberazione – nel senso più ampio – e anche di transito a una restaurazione strisciante e poi conclamata. […] l’anno dei processi di Norimberga. Comincia un’analisi che ha un compimento nel 1962 in La banalità del male di Hannah Arendt, sul processo al nazista Eichmann. Analisi per definire i termini della società antitetica a quella paisà, retta cioè sulla “sistematica menzogna” (anche a se stessi) che dà origine al totalitarismo». De Benedictis ci rivela tutti i retroscena del primo capolavoro neorealista, rivelando come talune scelte estetiche siano state dettate in realtà dalle ristrettezze in cui avvenivano le riprese: Paisà «è girato a scene rapide, non volutamente, ma per la brevità dei pezzi di pellicola reperibili in quel sinistrato momento […] quella certa luce su cui tanto si è scritto […] non è costruita dall’autore ma, in assenza di un parco lampade decente, dal direttore della fotografia con accrocchi di lampadine sugli attori, come su statue della madonna. E poi gli ambienti esterni e interni, esaltati per il taglio della loro essenziale novità, erano ciò che si poteva trovare a Roma, con Cinecittà svuotata dei macchinari dai tedeschi e occupata dagli sfollati dei bombardamenti. Viene da pensare – al di là dello stesso criterio dell’improvvisazione – che un centro di autorialità si rileva nell’uso stesso dei limiti di mezzi che la realtà, o la Storia, impongono».
L’Albertone nazionale, dalla maschera al ghigno
Dedicando un intero capitolo alla straordinaria figura di Alberto Sordi (uno dei “mostri sacri” di mezzo secolo di cinema italiano, accanto a Gassman, Manfredi, Mastroianni e Tognazzi), De Benedictis ne traccia un ritratto memorabile enucleandolo dalla celeberrima sequenza degli spaghetti in Un americano a Roma: «una divorante fame italiana (prima del decollo economico) che ingurgita pasta a testa in giù, la bocca spalancata, gli occhi persi in un miraggio di sazietà e anche di paura per l’attacco di fame a venire. La peculiarità della scena, eternata dai poster appesi in molte case italiane, sta in una ferocia particolare con cui, non si fronteggia, ma si assale il bisogno primario del cibo. Gli spaghetti come creatura da cannibalizzare, in un sacrificio al dio atroce della bocca e del ventre. Non sta mangiando un monte di pasta, ma rosicchiando per rivalsa il cranio del mondo». In Un borghese piccolo piccolo, girato da Mario Monicelli due anni dopo la morte di Pasolini, in un’Italia già assediata dal terrorismo politico e dall’anonima sequestri, la metamorfosi del pavido travet ministeriale in un sadico e vendicativo giustiziere privato deforma la maschera bonaria e quasi pecoreccia di Sordi nel ghigno sanguinario del forcaiolo. Significativo l’aneddoto che ci narra De Benedictis, risalente alla lavorazione di questo film: «l’attrice americana Shelley Winters s’arrabbiò con Sordi […] perché mentre lei prendeva una lunga pausa per “entrare” nel personaggio, lui, Alberto, se la rideva masticando un panino. A bocca piena, le rispose un qualcosa come: “Tu ciai il metodo Stanislavskij e io ciò il metodo della mortadella” […] Non era più il Sordi degli anni Cinquanta; ma nella mortadella, come un grano di pepe, rimane un briciolo di furia divorantemente “realistica”».
Fellini, il viandante nella selva dei simboli
Nel capitolo centrale e fondamentale, Linguaggi dell’aldilà. Fellini e Pasolini, che non a caso racchiude quasi metà del libro di De Benedictis, l’autore si addentra nell’universo complicato dei due grandi maestri del cinema italiano. Federico Fellini non è mai riuscito a realizzare un film sull’al di là, Il viaggio di G. Mastorna, del quale però esiste un vasto materiale grezzo da cui attingere preziose chiavi interpretative delle opere invece realizzate: «Per Fellini, il morto viene a trovare l’autore sotto forma di opera: è Mastorna che ciclicamente va e viene. Fino al biglietto stilato dal regista nell’ospedale in cui morirà».
Dal debutto neorealista come co-sceneggiatore e assistente alla regia di Rossellini per Paisà, Fellini degli anni Cinquanta infierisce sul maschio italico gallista (Lo sceicco bianco) e “mammista” (I vitelloni), per poi spostare il tiro sul «torvo buffone da fiera che mangia il fuoco e spezza le catene» in La strada e sul truffatore da strapazzo de Il bidone, ammazzato di botte sul ciglio di un sentiero di montagna. Questa stagione si chiude con Le notti di Cabiria, di cui De Benedictis sottolinea la memorabile sequenza di «delirio religioso popolare» nel santuario del Divino Amore. Gli anni Sessanta si aprono per il cinema italiano con una triade di capolavori dopo i quali nulla sarà più come prima: uno dei tre, La dolce vita, porta la firma di Fellini (gli altri due sono Rocco e i suoi fratelli di Visconti e Accattone di Pasolini), ed è il primo elemento di un trittico ideale in cui lo affiancano i successivi 8 e mezzo e Giulietta degli spiriti. Un trittico da cui, scrive De Benedictis, emerge «un tetro oscuramento di coscienza», mentre il progetto del viaggio di Mastorna si arena rischiando di inaridire la vena creativa del regista. Si riparte in un clima post-sessantottesco con Satyricon, dove «il rosso pompeiano si fa simile a una crosta secca di sangue», si prosegue con I clowns in cui De Benedictis ravvisa «un aldilà come trionfo di istinti e inconscio» e con Roma, «una visione violenta – una specie di caricatura totalizzante – intinta in iconografie grasse e acide, urtanti, dall’espressivismo barocco di Gadda al colorismo della Scuola Romana, portato a un senso sfatto, a volte putrescente». Nel corso degli anni Settanta, la visione felliniana si rasserena in Amarcord, vera e propria «foresta di simboli in cui doveva far legna il Mastorna», e precipita nel vuoto con il Casanova, affresco estenuato e quasi deprimente, paragonabile allo «scorrere di una materia consunta e marcida, acquatica – dai riflessi vibranti sugli interni – di colore tra verdognolo e ruggine». Le ultime opere del maestro – fra il 1979 e il 1990, tre anni prima dell’improvvisa scomparsa – sono stanche coazioni a ripetere, quasi sempre autoreferenti (frutto di una vera e propria «inerzia ispirativa»): la cupa allegoria politica di Prova d’orchestra, il magma indigesto di La città delle donne, il manierismo spesso stucchevole di E la nave va e di Ginger e Fred, la nostalgia vagamente spettrale di Intervista, e, da ultimo, La voce della luna, dove dal «disfacimento del presente affiorano echi del passato». Annota amaramente De Benedictis in chiusura di capitolo: «l’ultimo Fellini (non invecchiava “bene”, confidò una volta il clown asessuato del suo cinema ed enigma permanente della sua vita privata, Giulietta Masina), magari nello schermo intimo dei disegni, non s’illudeva molto».
Pasolini, l’innocente traditore di se stesso
La prima fase di Pasolini autore cinematografico si snoda su un percorso che De Benedictis fotografa magistralmente nel titolo del paragrafo: Dai poveri cristi a Cristo. Debutta dietro la macchina da presa agli inizi degli anni Sessanta con Accattone, in cui il magnaccia che tenta inutilmente di redimersi è incalzato da una «cinepresa vischiosamente luminosa, come la coscienza che poco a poco lui comincia a sentire». Il miraggio di un impossibile riscatto sociale assilla anche la Magnani di Mamma Roma, film girato in una «cristiana città dei “figli di mignotta” condannati ognuno alla croce, mentre le madri si disfanno di dolore risaputo». «Cosa ne pensa della società italiana?» domanda un intervistatore a Orson Welles ne La ricotta: e lui risponde: «il popolo più analfabeta e la borghesia più ignorante d’Europa». In questo episodio del film Rogopag (a suo tempo processato per vilipendio alla religione), una comparsa affamata, di nome Stracci, crepa per davvero sulla croce, come uno dei ladroni, a causa di un rigurgito di ricotta. «Povero Stracci», commenta Welles (che impersona il regista del film sulla passione di Cristo a cui partecipava il poveraccio), «ha dovuto morire per farci accorgere che esisteva». Qui il povero cristo pasoliniano è un «un rifiuto del boom economico». L’anno dopo, Pasolini gira fra i Sassi di Matera Il Vangelo secondo Matteo (e in quella medesima cornice, quattro decenni dopo, Mel Gibson girerà il truculento The Passion of the Christ): capolavoro «tessuto di alta tradizione visuale e scarnificata gestualità; musica sacra, colta, e spirituals aspri di sudore; inquadrature memori dei grandi autori – per esempio i russi epici – e riprese effettuate quasi da un cineamatore lì per caso […] col Vangelo, Pasolini è a una curva del percorso. Se prima aveva messo con amorevole furia le mani su Accattone, costringendolo a specchiarsi nei suoi occhiali scuri – manovra che, ne La Ricotta, con la figura di quel regista, diventava anche autocritica – adesso è come se lui si facesse imporre le mani da Cristo e si mettesse in causa». Il Pasolini degli anni Sessanta è vulcanico quanto discontinuo: Uccellacci ed uccellini è un apologo bizzarro dove Totò e Ninetto Davoli «percorrono una lunga strada, irta di occasioni simboliche e liriche. Per un bel tratto, procedono in compagnia di un corvo gracchiante che, con aforismi pungenti o istrionici paternalismi, chiosa ogni naturalezza sottoproletaria e ogni atto, innocente o efferato, di aspiranti piccolo-borghesi». Totò e Ninetto ricompaiono in uno degli squarci poetici più sublimi del cinema pasoliniano, l’episodio Che cosa sono le nuvole in Capriccio all’italiana: due burattini gettati in una discarica per la prima volta contemplano il cielo e le nuvole, scoprendo la bellezza del creato… Segue Edipo re, trasposizione ambiziosa quanto fallimentare di Sofocle, come se l’accecarsi di Edipo significhi «fare tabula rasa, riempirsi le orbite svuotate con uno sguardo internamente chiaro». Anche Teorema – allegoria di una ricca famiglia borghese messa in crisi e disgregata da una specie di angelo sterminatore buñueliano – appare piuttosto trasandato, e lo stesso vale per Porcile, dove «il padre – la società con i suoi poteri –, divorato dal figlio ridivora quest’ultimo». Opere che più che scandalizzare per il loro potenziale trasgressivo irritano e sconcertano un pubblico del tutto incapace di decodificarle, ad eccezione della solita esigua minoranza di intellettuali. Dopo l’algido e raggelato Medea, che chiude la stagione degli anni Sessanta iniziata con Accattone, Pasolini affronta il decennio successivo sfoderando «una tecnica fatta maturare a forma dirompente, anch’essa liberatoria»: è la Trilogia della vita. Ispirandosi a Boccaccio (Il Decameron), a Chaucer (I racconti di Canterbury) e alla novellistica orientale (Il fiore delle mille e una notte), Pasolini infrange le barriere censorie (puntualmente assolto da procedimenti penali per oscenità: per primo ha osato inquadrare i genitali maschili in primo piano e descrivere atti sodomitici fra uomini), fungendo da involontario apripista per la pornografia di consumo (pochi anni dopo la sua morte aprono i battenti le prime sale a luci rosse in Italia). Il suo «ultimo espressivo sforzo di salvare il corpo» si risolve in un mortificante fallimento, e Pasolini stesso, poco prima di avviare le riprese di Salò, rinnega pubblicamente la Trilogia, pur affermando di non essersi pentito di averla realizzata. Ed eccoci all’autunno del 1975, al capolinea fatidico di Salò o le 120 giornate di Sodoma. Film che è impossibile vedere due volte (confesso di non esserci riuscito, in preda a una specie di crisi di rigetto sia morale che emotivo): il vitalismo disordinato della Trilogia si necrotizza in una geometrica e agghiacciante pulsione di morte. La matrice sadiana rivive nelle uniformi dei carnefici fascisti in un «orrore che l’autore non vuole disperdere emozionalmente: taglia dunque la rappresentazione in una stele rigorosa, un bassorilievo quasi di pietra. Vi incide l’intreccio di capacità accusatoria e di drammatica impotenza che c’è dietro la sua faccia scavata (avviata a maschera mortuaria)». De Benedictis sottolinea il furore velenoso dell’ultimo Pasolini: «la scena del matrimonio celebrato fra cumuli di merda; espressione della ripugnanza pasoliniana per l’istituzione, per il circolo sociale che ricomincia, per la coppia eterossessuale, per tutto ciò, ultimo non ultimo, che lo priva del suo rapporto col corpo dei giovani maschi». Il 2 novembre 1975 la pressione di un pneumatico sfonda la gabbia toracica di Pier Paolo Pasolini e il suo cuore esplode: pochi giorni dopo la commissione di censura nega il visto alla sua opera postuma. Passeranno due anni prima che una sentenza assolutoria ne permetta la proiezione in pubblico: ma ormai delle immagini disturbanti di Salò non importava più niente a nessuno. Ne possiedo la versione integrale in videocassetta, ma giace da anni, ancora intatta, in uno scaffale della mia videoteca.
Il regista borgataro, l’illusionista del set e l’immortale teatrante
Gli ultimi tre capitoli del saggio di De Benedictis sono dedicati a un cineasta naïf allievo di Pasolini (Sergio Citti. Lo straniero del cinema italiano), alla geniale creatività di un truccatore (Un nome nei titoli di coda. Il trucco di Otello Fava) e al più grande artista di teatro italiano (Eduardo De Filippo: teatro, cinema, tv. Viaggio al termine della nottata). Sergio Citti, fratello maggiore di Franco (l’attore prediletto da Pasolini insieme a Ninetto Davoli), è un «sottoproletario digiuno di lettere, arte e cultura» che negli anni Settanta, dopo un lungo sodalizio con Pasolini (che da lui attinge il linguaggio delle borgate romane) esordisce dietro la macchina da presa nei primi anni Settanta: Ostia è il suo primo lavoro, girato con «aspra, quasi punitiva severità, a stacchi come schiaffi che partono lenti e vanno netti allo sguardo». Segue Storie scellerate, scritto da Pasolini, film genuino e gaglioffo nel suo virulento anticlericalismo in cui riecheggiano la vitalità plebea dei sonetti del Belli e l’umorismo acido delle pasquinate. Le opere successive (Casotto, Due pezzi di pane, Il minestrone, Mortacci), orfane del loro maestro e ispiratore tragicamente scomparso, accusano una certa stanchezza, fino all’ultima, originale quanto sgangherata, I magi randagi, girata negli anni Novanta.
Il truccatore Otello Fava è un’altro personaggio singolare e quasi leggendario, dato che percorre mezzo secolo di cinema italiano. Appena ventiseienne, Fava rende più emaciato il volto di Alida Valli in Piccolo mondo antico di Soldati mediante «il sughero di un turacciolo, niente di più, annerito al fuoco di un cerino e adoperato per scurire parti del viso». Nel Dopoguerra, in Europa ’51 di Rossellini, il viso di Ingrid Bergman viene assottigliato «lasciandole però una forte macchia di rossetto sulla carnosità delle labbra». Con Fellini l’arte del make up di Fava raggiunge vertici ineguagliati: memorabile Sandra Milo in Fellini 81/2: «rossetto viola, sopracciglia forti da gatta in calore, veletta con un punto nero (come una sculturina di Medardo Rosso)». Negli anni Settanta, Fava trasforma un semisconosciuto comprimario in un «Mussolini di mezza età con una calotta di plastica per la calvizie e, ancora una volta, sfinando leggermente le guance. Ne venne un duce asceticamente machiavellico», e nel Gesù di Nazareth di Zeffirelli «per la morte di Gesù, spennella Powell di una tinta bianco-verdolina: il colore della morte, sostiene, di quel Caravaggio che era uno dei suoi modelli cromatici e luministici».
Eduardo De Filippo è l’icona immortale del teatro italiano su cui si chiude il libro di De Benedictis: lo studioso rammenta come, in Natale in casa Cupiello, Eduardo crea «la condizione per cui un uomo, col suo linguaggio, va contro la realtà finta e ipocrita degli altri. È il caso di Luca Cupiello, indotto da un delirio di malattia in una condizione che fa dire il vero. In fondo, nello stesso senso disvelante procede il suo allucinato scorgere, nell’amante della figlia, colui che ne è il “vero” marito». Nel cinema, Eduardo, in Sabato, domenica e lunedì, film di fine anni Cinquanta, attua «una sorta di sciopero della parola, echeggiando le voci degli altri, che passano sulla sua maschera stranita e assente. La rivediamo così scarnificata, con un supplemento di onde rugose in fronte per quel sopracciglio alzato tra assorto e risentito».
Per concludere: iconografia di un trentennio di emozioni
L’apparato iconografico che De Benedictis ha voluto allegare al testo è tutt’altro che casuale: una selezione accurata e significante di immagini, fortemente emblematiche ed evocative. Il lampione che taglia in due l’inquadratura di Ladri di biciclette, e le ombre quasi metafisiche, alla De Chirico, disegnate da un balcone sulla parete. La damigiana di Paisà, immobile fra i due marciapiedi, in un campo lungo denso di angoscia per l’invisibile presenza dei cecchini. La voracità quasi animalesca di Sordi mentre ingurgita una forchettata di spaghetti in Un americano a Roma raffrontata alle bocche enormi di orchi scolpiti nel marmo e nella pietra. Ancora un Sordi ludicamente bifolco che fa il gesto dell’ombrello ne I vitelloni contrapposto al signorile distacco di Eduardo intento a predisporre il pernacchio in L’oro di Napoli. Lo strascico nero e tentatore (vera e propria “coda del diavolo”) pendente dalle forme opulente di Anita Ekberg che fluttua sull’acqua della fontana di Trevi in La dolce vita. Infine, il parallelismo prospettico fra il Cristo morto di Andrea Mantegna e il figlio della Magnani che agonizza stretto dalle cinghie del letto di contenzione in Mamma Roma. Fotogrammi che sono anche sensazioni e ricordi di un cinema che un tempo era il più ammirato del mondo, e che in questi ultimi anni un’oscura volontà maligna (annidata nei canali della televisione digitale come i ratti nelle fogne: chi ha orecchie per intendere intenda…) sta lentamente strangolando. «Attenti», aveva profetizzato Pasolini nel corso dell’intervista, l’ultima, concessa a Furio Colombo il giorno prima di morire, «l’inferno sta salendo da voi». E gli schermi televisivi, ancora più piattamente obitoriali nel nuovo design al plasma, sono le porte attraverso le quali quell’inferno continua a penetrare nelle nostre case e nelle nostre menti.
Guglielmo Colombero
(www.bottegascriptamanent.it, anno V, n.43, marzo 2011)
Elisa Guglielmi, Ilenia Marrapodi