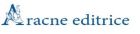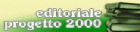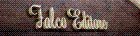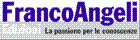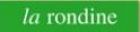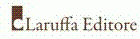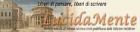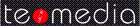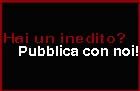Società di prodotti editoriali, comunicazione e giornalismo.
Iscrizione al Roc n. 21969.
Registrazione presso il Tribunale di Cosenza
n. 817 del 22/11/2007.
Issn 2035-7370.
Direttore editoriale: Mario Saccomanno
A. XIX, n. 211, mag. 2025
 Accordi fra Italia e Libia:
Accordi fra Italia e Libia:i loro drammatici effetti
nelle forti testimonianze
di viaggio dei migranti
di Paola Mazza
Per Infinito edizioni il video-documentario Come un uomo sulla terra ,
proiettato in tutta Italia, è in libreria con un testo di approfondimento
Siamo ormai abituati a vedere immagini di imbarcazioni che, stracolme di migranti disumanamente ammassati, approdano sul territorio italiano. Ma tante altre invece non ci pervengono. Sono quelle riguardanti il pre e il post di questi sbarchi. Cosa precede l’arrivo degli immigrati sulle nostre coste? E cosa accade loro una volta giunti in Italia? Spesso ci accontentiamo di quelle immagini senza porci altre domande.
Ma, concentrandoci in particolare sul primo dei due interrogativi: forse accade che i migranti subiscano viaggi stremanti, lunghi anni, di cui finiscono per perdere il controllo? Forse il loro percorso è costellato da disumani trattamenti e violenze psicologiche e fisiche estremamente dolorose? Forse sono pedine di poliziotti e mediatori in mano a regimi dittatoriali che negano i più basilari diritti umani? Forse molti di loro neanche arriveranno, perché lasceranno la vita durante le traversate del deserto o del mare? Forse l’Italia e l’Unione Europea hanno qualche responsabilità rispetto a tali tragedie personali e collettive?
Semmai qualche dubbio dovesse venirci, semmai avessimo la volontà di andare a indagare questi aspetti a noi sconosciuti, perché nessuno possa più dire «non lo sapevo», è stato realizzato il film-documentario Come un uomo sulla terra – di Riccardo Biadene, Andrea Segre e Dagmawi Yimer – e un omonimo testo (Infinito edizioni, pp. 144, € 15,00 – libro più dvd) a cura di Marco Carsetti e Alessandro Triulzi.
Certo ci vorrà coraggio, perché significherà essere spettatori di drammatiche esperienze di vita e perché è più difficile ignorare ciò che si conosce. Scrive però Ascanio Celestini nella sua Prefazione al testo: «Dovremmo avere il coraggio di guardare questo film e non crederci. […] Ma se ci fa venire un dubbio, andiamocelo a togliere».
Le drammatiche conseguenze degli accordi con
Come un uomo sulla terra, come si legge nel retro di copertina, è il documentario «che ha rotto il silenzio sugli accordi tra Italia e Libia e ha svelato le terribili violenze subite dai migranti arrestati e respinti in Libia». Grazie al lavoro dei suoi autori ci sono state presentazioni e proiezioni in città di ogni parte d’Italia e il video è diventato un fondamentale strumento di conoscenza. Attraverso le personali testimonianze dei protagonisti delle migrazioni, rivela infatti le drammatiche conseguenze umane delle politiche di regolazione dei flussi portate avanti dall’Italia e dall’Unione Europea. Mette in luce gli accordi di cooperazione sul controllo delle frontiere sottoscritti con
Scrive nell’Introduzione al libro Christine Weise, presidente della Sezione italiana di Amnesty International, «
Libro e dvd
Abbiamo già trattato il tema parlando in un’altra occasione del documentario. Una recensione sul video è stata infatti scritta da Francesca Rinaldi sulla nostra rivista sorella «Direfarescrivere» (vedi il link www.bottegaeditoriale.it/primopiano.asp?id=99). Un altro articolo invece proponeva l’originale iniziativa – promossa qualche mese fa da “Asinitas onlus”, “ZaLab”, «Fortress Europe» e Infinito edizioni – Natale come un uomo, che aveva lo scopo di “regalare” ai politici italiani una copia del libro e del dvd affinché potessero essere “aiutati” a uscire dalla condizione di ignoranza che li caratterizzava (vedi il link www.bottegascriptamanent.it/?modulo=Articolo&id=764&ricerca=come+un+uomo).
Ritorniamo ancora sull’argomento, purtroppo sempre attuale, segnalando che da qualche mese è possibile trovare in libreria il documentario, accompagnato dal libro e da alcuni extra speciali. Sono infatti contenuti nel dvd, oltre al video principale, L’albero, un cortometraggio di Dagmawi Yimer sulla scuola “Asinitas”; un episodio tratto da Il deserto e il mare, frutto di un laboratorio di video partecipativo di persone richiedenti asilo e rifugiate; Noi difendiamo l’Europa, un radio-documentario di Roman Herzog, e un reportage fotografico di Gabriele Del Grande, entrambi prodotti di un’inchiesta svolta all’interno dei centri di detenzione in Libia nel novembre 2008.
Il “viaggio”
Il video-documentario e la parte centrale del libro raccontano le esperienze di un gruppo di giovani etiopici, alcuni provenienti dal quartiere Kirkos di Addis Abeba, che, dopo aver effettuato diversi ma infelicemente simili viaggi, si sono rincontrati in un corso di Italiano a Roma. Hanno così deciso di raccontare la propria triste esperienza, con la speranza che la loro denuncia possa evitare che altre persone affrontino gli stessi drammi.
I ragazzi, intervistati da Yimer – coautore del documentario, nonché protagonista del “viaggio” – iniziano a rievocare partendo dalla formulazione dell’idea di intraprendere la migrazione. Una decisione che si rivela spesso difficile. Significa infatti lasciare il proprio paese a volte contro il volere della stessa famiglia, a volte incarnandone le speranze di un futuro collettivo migliore.
Raccontano di essere stati ignari, alla partenza, delle terribili vicende che avrebbero dovuto vivere. Immaginavano un viaggio che, seppur difficile, li avrebbe portati direttamente dall’Etiopia – attraverso il deserto del Sudan – alla Libia, e dalla Libia all’Italia. Tuttavia non è stato così e si sono ritrovati a percorrere più e più volte le stesse tratte, in una sorta di continuo «gioco dell’oca».
Accade infatti che i mediatori, pagati per portare le persone sulle coste libiche, non mantengano la propria parola e che i migranti si ritrovino ad essere arrestati. Senza l’ombra di un processo, senza che si chieda loro neanche il nome, vengono deportati dalla polizia libica nei centri di detenzione dove rimangono per giorni, mesi, a volte anni. Condizioni disumane caratterizzano tali carceri: il sovraffollamento che – com’è evidente dal reportage fotografico e dal capitolo Guantanamo Libia di Del Grande – vede la presenza di decine di persone in stanze di pochi metri quadrati; le condizioni igieniche disastrose; il cibo insufficiente e disgustoso; le violenze e le torture, gli stupri alle donne, subiti anche in prima persona da chi racconta.
A “salvarti” arrivano gli intermediari a cui gli stessi poliziotti vendono i migranti per un prezzo di circa 30 dinari a testa e «anche se sei venduto come uno schiavo sei felice di lasciare quel posto». Si richiedono nuovi, inaspettati soldi, per proseguire il viaggio, per essere riportarti a Tripoli e da qui imbarcarsi alla volta dell’Italia. Molti non hanno il denaro e sono costretti a farselo spedire dalla propria famiglia o a lavorare come schiavi per guadagnarlo.
E purtroppo non finisce ancora qui, perché si rischia di essere di nuovo arrestati, di nuovo torturati, di nuovo rivenduti e ricomprati senza sapere se e quando si riuscirà a porre fine a questo orribile gioco. John, uno dei ragazzi intervistati, racconta di essere stato arrestato sette volte, e rivenduto per altre cinque.
Terribili inoltre sono le condizioni dei container, anche questi fotografati da Del Grande, nei quali i migranti vengono trasportati verso le carceri. Spazi strettissimi in cui vengono stipate numerose persone, senza aria se non quella proveniente da piccole finestrelle poste in alto, per lunghissimi tragitti, sotto il sole cocente, «viene loro insegnato a stare incastrati gli uni tra le gambe degli altri […] si vomita, si orina su se stessi […] Ecco come gradualmente ognuno perde il rispetto di sé, l’autostima, il pudore e perfino la vergogna dei propri atti per sprofondare in quell’abiezione e in quella sottostima di sé che rende più facile il controllo».
Quando si riesce a uscire dal circolo di compravendita di mediatori e poliziotti, ci si imbarca alla volta dell’Italia e inizia una nuova terribile tappa. I migranti vengono caricati su piccole barche, in numero maggiore di quanto era stato loro promesso al momento del pagamento, con capitani di fortuna, privi di alcuna indicazione certa e con una vaga idea di dove si trovi l’Italia. Frequenti sono le rotture del motore, la fine della benzina o la perdita della rotta. Si finisce così ad essere naufraghi in mezzo al Mediterraneo. «So di un mio amico diventato pazzo e di un altro alcolizzato. Una volta vissuta un’esperienza del genere la tua mente non riposa».
Il percorso del film
Il libro si presenta come approfondimento del video contenendo interventi, oltre che dei due curatori dello scritto e dei tre autori del documentario, anche dei giornalisti Del Grande e Stefano Liberti e dei critici cinematografici Dario Zonta e Boris Sollazzo.
In una prima parte Triulzi racconta come il documentario e le testimonianze contenute nel libro facciano parte di un progetto più ampio, l’Archivio delle memorie migranti, volto al recupero della memoria e della dignità del percorso migratorio in Italia. Evidenzia inoltre l’intenzione di invertire il tradizionale modo giornalistico di riportare le esperienze altrui, preferendo che siano gli stessi protagonisti a raccontare le proprie vicende attraverso la scelta dell’autorappresentazione.
Carsetti scrive invece della scuola di italiano e dell’Associazione “Asinitas onlus”, luogo di incontro dei protagonisti del documentario e di ideazione, nonché ambientazione, delle sue riprese. L’associazione fa della pratica interculturale un elemento fondante, opponendosi alla diffusa tendenza all’etichettamento attraverso il quale si finisce col perdere la propria identità di uomo acquisendone una di utenti/vittime/rifugiati. «Ci siamo presto resi conto che […] insegnare italiano non era una questione meramente tecnica e non riguardava solo la parola, il prendere parola, ma la costruzione di relazioni affettive all’interno di contesti di socializzazione e costruzione di comunità».
«Come un uomo sulla terra – scrive Segre – nasce dal punto di vista cinematografico da un delicato processo di trasformazione dell’assenza in essenza». Il progetto nasce da un primo lavoro di laboratorio video partecipativo, in collaborazione con “ZaLab”, associazione che fa sua l’idea che il racconto cinematografico e documentario debba fondarsi su percorsi partecipativi dei protagonisti delle storie narrate. Fondamentale a tal fine è la presenza di Yimer che, ricoprendo il ruolo di intervistatore-protagonista, si pone come ottimo mediatore fra i racconti e la telecamera.
Un altro momento importante del percorso di realizzazione del documentario è inoltre presentato nell’ultimo capitolo del libro in cui Triulzi racconta della proiezione del video nel quartiere di Kirkos, dinanzi alle famiglie di molti dei protagonisti. «Non è stata una scelta facile […] proiettare il film indicava la scelta dei ragazzi di Kirkos di uscire dai silenzi e dalla comunicazione rituale del “va tutto bene”». Ma questo aveva un significato profondo per i protagonisti che hanno deciso di affrontare il proprio dolore, che nasce col raccontare esperienze drammatiche, e la sofferenza profonda delle famiglie, rese consapevoli delle atrocità che i loro cari erano stati costretti a subire. Il «grande obbligo morale – scrive Yimer – di raccontare ciò che abbiamo vissuto: rivelare quella realtà per provare a salvare chi ancora sta subendo quelle violenze e quelle discriminazioni».
Paola Mazza
(www.bottegascriptamanent.it, anno IV, n. 33, maggio 2010)
Ilenia Marrapodi