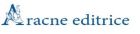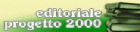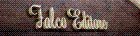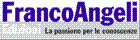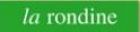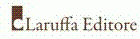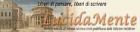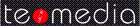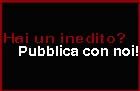Società di prodotti editoriali, comunicazione e giornalismo.
Iscrizione al Roc n. 21969.
Registrazione presso il Tribunale di Cosenza
n. 817 del 22/11/2007.
Issn 2035-7370.
Anno II, n° 12 - Agosto 2008
La città di Napoli e le sue fantasiose arti culinarie
di Arianna Calvanese
Un libro che raccoglie i cibi e le tradizioni tipiche che ravvivano la città.
Un esilarante ricettario fuori dalle righe che custodisce gustosi segreti
Cucinare non è soltanto un atto per sfamare il proprio essere, ma un modo per esprimere se stessi, per creare, per sperimentare, per riunire tutti allo stesso tavolo. Il profumo emanato da una pietanza spesso riporta la mente a momenti felici della propria esistenza. La cucina casereccia è spesso un’arte tramandata da madre in figlia che racchiude in sé i caratteri distintivi della terra di origine. Anche se i tempi in cui viviamo sono estremamente frenetici e, di conseguenza, si è spinti sempre più verso un tipo di cucina veloce e i fast-food, bisogna ben guardarsi dal pericolo del dimenticare il piacere del mangiare insieme.
Patrizia Rotondo Binacchi nel suo libro di cucina, A Napoli mentre bolle la pentola, (Pellegrini, pp. 128, € 10,00) riporta antiche ricette della tradizione che hanno il sapore della Napoli antica. L’autrice ricorda che per i napoletani il cibarsi è uno spettacolo ricco di colore. La cucina napoletana è tanto povera quanto genuina, proprio come le osterie in cui le gustose pietanze sono servite. Nei quartieri abitati dalla classe operaia le strade sembrano consistere in un grande ristorante all'aperto. Se non un ristorante, strade piene comunque di negozi di generi alimentari, i cui prodotti spesso arrivano ad occupare metà di esse. Grandi forme di formaggio bianco, quarti di manzo pendenti al sole con mosche ronzanti intorno, chioschi di gelati e sorbetti al limone, adornati con effigi di madonne e fiori, tutti mettono in mostra la loro merce. L’autrice ricorda che: «Gli odori, i rumori, i sapori dei tempi che furono non torneranno più perché sono elementi cronologici di nostalgia ma nessuno potrà mai cancellare l’immagine e l’odore dell’uomo col carretto, con i polpi lessi nel pentolone di rame, con l’acqua nera di pepe e di mezzi limoni, che girava nei quartieri gridando “o purpo” (il polpo lesso)».
La cucina napoletana lavora su antiche ricette, su piatti rituali, su pratiche radicate nell'uso e le ha composte con le nuove esigenze della società moderna trasformando e modificando molti sapori. Si può parlare di una cucina napoletana perché, nonostante trasformazioni e innovazioni, permangono ancora un insieme di procedure, un repertorio di piatti, di sapori, valori rituali che hanno attraversato molti secoli e che contribuiscono ancora a delineare, in modo inoppugnabile, una precisa identità. Le cucine regionali non devono essere considerate come cucine inferiori. Esse sono, invece, serbatoi di un repertorio antico e nuovo e che rappresentano i pilastri della cucina italiana.
La gastronomia partenopea, in quanto mediterranea, è stata sicuramente influenzata dai vari popoli (Fenici, Greci, Arabi, Francesi ecc.), che, da tempi lontani ad epoche recenti, ebbero frequenti rapporti con le nostre regioni costiere. E infatti molti piatti della nostra cucina di oggi, ci vengono direttamente dal passato (gli struffoli e il capretto con uova e piselli dalla Grecia, l'utilizzo dell'aglio, dell'olio e del basilico dalla Provenza). A Napoli e in Campania le testimonianze del passato splendore di città europea e di capitale si manifestavano anche in cucina. L'influsso delle culture è stato adattato alle esigenze, al gusto, al carattere del popolo. Ecco perché la cucina regionale campana è a volte ricca e fastosa (timballo di maccheroni, sartù di riso) e a volte fantasiosa e povera (caponata, pizza). In sostanza i napoletani sono stati sempre capaci di nutrirsi gustando anche una sola fetta di pane condita con un filo d'olio e un pizzico di sale, mentre era festa grande quando potevano dare fondo a ricchi piatti. Ecco perché la pizza è nata a Napoli e non altrove. Oggi la pizza, ormai diffusa in tutto il mondo, è elevata a rango di stuzzichino, di "sfizio". Fino a non molto tempo fa costituiva il pasto quotidiano per una grandissima parte di napoletani.
Un assaggio delle ricette
Chi siede ad una tavola napoletana non si aspetti di cominciare con un leggero antipasto.
La fantasia dei napoletani si scatena con gli antipasti, che a volte diventano il piatto forte del pranzo, allora la tavola sarà sommersa di piattini pieni di assaggi variopinti che è una festa per gli occhi: bocconcini di mozzarella di bufala di Aversa, fettine di salame piccante, olive farcite di peperoncino, carciofini sott’olio, bruschette con pomodorini, frittelle di alghe, paste cresciute, cicenielle in pastetta, crocchè di patate, palle di riso, zucchine e melanzane a scapece, melanzane indorate e fritte, il tutto in quantità minima, giusto per stuzzicare l’appetito e “aprire lo stomaco”.
Dopo l’antipasto bisogna vedere se si prosegue con i primi di pesce o di carne e allora o vermicelli con le vongole o spaghetti con le cozze o linguine ai frutti di mare. La cipolla a Napoli deve stare lontana dal pesce. Se al pesce si preferisce la carne allora parliamo del famoso ragù della mamma, a cui bisognerebbe dedicare un capitolo intero. Per questo motivo mi limito a dire che il ragù o è di carne di vitello o di maiale (salsicce o/e tracchiulelle) o di entrambi; si possono aggiungere anche le braciole con il ragù e si condiscono gli ziti spezzati, gli gnocchi, i paccheri (aggiungendo della ricotta stemperata in un po’ di ragù) o lo si usa per condire la pasta al forno e le lasagne di carnevale. Gli ziti si condiscono anche con la “genovese”, sugo di carne con tantissime cipolle, almeno un paio di chili, che si consumano insieme alla carne diventando una crema marroncina profumatissima… Ovviamente l’autrice non poteva omettere nel suo libro la ricetta del “re dei dolci napoletani” il babà. Non esiste alcuna parola o perifrasi che sia in grado di descrivere degnamente questa leccornia sublime. Per questo motivo l’unica cosa da fare è cucinarlo, inebriarsi con il suo odore paradisiaco e assaporare ogni singolo boccone.
Cibo e dialetto e lotto
Dall’excursus culinario di Patrizia Rotondo Binacchi emerge l’identificazione sociale del popolo partenopeo, caratterizzato da espressioni e tradizioni antiche, oltre che scaramantiche. L’itinerario “in cucina” dell’autrice offre dunque, uno spaccato di vita popolare e invita a riflettere sulle origini della comunità.
I napoletani infatti hanno innumerevoli espressioni in cui il carattere è associato ad uno stato fisico più che mentale, tutte ricche di sfumature la cui traduzione in italiano, a volte esportata nel linguaggio corrente nazionale proprio come la pasta e la pizza a tavola, non rende spesso esattamente l'idea di ciò che in realtà si vuole rappresentare. Proprio per sottolineare il vincolo esistente fra la lingua regionale e il cibo, un capitolo del libro è dedicato a simpatici modi di dire napoletani, tradotti in italiano. Ad esempio, "Si nu’ babà” si dice a qualcuno quando vogliamo trasmettergli tutto il nostro carnale sentimento, tutta la nostra stima e affetto rinnovati a una persona già conosciuta, ma evidentemente non ancora del tutto apprezzata per quello che realmente essa possa significare, a una persona che continua a sorprenderci benevolmente per le sue capacità e le sue doti nascoste.
Poiché l’autrice del libro ha cercato di scrivere non solo un testo che [non]parlasse solo di cucina, ma anche che racchiudesse le usanze napoletane più diffuse, non poteva mancare un capitolo dedicato al gioco del lotto e all’interpretazione dei sogni che per i napoletani non è soltanto un modo per guarire la propria psiche, ma anche un mezzo per tentare la fortuna. Il linguaggio dei sogni non è facile da comprendere perché si basa su immagini e simboli molto familiari ad un uomo dell'antichità, piuttosto che ad un uomo contemporaneo, dalla mentalità scientifica e razionale, ma ancora oggi, nei nostri discorsi, spesso ricorriamo ad immagini tradotte in metafore verbali. Queste e altre espressioni del genere magari non possiederanno grande accuratezza scientifica, ma certo possiedono una grande immediatezza emotiva. Da secoli i napoletani associano i sogni al gioco del lotto. Il termine cabala o qabbalah è legato alla smorfia e per alcuni la stessa origine della smorfia è legata alla cabala.
Ma cos’è la cabala? Fa parte della tradizione ebraica e significa previsione o divinazione, infatti per la cabala ogni parola, lettera o segno ha un significato. Secondo la cabala anche il mondo non è altro che un insieme di simboli da codificare. Per la cabala tutto ha un numero, dalle lettere dell’alfabeto ai giorni della settimana, dai segni dello zodiaco ai mesi dell’anno. Tutto è riscontrato nella cabala. I napoletani, in maniera più o meno consapevole, adottano questa antica tradizione ebraica nella speranza di essere baciati dalla fortuna.
Arianna Calvanese
www.bottegascriptamanent.it, anno II, n. 12, agosto 2008)