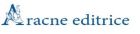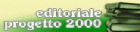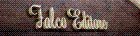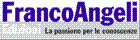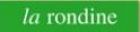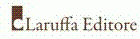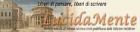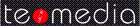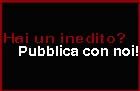Società di prodotti editoriali, comunicazione e giornalismo.
Iscrizione al Roc n. 21969.
Registrazione presso il Tribunale di Cosenza
n. 817 del 22/11/2007.
Issn 2035-7370.
Direttore editoriale: Graziana Pecora
Anno VIII, 86, ottobre 2014
 Internet
Internetper umanisti
di Selene Miriam Corapi
Per i tipi di Apogeo,
una guida spiega
il web ai letterati
Cosa lega i termini “informatica” e “umanista”? Come ben sappiamo, il computer negli ultimi anni ha acquisito un ruolo notevole nella nostra vita, tale da poter affermare con certezza che non potremmo vivere senza. La “macchina”, con l’avvento di Internet, non solo si è evoluta nelle sue funzionalità di base, ma a poco a poco si è infiltrata, come acqua nel terreno, in tutti i settori lavorativi e nella quotidianità. Grazie al web è possibile fare di tutto nel minor tempo possibile e per qualsiasi informazione basta un semplice click del mouse. La tecnologia ha apportato cambiamenti notevoli, agevolando, talora complicando, le nostre abitudini. «Internet ha radicalmente cambiato il modo in cui le informazioni vengono archiviate, distribuite e fruite. Oggi nessuno può fare a meno della Rete e del Web, e questo è vero soprattutto nel mondo del lavoro. Una quantità interminabile di dati è affidata a Internet e finisce sugli schermi dei computer in forma di parole, immagini, suoni e video. Ogni giorno. La capacità di orientarsi in Rete è quindi imprescindibile in un mondo dove la comunicazione è una necessità vitale».
Perché dunque non adoperare la tecnologia informatica anche nell’ambito umanistico?
Il computer permette di catalogare, visionare, reperire tutte le informazioni necessarie; ma per attuare ciò bisogna saper usare questa portentoso strumento. Purtroppo esiste un pregiudizio di fondo in molti umanisti: «il computer è ancora inteso come l’evoluzione della macchina da scrivere, Internet è un’icona sul desktop da cui scaricare musica e film».
Fabio Brivio, nel suo L’umanista informatico. Xml, Html, Css, Sql, Web, Internet, database, programmazione e Google per le Scienze umane (Apogeo, pp. 150, € 7,90), propone con analisi dettagliata un manuale-guida per mezzo del quale l’umanista può comprendere i concetti chiave del mondo informatico di cui poter facilmente disporre nel proprio settore; il testo inoltre è corredato da esempi che consentono al lettore di apprendere la teoria e, al contempo, di verificare il risultato pratico.
L’architettura del web
Il web nacque agli inizi degli anni ’90 del secolo scorso nei laboratori del Cern (Consiglio europeo per la ricerca nucleare), ideato da Tim Berners-Lee, che inventò il linguaggio Html con cui scrivere le pagine web, rendendo così possibile, il 25 dicembre 1990, la comunicazione tra due computer via Http.
In realtà concettualmente il web ha origini più retrodatate e si lega ad altre due figure: Vannevar Bush e Ted Nelson; il primo nel 1945 pubblicò un articolo in cui teorizzava una macchina (il Memex) in grado di archiviare, catalogare testi e documenti in una struttura reticolare, per poter sistemare il sapere, in particolar modo le conoscenze scientifiche; il secondo coniò il termine “ipertesto” e nel 1960, a capo del Progetto “Xanadu”, operava per creare ipertesti all’interno di reti di computer. «Tim Berners-Lee ha così raccolto l’eredità e le suggestioni di questi suoi predecessori, trasformandole in realtà».
Il web è una rete di computer su cui sono ospitati documenti ipertestuali; la comunicazione tra le macchine è regolata dal protocollo Http. I computer all’interno della rete assumono il ruolo di client o di server: il primo tipo riguarda i computer e i relativi programmi da cui si parte nella ricerca nel web; il secondo riguarda i computer che ospitano i siti o altri documenti; «il client fa una domanda e il server risponde. Questa è la logica su cui è basata la comunicazione in Rete».
Il client web è il browser, termine derivato dal verbo inglese to browse, “sfogliare”. Tra i più famosi citiamo: Internet Explorer di Microsoft, Mozilla, Firefox e Chrome di Google.
Internet
La caratteristica di Internet è quella di non avere un centro, «la sua struttura è costruita in modo tale che anche in caso di danneggiamento di una sua parte, la Rete rimane attiva e funzionante. Non è cioè possibile “spegnere” Internet, ma è possibile spegnere alcuni dei computer che ne fanno parte o, impedire la comunicazione tra due o più macchine».
Molto spesso i termini Internet e web vengono usati come sinonimi, ma non c’è «niente di più errato. Internet – “la rete delle reti” – è una grande “ragnatela” di computer sparsi per il mondo e connessi in diversi modi. Le modalità in cui questi computer comunicano sono differenti e basate su diversi protocolli», ossia le regole che «guidano lo scambio di informazioni tra macchine diverse».
Sfatare un falso mito
Le informazioni che oggi vengono gestite ormai interamente in formato digitale possono essere utilizzate e organizzate dall’umanista, in quanto per la sua formazione «è la persona meglio preposta a guardare criticamente le informazioni, a metterle in relazione, a ricavare informazione da informazione. Lo scoglio da superare sta tutto nel conoscere gli strumenti e le logiche attraverso cui le informazioni o dati, vengono gestite». L’umanista molto spesso è considerato come un individuo che «parla, scrive e magari pensa pure bene, ma a conti fatti è privo di reali abilità pratiche e quindi produttive. Nel mondo del lavoro servono tecnici, informatici in particolar modo. Alla gente che sa si preferisce la gente che sa fare. E l’umanista troppo spesso sa, ma non sa fare. O almeno così si pensa». L’informatica è uno strumento al servizio dell’uomo e, così come per tutti gli strumenti in genere, il suo apprendimento passa attraverso la fase della applicazione pratica; l’autore ci invita a considerare le lingue dell’informatica come strumenti e, così come per le altre lingue, il miglior modo per apprendere è quello di studiarle.
L’umanista in quanto studioso delle grammatiche delle più complicate lingue umane e delle strutture logiche del pensiero può facilmente superare e sfatare questo mito, così che, in virtù delle conoscenze e della elasticità mentale, è in grado di apprendere i linguaggi informatici e piegarli al proprio servizio meglio di chiunque altro.
Selene Miriam Corapi
(www.bottegascriptamanent.it, anno VIII, n. 86, ottobre 2014)
Francesca Buran, Ilenia Marrapodi, Pamela Quintieri, Francesco Rolli, Fulvia Scopelliti
Simona Baldassarre, Maria Laura Capobianco, Maria Assunta Carlucci, Alberto Cazzoli, Guglielmo Colombero, Selene Miriam Corapi, Veronica Di Gregorio Zitella, Giacomo Dini, Riccardo Fiorenza, Maria Francesca Focarelli Barone, Vilma Formigoni, Federica Lento, Chiara Levato, Giuseppe Licandro, Flavia Maccaronio, Irene Nicastro, Maristella Occhionero, Giusy Patera, Stefania Pipitone, Luciana Rossi, Martino Santillo, Maria Saporito, Paolo Veltri, Andrea Vulpitta, Carmine Zaccaro
Denise Amato, Selene Miriam Corapi, Vilma Formigoni, Aurora Logullo, Rosina Madotta, Manuela Mancuso, Ilenia Marrapodi, Pamela Quintieri, Francesca Rinaldi, Francesco Rolli, Fulvia Scopelliti