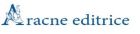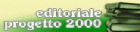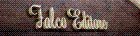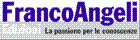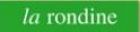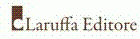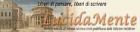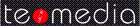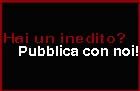Società di prodotti editoriali, comunicazione e giornalismo.
Iscrizione al Roc n. 21969.
Registrazione presso il Tribunale di Cosenza
n. 817 del 22/11/2007.
Issn 2035-7370.
Direttore editoriale: Graziana Pecora
Anno VIII, 86, ottobre 2014
 Sopravvivere al sisma.
Sopravvivere al sisma.Una tragedia italiana
di Federica Lento
La situazione economica e sociale d’Aspromonte:
da Nuove edizioni Barbaro, un libro di inizio ’900
Nel 1908, tra Messina e Reggio Calabria si verificò un catastrofico sisma. Erano le cinque e ventuno minuti del 28 dicembre quando, per trentasette interminabili secondi, il terremoto provocò un numero altissimo di vittime e danni. Si trattò della più grave catastrofe naturale in Europa. In seguito al sisma, il giornalista piemontese Giovanni Cena pubblicò sul periodico Nuova Antologia del 16 gennaio 1909 un reportage dal titolo Lungo le rive della morte, in cui descrisse, tra distruzione, lacrime, preghiere e morte, la terribile vicenda. Anche la nascita dell’Associazione “Animi", fondata nel 1910, elaborò un concreto intervento fatto di racconti dei sopravvissuti e aiuto alle popolazioni colpite dal sisma. Di quell’associazione facevano parte Giovanni Malvezzi e Umberto Zanotti Bianco, i quali hanno vissuto, analizzato e descritto la situazione economica e culturale in quella parte di Meridione in seguito al terremoto nel saggio L’Aspromonte Occidentale (Nuove edizioni Barbaro, pp. 180, € 12,00).
L’inchiesta per dare voce alla paura della gente
Il volume racconta la situazione di una terra dilaniata dal terremoto e il dolore di gente disorientata e spaventata, indebolita, nella sua già precaria condizione, da una calamità naturale tanto impetuosa. L’inchiesta attraversa i territori che vanno dalla vallata del Formano alla fiumara di Sant’Agata, comprendendo la regione occidentale dell’Aspromonte e poco meno della metà della provincia di Reggio Calabria, nello specifico trentasei comuni. Un territorio completamente distrutto in cui risuona il lamento di chi ha perduto tutto, anche quel poco che, con sacrificio, era riuscito ad avere in una terra sfavorevole. Così, dalla Prefazione del testo: «Ricordo una notte passata sull’Aspromonte: una notte estiva dai pochi grandi astri lucenti, dai possenti venti meridionali profumati dal sonno divino delle campagne lontane. Ricoverati in una baracca rattristata dal lamento monotono d’un bimbo malato che si confondeva col cigolìo delle assi sconnesse, ascoltavamo, avvolti quasi nelle tenebre, storie di miserie e d’abbandoni che, come reiterati lamenti, uomini e donne ci narravano a capo chino, con voce lenta e fioca, appena tremante di lacrime quasi che il pianto venisse da lontano! E pareva che tutti i dolori, tutte le agonìe del gran cuore di quei monti selvaggi e delle lande remote, protetti dalle pallide ombre della notte passassero innanzi ai nostri occhi smarriti nelle tenebre del futuro ignoto. Ricorderò sempre la sensazione paurosa più che la morte, di quelle vite perdute nella terribile vastità dell’infinito! Fu allora che ci promettemmo di seguirle, povere anime, nelle tenebre e nel dolore!…».
L’economia della regione
L’unica fonte di guadagno del territorio era data dall’agricoltura: ulivo, agrumi, vite, patate, grano rappresentavano spesso la sola forma di sussistenza della popolazione locale. Per questo motivo, osservano gli autori, in un territorio dove si riscontravano difficoltà sia nel commercio sia nei trasporti, il credito doveva essere rivolto al miglioramento delle condizioni agricole e dei collegamenti commerciali grazie ad un potente intervento dello stato. Lo sviluppo della rete stradale costituiva una condizione imprescindibile di progresso: «Sappiamo che la elevazione sociale è legata principalmente ai frequenti contatti con i circonvicini e al confronto delle idee e delle iniziative con gli altri gruppi urbani. Anche il sentimento della solidarietà prende consistenza dalla vicinanza e dal reciproco influsso dei propri simili».
La debole istruzione in Calabria
Il secondo grande neo della regione era rappresentato dall’apatia e dal fatalismo intellettuale degli abitanti del luogo, dal divisionismo della popolazione, dalla «malattia della volontà» di gente rassegnata ad una condizione di non vita, avallata dall’assenza quasi totale della scolarizzazione. «Piglia u mundu comu veni» è il detto popolare che esprime lo stato di rassegnazione e la mentalità fatalistica che guidava l’operato della gente calabrese e dei suoi amministratori. L’analfabetismo, l’indifferenza per la cultura, la mancanza di iniziative private, le condizioni disastrose delle scuole e l’assenza di personale docente, emigrato dopo il sisma, avevano indebolito una popolazione già senza grandi risorse. L’incremento scolastico, dunque, doveva rappresentare l’altro fattore di evoluzione popolare.
L’analisi di Malvezzi e Zanotti Bianco mette in evidenza il contrasto della vita sociale nella prima decade del secolo con la bellezza ed opulenza del «territorio, uno dei più incantevoli d’Italia». Il loro lavoro è ancora attuale; ha il merito di far scoprire nuove informazioni su un territorio spesso poco considerato e contemporaneamente fornisce stimoli illuminanti che, a partire dalla grande tragedia del sisma, dovrebbero essere considerati per risolvere i persistenti problemi di quelle terre.
Federica Lento
(www.bottegascriptamanent.it, anno VIII, n. 86, ottobre 2014)
Francesca Buran, Ilenia Marrapodi, Pamela Quintieri, Francesco Rolli, Fulvia Scopelliti
Simona Baldassarre, Maria Laura Capobianco, Maria Assunta Carlucci, Alberto Cazzoli, Guglielmo Colombero, Selene Miriam Corapi, Veronica Di Gregorio Zitella, Giacomo Dini, Riccardo Fiorenza, Maria Francesca Focarelli Barone, Vilma Formigoni, Federica Lento, Chiara Levato, Giuseppe Licandro, Flavia Maccaronio, Irene Nicastro, Maristella Occhionero, Giusy Patera, Stefania Pipitone, Luciana Rossi, Martino Santillo, Maria Saporito, Paolo Veltri, Andrea Vulpitta, Carmine Zaccaro
Denise Amato, Selene Miriam Corapi, Vilma Formigoni, Aurora Logullo, Rosina Madotta, Manuela Mancuso, Ilenia Marrapodi, Pamela Quintieri, Francesca Rinaldi, Francesco Rolli, Fulvia Scopelliti