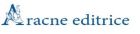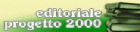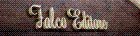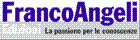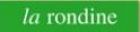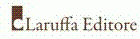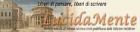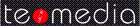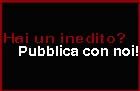Società di prodotti editoriali, comunicazione e giornalismo.
Iscrizione al Roc n. 21969.
Registrazione presso il Tribunale di Cosenza
n. 817 del 22/11/2007.
Issn 2035-7370.
Direttore editoriale: Mario Saccomanno
A. XIX, n. 211, mag. 2025
 Paesaggio, arte, ricerca:
Paesaggio, arte, ricerca:la ricchezza mai goduta
di Aurora Logullo
Valore e degrado dei beni storico-artistici italiani:
da Rubbettino, una proposta per la loro salvezza
Sono passati tre anni da quando la notizia del crollo della Schola Armaturarum Iuventutis Pompeianae, l’armeria dei gladiatori di Pompei, fece il giro del mondo suscitando l’indignazione di politici, di addetti ai lavori e di tutto il resto della popolazione dentro e fuori dai confini dell’Italia. Da allora la situazione del sito archeologico non è migliorata, anzi i cedimenti sembrano quasi all’ordine del giorno e le azioni intraprese dai vari governi degli ultimi anni appaiono dispendiose e poco risolutive. E se Pompei piange, altrove certo non si ride. Anche la monumentale Reggia di Caserta scricchiola ed è costretta alla chiusura di alcune sale, mentre, solo di recente, dopo ben quattro anni passati in un umiliante “riposo del guerriero”, i Bronzi di Riace sono finalmente ritornati nel museo che da sempre li ospita. E finalmente in piedi.
Possibile che in Italia, dove sono localizzati il maggior numero di siti considerati patrimonio dell’umanità, lo stato dei beni culturali sia così drammatico? Si tratta di una situazione senza via d’uscita? Il governo, il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, le soprintendenze cosa fanno?
Luca Nannipieri nel suo ultimo lavoro, Libertà di cultura. Meno Stato e più comunità per arte e ricerca (Rubbettino, pp. 160, € 10,00), analizza proprio lo stato del patrimonio culturale italiano e delle leggi a esso legate, sviluppando una soluzione al problema fortemente provocatoria.
Patrimonio, paesaggio e cultura: realtà in movimento
Partendo da un’attenta analisi della legislazione italiana legata al mondo dei beni culturali, Nannipieri ripercorre in breve la storia dei più importanti monumenti nazionali e internazionali.
Ecco dunque che il lettore, grazie anche allo stile limpido e alla scelta di ricorrere a un lessico chiaro e non troppo specialistico, riesce a immergersi nel passato del nostro patrimonio culturale, scoprendone spesso macchie nere e paradossi: il Pantheon, luogo di culto per gli antichi Romani, trasformato in basilica cristiana e poi spogliato da Urbano VIII; il Partenone, passato da tempio greco a chiesa cristiana, poi a moschea e infine ad arsenale; l’Abbazia di Montecassino, importante centro di tradizione manoscritta, rasa al suolo durante la Seconda guerra mondiale perché considerata covo dei tedeschi. Ciò che all’autore preme sottolineare attraverso i numerosi esempi è la pluralità e la relatività dei concetti di patrimonio, paesaggio e cultura in rapporto alle variabili spazio e tempo: «non c’è un patrimonio della Nazione da difendere, non c’è un patrimonio generico e aleatorio da preservare, ma sono le singole comunità, i singoli poteri, le mode, le tendenze, le memorie, gli interessi, che incidono su queste comunità, a definire passo passo cosa sia patrimonio. Saranno loro a tutelare questo oggetto a discapito dell’altro, a preservare un tempo della storia a discapito di un altro, a conservare una serie di manufatti, opere ed edifici mentre altri verranno fagocitati, rivisti, distrutti o dispersi». Non esiste un bene o un luogo di cultura di per sé, ma esistono solo le attenzioni che la comunità gli conferisce per il suo valore identitario: «ci sono luoghi cioè che per una comunità sono più luoghi di altri: in loro secolarmente si è condensato un valore più ampio di quanto non lo sia la loro fisica concreta struttura. Questa “intensità” di senso non ha una parola che la racchiude, ma ha parole che le si avvicinano: la memoria, l’identità, l’affetto». Pur sottolineando il valore simbolico che il patrimonio culturale può assumere, l’autore nega la sua assolutezza; esso appare piuttosto strettamente legato alla comunità di appartenenza: pertanto potrebbe essere distrutto da un gruppo rivale, come è successo ai templi pagani a opera dei Cristiani o alle grandi statue dei Buddha di Bamiyan, in Afghanistan, fatte esplodere dagli jihadisti.
Meno stato, più comunità
Nannipieri, che si occupa di beni culturali su il Giornale, ma è attivo anche su Libero, Europa e La Nazione, è il direttore del Centro studi umanistici dell’Abbazia di San Savino, un centro di ricerca per lo studio del patrimonio storico-artistico in stato di degrado, incarico che gli ha consentito di verificare l’importanza del rapporto tra comunità e patrimonio culturale. La riflessione sulla pluralità di quest’ultimo costituisce il punto di partenza della sua proposta rivoluzionaria, per recuperare lo stato della cultura e dell’arte in Italia; teoria che, seppur anticipata nella prima parte del saggio, è apertamente illustrata solo a partire dal quinto capitolo: «non vi può essere una legislazione che definisce cosa è patrimonio da conservare da cosa non lo è; non vi può essere uno Stato o non vi possono essere Nazioni che decidono dall’alto della loro autorità cosa e come si debba preservare». Andando avanti dimostra quindi, con profondo rigore e attenzione, come la riscoperta del patrimonio culturale vada di pari passo con una modifica della Costituzione e con una presa di distanza dai modelli europei – considerati migliori perché artefici di maggiori finanziamenti a favore del settore della ricerca e della cultura – così da favorire un processo di delocalizzazione del bene culturale, sia facendo regredire il ruolo dello stato, attraverso l’abolizione delle soprintendenze e degli istituti centrali per le biblioteche e per il restauro, sia facendo emergere il desiderio e la passione del singolo e della comunità, nutrimento fondamentale della cultura. La proposta diventa quindi l’occasione di una rivendicazione di libertà: «liberi di essere diversi significa liberi di poter familiarizzare, trattare e condividere il patrimonio come noi vogliamo, non come ci viene richiesto, sapendo che dopo di noi, o su iniziativa di noi stessi, si potrebbe in un secondo momento decidere diversamente, rivedere le nostre scelte».
Un cambiamento radicale, dunque, che mette in discussione la percezione tradizionale del patrimonio storico-artistico e della sua conservazione e che tuttavia viene illustrato secondo una logica stringente e allo stesso tempo con grande naturalezza: l’autore, difatti, pur essendo profondamente consapevole dell’eccezionalità della proposta avanzata e delle polemiche che attirerà, mantiene un tono pacato in tutta la trattazione, preferendo lasciare ai numerosi esempi citati il compito di mostrare al lettore l’evidenza della propria riflessione.
Aurora Logullo
(www.bottegascriptamanent.it, anno VIII, n. 81, maggio 2014)
Ilenia Marrapodi