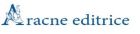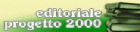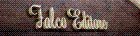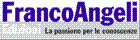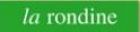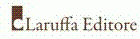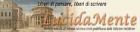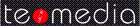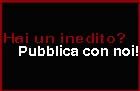Società di prodotti editoriali, comunicazione e giornalismo.
Iscrizione al Roc n. 21969.
Registrazione presso il Tribunale di Cosenza
n. 817 del 22/11/2007.
Issn 2035-7370.
Direttore editoriale: Graziana Pecora
Anno VIII, n 79, marzo 2014
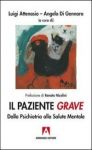 Psichiatria,
Psichiatria,studi e cure
di Francesca Erica Bruzzese
Nuove metodologie
per guarire la mente,
da Armando editore
Il problema della salute mentale, assieme alla tematica ad esso inevitabilmente correlata dei cosiddetti “matti”, è stato ed è tuttora spesso visto come una piaga della società il cui rimedio più spedito, e concepito come unico possibile, è la clinica psichiatrica. Se i manicomi, in Italia, hanno conosciuto la chiusura in seguito alla legge 180 promossa nel 1978 da Franco Basaglia, non è ancora tuttavia superata l'idea di “manicomialità”, che consente l’attuale presenza nel nostro paese di numerosi ospedali psichiatrici giudiziari (Opg).
Ma il nocciolo della questione, come sottolinea il noto filosofo Pier Aldo Rovatti in un articolo apparso sulla versione on line de la Repubblica il 29 marzo 2013, non è rappresentato solo dalla persistenza di questi manicomi giudiziari e dalla mancata conversione in “comunità protette”, ma anche dalla detenzione a lungo termine dei pazienti, spesso senza possibilità di riabilitazione e reintegrazione nel tessuto sociale, né di barlume di guarigione, che, come annota lo stesso Rovatti, «non significa solo trovare la giusta diagnosi del disturbo e una soddisfacente risposta farmacologica. Ma vuol dire soprattutto riemergere da una condizione di non-soggettività a una condizione di soggetti, liberi e dotati di diritti sociali».
Su quest’ultima questione, e sulle possibili piste da seguire per realizzare obiettivi concreti di guarigione di pazienti psichiatrici, Luigi Attenasio – direttore del Dsm (Dipartimento di Salute mentale) della Asl Roma C, nonché allievo dell'affermato basagliano Agostino Pirella – e Angelo Di Gennaro – psicologo presso il medesimo dipartimento – portano avanti nel volume Il paziente grave. Dalla Psichiatria alla Salute Mentale (Armando editore, pp. 380, € 29,00) il tentativo di mettere in atto nuovi percorsi terapeutici per affrontare le situazioni problematiche relative ai cosiddetti “pazienti gravi”, cercando di coinvolgere, sensibilizzare e responsabilizzare la collettività circa l’operato dei servizi afferenti a un Dsm.
Gli atti di un innovativo corso-progetto
Il volume, le cui conclusioni non costituiscono la sistematizzazione di risultati definitivi, ma si propongono di rimettere in discussione gli effetti derivanti dai capisaldi della “psichiatria accademica”, è una raccolta metodica e precisa degli atti e delle discussioni in seno a un vero e proprio progetto di ricerca dipartimentale, Analisi dei percorsi terapeutici del Dsm a partire dalla storia e definizione dei cosiddetti pazienti gravi , svoltosi nell’arco degli anni 2001-2003 presso la Asl C di Roma, a cura di un gruppo interdisciplinare di operatori appositamente istituito. Gli operatori – psichiatri, psicologi, assistenti sociali ed educatori professionali facenti capo ai relativi enti Centro di salute mentale, Centro diurno, Comunità terapeutica e Servizio psichiatrico diagnosi e cura – sono gli effettivi esecutori del progetto, guidati e sostenuti da esperti affermati nel campo, quali Agostino Pirella, Cristiano Castelfranchi, Vieri Marzi, Paolo Henry, Guido Pullia.
Il progetto di ricerca è dedicato per l’appunto al “paziente grave”, partendo dalla sua definizione e identificazione e giungendo, attraverso il lavoro specifico degli operatori, alla formulazione di risposte concrete scevre il più possibile dalle procedure e dagli automatismi istituzionalizzati. Coerentemente con l’insegnamento di Basaglia, il principio su cui si basa il suddetto lavoro è quello secondo cui, per aiutare una persona problematica, non basta internarla e somministrarle una semplice dose giornaliera di psicofarmaci. È invece necessario entrare nell’universo di chi sta male, scoperchiarne il mondo sociale e familiare, creare per lui degli spazi soggettivi in cui gli sia possibile esprimere la propria sofferenza, ristabilire l’importanza dell’elemento affettivo. Scrivono i curatori: «Pensiamo che imparare dall’esperienza e dalla vita (affermazione tutt’altro che ovvia) richieda alcuni presupposti, tra i quali: coinvolgimento attivo e responsabile di tutti coloro che sono interessati al processo terapeutico […]; atteggiamento fondamentalmente positivo nei confronti della possibilità di cambiamento; capacità di relazione reciproca con la diversità fino a lasciarsene formare e trasformare».
Per fare ciò sono indispensabili il coinvolgimento e la collaborazione di tutti gli enti sopra citati. Collaborazione e coinvolgimento che si realizzano effettivamente e costituiscono la vera componente innovativa di questo progetto, che va quindi a perseguire una doppia finalità: proporre come laboratori di ricerca i servizi del dopo 180; costruire un sapere che nasca anche dalle relazioni reciproche, sia tra gli stessi servizi, sia tra servizi e pazienti, «nella convinzione che la mente non sia del tutto riconducibile all’interno della testa ma che essa è nel rapporto con le persone». Questo si configura, quindi, non solo come uno svecchiamento della prospettiva manicomiale consolidata, senza tuttavia giungere ad una normalizzazione sociale del paziente psichiatrico, ma anche come un’apertura su quanto finora è stato spesso rigettato perché considerato decostruttivo del successo riabilitativo.
Chi è il “paziente grave”
I protagonisti di questo studio sono persone che presentano patologie rientranti prevalentemente nell’area psicotica, di un’età compresa tra i 18 e i 45 anni. Ma “paziente grave”, in questa sede, non è una definizione univoca né data una volta per tutte. Nel corso dei lavori, infatti, ciascun servizio, rappresentato da suoi specifici operatori, dà la propria definizione di “persona soggetta ad uno stato di gravità”, definizione che è condivisa e comprovata dall’esperienza, quasi estemporanea, sui singoli casi. Viene dimostrato come il paziente cosiddetto “grave” non lo sia talvolta solo per categoria diagnostica, ma anche per tutte le variabili, pure istituzionali, che concorrono ad aggravare la sua situazione psichica e che sono spesso immanenti alla struttura degli ospedali psichiatrici cui ci si rivolge. I casi scelti e analizzati come “gravi” non lo sono solo sulla base dell’intensità o della ricorrenza dei disturbi deliranti cui sono eventualmente soggetti, né unicamente per la quantità di tentativi di suicidio, o di episodi distruttivi eterodiretti, ma anche e soprattutto per il percorso, più o meno turbolento, più o meno continuativo, che si è fatto con i servizi. Spesso questi ultimi, per via di questioni istituzionali, non riescono a garantire continuità di terapia ai pazienti, o inseriscono un paziente “in affidamento” ad un ente che però non si rivela quello più appropriato per il suo tipo di problematicità.
A questo proposito, gli atti del corso-progetto, attraverso le parole degli operatori e degli esperti, riportano diversi esempi di pazienti la cui assistenza subisce variazioni di servizio a seconda della reazione che il paziente stesso manifesta in seguito alla degenza nella struttura.
Tra i casi considerati, c’è Gianni, un ospite del Centro diurno che porta avanti la sua terapia costruendo la propria quotidianità tra la permanenza all’interno del servizio e l’inserimento lavorativo in una pizzeria.
Provvedimenti come questo, ed altri simili, contribuiscono ad una prospettiva concreta di “deistituzionalizzazione” della psichiatria, perché chi sta male non venga emarginato dal resto della società, né più visto come “il diverso” da temere e da cui stare lontano.
Il libro, prima della sezione Ringraziamenti, termina con una raccolta di Aforismi di Vieri Marzi, professore emerito scomparso prima della conclusione del corso-progetto, per il quale ha svolto il ruolo fondamentale di guida e coordinatore dei lavori.
Lo “svecchiamento” della psichiatria incontra lo spirito dell’Estate romana
È Renato Nicolini, il creatore dell’“Estate romana” del 1979, che consegna come Prefazione al libro, poco prima della scomparsa, un ricordo del suo incontro con Franco Basaglia. La descrizione assume toni quasi onirici, comunque non in contrasto con il realismo vivido che permea il resoconto di quel momento storico: anni in cui, racconta Nicolini non senza una nota di rimpianto, politica, società e cultura costituivano un tutt’uno e sindaci come Luigi Petroselli e Giulio Carlo Argan avevano reso Roma un’autentica città d’arte “in movimento”, con Gigi Proietti e Dario Fo promotori di un teatro che si compenetrava con la vita e che andava a interessare tutte le fasce della società, soprattutto quelle più deboli e svantaggiate, a più livelli.
L’intera capitale, motivata dall’arte e dalla cultura, si era aperta alla diversità e alla riscoperta dell’altro da sé.
Ed è con lo stesso spirito costruttivo dell’“Estate romana”, e di Nicolini, che Luigi Attenasio e Angelo Di Gennaro propongono la lettura di questo libro: combattere la paura del “diverso”, riscoprire “l’altro da sé” per riconoscere “l’altro in sé”.
Francesca Erica Bruzzese
(www.bottegascriptamanent.it, anno VIII, n. 79, marzo 2014)
Francesca Buran, Pamela Quintieri, Francesco Rolli, Fulvia Scopelliti
Simona Baldassarre, Sabrina Barbin, Ilaria Bovio, Francesca Erica Bruzzese, Valentina Burchianti, Diana Calvino, Maria Laura Capobianco, Maria Assunta Carlucci, Alberto Cazzoli, Cinzia Ceriani, Guglielmo Colombero, Selene Miriam Corapi, Veronica Di Gregorio Zitella, Giacomo Dini, Maria Rosaria Ferrara, Elisabetta Feruglio, Riccardo Fiorenza, Maria Francesca Focarelli Barone, Vilma Formigoni, Adelina Guerrera, Francesca Ielpo, Federica Lento, Giuseppe Licandro, Aurora Logullo, Flavia Maccaronio, Stefania Marchitelli, Francesca Martino, Irene Nicastro, Maristella Occhionero, Giusy Patera, Stefania Pipitone, Elisa Pirozzi, Luciana Rossi, Martino Santillo, Maria Saporito, Angelica Tundis, Paolo Veltri, Andrea Vulpitta, Carmine Zaccaro
Denise Amato, Mariacristiana Guglielmelli, Francesca Ielpo, Annalisa Lentini, Aurora Logullo, Rosina Madotta, Manuela Mancuso, Francesca Maruccia, Elisa Pirozzi, Pamela Quintieri, Francesca Rinaldi, Francesco Rolli, Fulvia Scopelliti