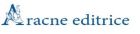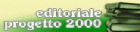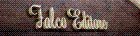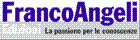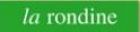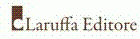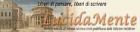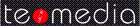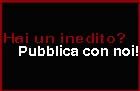Società di prodotti editoriali, comunicazione e giornalismo.
Iscrizione al Roc n. 21969.
Registrazione presso il Tribunale di Cosenza
n. 817 del 22/11/2007.
Issn 2035-7370.
Direttore editoriale: Graziana Pecora
Anno VIII, n 78, febbraio 2014
 Storie di donne di mare
Storie di donne di maretra narrativa e ricerca
di Vilma Formigoni
Uno studio sulla condizione femminile alle Eolie
nelle testimonianze raccolte da Pungitopo editrice
Quando si parla di “gente di mare”, il pensiero corre subito a marinai e pescatori, dimenticando che accanto a essi vivono e lavorano madri, mogli, figlie. Una differenza di genere spesso trascurata dalla letteratura tradizionale, quando in realtà le donne del mare sono le depositarie di tradizioni che l’età contemporanea ha ormai perduto per sempre.
L’antropologa Marina Marilena Maffei, lucana di nascita ed eoliana d’adozione dopo il matrimonio, ha raccolto le voci, le storie, le fiabe delle donne che vivono nelle Isole Eolie, un mondo lontano destinato a perdere la memoria di sé.
Orgogliosa di aver contribuito con i suoi studi antropologici alla scoperta dell’arcipelago eoliano, ha scritto quattro libri fondamentali: Capelli di serpe (1995), Le fantasie, le opere e i giorni (2000), I contorni irreali delle Eolie (2002) e La danza delle streghe (2008).
Donne di mare (Pungitopo editrice, pp. 176, € 12,00) è la sua ultima fatica letteraria, in cui raccoglie le vite di donne eoliane che «hanno sfidato quotidianamente il mare lottando corpo e anima per sé e per gli altri». Una ricerca etnografica e iconografica che ha permesso di recuperare e riscoprire il valore di queste donne, attraverso testimonianze riconducibili alla prima metà del secolo scorso, quando l’arcipelago non era ancora una meta turistica alla moda e i suoi abitanti esercitavano prevalentemente attività collegate alla pesca e all’agricoltura di sussistenza.
Le donne di mare raccontate da pescatori e sociologi
Fino all’inizio del XX secolo, le Eolie erano praticamente isolate e i rapporti con i territori siciliani più vicini poco frequenti, anche se l’elevata pescosità del mare della zona era molto nota. La separazione era dovuta non solo alle difficoltà dei collegamenti, ma «anche all’uso di un diverso linguaggio dialettale». Il successivo processo d’integrazione sociale con gli abitanti della Sicilia è da ascrivere prevalentemente ai matrimoni fra «Aciriali e Liparoti», che hanno «annullato la differenza iniziale».
Il libro di Maffei si snoda lungo una serie di racconti di esperienze femminili che partono da un assunto antico: «il mare agli uomini e la terra alle donne, è la generica affermazione che ha tradotto per molto tempo un convincimento più perentorio di qualunque tradizione. L’arcipelago eoliano mostra quanto questa regola fosse non soltanto non veritiera, ma addirittura fallace».
Martino Dalla Chiesa è un vecchio pescatore, figlio di padre eoliano e di madre aciriale, che racconta all’autrice le vicende di queste «donne di mare» riconoscendo alla figura materna un ruolo di primo piano, poiché contribuì a dare «impulso all’integrazione sposando un pescatore con cui condividerà per tutta la vita il lavoro del mare». È una donna forte, la madre di Martino, che agisce con fermezza, guidata da profonda conoscenza e da valori antichi che si perdono nella notte dei tempi.
Esiste una «identità mediterranea»? Se lo chiede l’autrice, che cerca nella tradizione greca e nella mitologia una sorta di archetipo che configuri la donna legata strettamente al mare. Maffei cita il grande storico francese Fernand Braudel, le cui osservazioni prefigurano i tratti e i comportamenti del pescatore definito «artigiano dell’arte alieutica che svolge anche il mestiere del contadino». Lo storico francese, infatti, aveva condotto un’attenta ricerca per descrivere la figura del pescatore che conosce il mare e il territorio del proprio villaggio; non solo attua una pesca assolutamente non dannosa, ma sa essere anche un contadino esperto che coltiva il proprio orto. Si tratta, in verità, come sottolinea l’autrice, di condizioni di vita che riguardano non solo l’individuo, ma tutta quanta la comunità; abitudini, in buona sostanza, che «hanno accomunato […] cultura marittima mediterranea. […] Che si tratti di […] una testimonianza orale, tuttavia all’interno di questa trattazione non ha alcuna importanza, è un’altra la questione centrale: quelle parole non sono pronunciate da un pescatore ma escono da labbra femminili». Ognuna di queste testimonianze, così come sono raccontate da Martino, si definisce «non solo come voce di pescatrice e di donna di mare ma anche come voce di moglie e di madre» e trasporta il lettore nella dimensione reale dell’esistenza.
I racconti sono talora anche drammatici, come racconta Bartolo, pescatore di Canneto, a proposito della madre e di un modello di vita caratterizzato dal dolore. «Mio padre aveva otto figli e […] per dare da mangiare ai figli, andava con mia mamma a pescare. Mia mamma [una volta] era incinta grossa, aveva già sette figli poi era di nuova incinta era… era grossa! Ha partorito sulla spiaggia, ed è morto, è morto il bambino». La pesca per la vita e per la famiglia; la morte del bimbo sulla spiaggia; vita e morte sono strettamente saldate tra loro e alimentano un «pensiero che pare attraversare incessantemente la donna: traghettare i figli, quelli vivi, fuori dai territori della fame». Così come la figura di Tarina, «donna subalterna che non può sottrarsi al ruolo della tradizione, sullo sfondo di una miseria evidente», alla quale veniva richiesto di «avere il grembo sempre pronto ad ospitare nuove vite, continuando però il suo mestiere di pescatrice»: ella è forte, accetta tutte le sfide, fronteggia col corpo gravido le onde del mare utilizzando una rete chiamata “ragno” con la quale «consegna il corpo del figlio non alla dinamicità della vita ma alla fissità della morte», proprio come fa il ragno quando tesse la tela per catturare gli insetti. Sembra di assistere, leggendo questa testimonianza, al rinnovarsi di un antico legame «fra la donna e il ragno, nelle Eolie, inscritto […] nella dimensione del mito» di Aracne, sottolineato tragicamente dall’afasia di Tarina di fronte al figlio nato morto.
L’opera di Maffei presenta anche interessanti spunti che attestano un’accurata indagine sociologica. «Come è possibile – si chiede l’autrice – che le donne che remavano e pescavano nei mari siciliani […] non siano mai state considerate un significativo orizzonte sociologico del lavoro femminile?». Eppure non mancano testimonianze storiche risalenti all’Ottocento che mettono a fuoco un aspetto della condizione femminile eoliana rilevato dagli osservatori del tempo: «le donne eoliane effettuavano nel modo migliore attività considerate altrove appannaggio degli uomini, ma anche tali lavori ricadevano sulle spalle femminili, determinando una distribuzione del lavoro ad esse nettamente sfavorevole». Infatti, le donne eoliane, oltre all’attività legata alla pesca, si occupavano di agricoltura, allevavano i figli, si dedicavano alla casa; per di più, il loro lavoro era pagato molto meno di quello maschile perché si sosteneva che «la capacità produttiva femminile è per natura inferiore a quella maschile e ha portato diritto a una remunerazione per definizione inferiore». Nonostante tutto questo, l’alieutica, l’antica arte della pesca, è messa a disposizione della famiglia, dei figli e del marito perché nasce, come testimoniano i racconti delle «donne di mare», all’interno di legami affettivi forti sui quali si fondano i loro comportamenti e, anche, la loro ostinazione.
Si potrebbe obiettare che il libro propone e utilizza una «memoria parziale e soggettiva», quella delle donne, appunto. A questa obiezione l’autrice risponde che «non si fa più storia solo con i documenti scritti o solo con i documenti orali; fare storia […] è una cosa talmente complessa che può essere solo il dialogo fra sistemi complicati […] di interpretazioni. […] Ciò che ci offrono queste vite comuni è qualcosa che la storia non ci darà mai e che forse non vuole o ha paura di dare: una società vista straordinariamente da chi l’ha vissuta e ce la racconta, il racconto di un mondo».
La conferma di quanto affermato da Maffei è anche nel linguaggio dialettale, quello del pescatore che racconta, alternato a quello più dichiaratamente specifico dei ricercatori, dei sociologi storici e dell’autrice medesima, che di queste donne eoliane coglie il sistema di conoscenze e di saperi molto più ampio e articolato rispetto a quello delle donne della loro epoca e condizione.
È una cultura che non può essere cancellata, perché appartiene alle radici di un passato che rischierebbe, inesorabilmente, di essere travolto dalle trasformazioni antropologiche che hanno investito il mondo occidentale in genere. Le testimonianze raccolte, infatti, mostrano la forza dei legami affettivi e familiari, così che dimenticarle «significherebbe, per le Isole, cancellare una parte del proprio passato», la propria identità storica. E il vero progresso, tanto proclamato, non consiste nell’oblio, ma nella memoria di sé per accogliere il futuro senza tradire le origini.
Le numerose referenze iconografiche, infine, testimoniano e completano, arricchendola, la realtà di un mondo lontano che non si può e non si deve dimenticare.
Vilma Formigoni
(www.bottegascriptamanent.it, anno VIII, n. 78, febbraio 2014)
Francesca Buran, Pamela Quintieri, Francesco Rolli, Fulvia Scopelliti
Simona Baldassarre, Sabrina Barbin, Ilaria Bovio, Francesca Erica Bruzzese, Valentina Burchianti, Diana Calvino, Maria Laura Capobianco, Maria Assunta Carlucci, Alberto Cazzoli, Cinzia Ceriani, Guglielmo Colombero, Selene Miriam Corapi, Veronica Di Gregorio Zitella, Giacomo Dini, Maria Rosaria Ferrara, Elisabetta Feruglio, Riccardo Fiorenza, Maria Francesca Focarelli Barone, Vilma Formigoni, Francesca Ielpo, Federica Lento, Giuseppe Licandro, Aurora Logullo, Flavia Maccaronio, Stefania Marchitelli, Irene Nicastro, Maristella Occhionero, Giusy Patera, Stefania Pipitone, Elisa Pirozzi, Luciana Rossi, Martino Santillo, Maria Saporito, Angelica Tundis, Paolo Veltri, Andrea Vulpitta, Carmine Zaccaro
Denise Amato, Mariacristiana Guglielmelli, Francesca Ielpo, Annalisa Lentini, Aurora Logullo, Rosina Madotta, Manuela Mancuso, Francesca Maruccia, Elisa Pirozzi, Pamela Quintieri, Francesca Rinaldi, Francesco Rolli, Fulvia Scopelliti