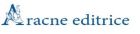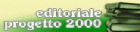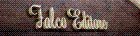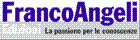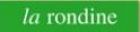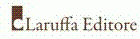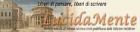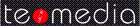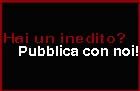Società di prodotti editoriali, comunicazione e giornalismo.
Iscrizione al Roc n. 21969.
Registrazione presso il Tribunale di Cosenza
n. 817 del 22/11/2007.
Issn 2035-7370.
Direttore editoriale: Graziana Pecora
Anno VII, n. 70, giugno 2013
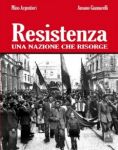 L’antifascismo
L’antifascismoe il riscatto italiano
dal Ventennio nero
di Giuseppe Licandro
Da Città del sole, la sintesi letteraria
di un documentario sulla Resistenza
Circa quarant’anni orsono, il regista Ansano Giannarelli, in collaborazione con lo sceneggiatore e critico cinematografico Mino Argentieri e con lo storico Paolo Spriano, curò le riprese di Resistenza, una nazione che risorge, un lungo docu-film che parlava della lotta partigiana in Italia durante l’occupazione nazista.
Nel 1975, in occasione del 30° anniversario della Liberazione, il filmato venne edito dalla Unitelefilm, una piccola casa produttrice di proprietà del Partito comunista italiano specializzata in cortometraggi propagandistici, ma ebbe una scarsa diffusione nelle sale cinematografiche, limitandosi a sporadiche proiezioni nelle scuole e nei circuiti d’essai.
Suddiviso in cinque parti per una durata complessiva di tre ore e tre quarti, il documentario s’incentrava soprattutto sulle interviste ad alcuni dei protagonisti della lotta antifascista. In particolare: Giorgio Amendola, Giustino Arpesani, Arrigo Boldrini, Giuseppe Brusasca, Franco Catalano, Arturo Colombi, Enzo Enriques Agnoletti, Ugo
Trentacinque anni dopo, il film è diventato un libro, sempre a cura di Argentieri e Giannarelli, dal titolo Resistenza. Una nazione che risorge (Città del sole, pp. 264, € 20,00). Il volume comprende tre saggi introduttivi, il testo della sceneggiatura del documentario, le interviste e le biografie dei protagonisti della lotta partigiana.
Un film tramutato in un libro
Argentieri, nel saggio Un film trentacinque anni dopo, afferma giustamente che, anche al giorno d’oggi, «la questione della Resistenza si appalesa nella sua calda politicità e attualità e non come semplice controversia storiografica o mera disputa accademica tra specialisti».
Lo sceneggiatore parte dalla constatazione che, nell’ultimo ventennio della storia italiana, si è diffusa la rilettura di stampo revisionistico dell’esperienza partigiana, portata avanti soprattutto dagli studiosi schierati su posizioni attigue ai partiti di centrodestra, che hanno lungamente governato dal 1994 in poi.
Argentieri, tuttavia, è consapevole che il tentativo di annacquare la portata dirompente della Liberazione risale a molto tempo prima: già negli anni Cinquanta del secolo scorso, infatti, i governi a conduzione democristiana si prodigarono in tal senso e – come ha dimostrato lo storico tedesco Felix Bohr − tentarono persino di insabbiare le indagini sulla strage delle Fosse Ardeatine.
Le aperture a destra di una parte della Democrazia cristiana − ad esempio, l’incontro tra Giulio Andreotti e Rodolfo Graziani ad Arcirazzo nel 1953 o il governo guidato da Ferdinando Tambroni nel 1960, appoggiato anche dal Movimento sociale italiano − contribuirono a far rimuovere la lotta partigiana dal dibattito politico-culturale.
Col tempo anche buona parte della sinistra italiana ha finito per rimuovere gli ideali antifascisti, demandando «lo studio e la disamina della Resistenza specialistica e dell’antifascismo militante alla ricerca di origine universitaria e parauniversitaria».
Tutto questo, però, ha sortito conseguenze politiche deleterie, perché ha spianato la strada a Silvio Berlusconi, favorendo l’affermazione di un modello «di democrazia autoritaria e fascistoide, cesarista e plebiscitaria».
Argentieri sottolinea che il film di Giannarelli non era celebrativo, né retorico, bensì «asciutto e concreto, un ensemble di tasselli conoscitivi da porgere allo spettatore affinché lo commentasse», presentando
Egli ricorda che non fu possibile intervistare due tra i maggiori protagonisti della lotta partigiana, cioè Pietro Nenni e Sandro Pertini, il primo perché aveva problemi di salute, il secondo… perché si spazientì con gli autori, che gli avevano chiesto di «rivangare nei risentimenti e nelle frizioni intestine della Resistenza»!
Pur ribadendone «il carattere di massa», Argentieri riconosce − con grande onestà intellettuale − che ci fu uno scarso coinvolgimento della popolazione meridionale nella guerra contro i nazifascisti e, inoltre, che
Lo sceneggiatore ammette che il film ha peccato di superficialità, perché non ha saputo cogliere, fino in fondo, le divisioni esistenti tra le forze antifasciste, né i segnali inquietanti che già nel Secondo dopoguerra serpeggiavano nella società italiana, trascurando l’esistenza di «un soggetto bastardo, bicefalo, individualista, violento, […] voltagabbana per convenienza, pronto a saltare sul carro del vincitore», che ha seminato il terreno su cui poi ha attecchito il conservatorismo di fine secolo.
Nel film è stata, inoltre, poco esplicitata l’ambiguità di fondo del Vaticano e di papa Pio XII, che − nonostante il sincero impegno di tanti fedeli nella Resistenza − «sono stati fermamente avversi alla lotta antinazista e antifascista», scoraggiando la ribellione aperta contro i tedeschi. Il documentario è lacunoso anche riguardo al comportamento, non sempre ortodosso, mantenuto dagli Alleati: infatti, pur sottolineando che si avvalsero del supporto logistico di molti mafiosi, non ha posto l’accento sulle violenze perpetrate dalle incursioni aeree anglo-americane dopo l’8 settembre 1943 – che causarono ben 40.000 vittime – e dalle truppe di occupazione, soprattutto da quelle francesi.
Nonostante questi difetti, Resistenza, una nazione che risorge rimane uno dei più validi documentari sulla Liberazione ed è appunto per proporre il messaggio di libertà in esso contenuto che si è deciso di «tramutare un film in un libro».
I film sulla Resistenza dal 1945 al 1969
Nel saggio Visioni filmiche della Resistenza, Giannarelli prende in esame la filmografia resistenziale, che comprende due tipologie, «quella documentaria e quella di ricostruzione», anche se manca un catalogo completo di questo genere di cinema.
Il regista individua poco meno di trecento film (tra fiction e documentari) che, a vario titolo, si sono occupati di fatti riconducibili alla Resistenza, dispiegandosi lungo cinque distinte fasi della cinematografia italiana postbellica.
Il primo periodo, compreso tra il 1945 e il 1947, segnò la fusione del cinema resistenziale col neorealismo, una corrente cinematografica «di alto valore culturale, estetico e politico». Emblema di questo legame fu il capolavoro Roma città aperta, girato nel 1945 da Roberto Rossellini, che assurse a modello per altre pellicole dell’epoca: Due lettere anonime (1945) di Mario Camerini, La nostra guerra (1945) di Alberto Lattuada, Il sole sorge ancora (1946) di Aldo Vergano, Paisà (1946) dello stesso Rossellini e Vivere in pace (1947) di Luigi Zampa.
Il secondo periodo del cinema resistenziale si dispiegò nel decennio compreso tra il 1948 e il 1958 e fu contraddistinto dalla fine dell’unità antifascista e dall’egemonia della Democrazia cristiana, durante la quale la lotta partigiana fu rimossa dalla memoria collettiva, insieme ai tanti crimini perpetrati dai neonazisti: i fascicoli giudiziari concernenti molti di questi delitti finirono relegati nell’“armadio della vergogna”, dove rimasero a impolverarsi fino al 1994!
Il cinema italiano, negli anni Cinquanta, fu attraversato da un’ondata di perbenismo, che finì per accantonare lo stile narrativo neorealista a vantaggio delle commedie leggere e dei melodrammi. Risultò fondamentale, in questo frangente, la volontà del governo democristiano di obliare il ricordo della Resistenza, in particolare di Andreotti, sottosegretario alla Presidenza del consiglio con delega allo Spettacolo, che volle «promuovere un cinema spensierato e ottimista».
Non mancarono, tuttavia, pellicole pregevoli, che si occuparono della guerra e della lotta partigiana: L’armata s’agapò (1953) di Renzo Renzi (che fu condannato per il reato di «vilipendio delle forze armate», insieme a Guido Aristarco, direttore della rivista Cinema Nuovo), San Miniato: luglio 1944 (1954) di Valentino Orsini e di Paolo e Vittorio Taviani, Gli sbandati (1955) di Francesco Maselli, Il delitto Matteotti (1956) di Nelo Risi.
Il terzo periodo si delineò tra il 1959 e il 1969, allorché in Italia si affermarono i governi di centrosinistra contestualmente alla crescita elettorale del Partito comunista italiano e all’esplosione della contestazione giovanile. Si verificò, pertanto, un ritorno di interesse per la fiction resistenziale, insieme a una «consistente ripresa della produzione di cortometraggi documentari».
Tra le opere più espressive di questa fase, ricordiamo: Il generale Della Rovere (1959) di Rossellini, I fratelli Rosselli (1959) di Nelo Risi, Tutti a casa (1960) di Luigi Comencini, La lunga notte del ’43 (1960) di Florestano Vancini, Kapò (1960) di Gillo Pontecorvo, Un giorno da leoni (1961) di Nanni Loy, Il processo di Verona (1962) di Carlo Lizzani, Le quattro giornate di Napoli (1962) di Loy, La ragazza di Bube (1963) di Comencini.
I film sulla Resistenza dal 1970 al 2011
Nella quarta fase, compresa tra il 1970 e il 1980, gli ideali della Resistenza si rafforzarono, sull’onda delle lotte operaie e studentesche di quegli anni.
Numerosi furono i film, riferibili al periodo bellico e alle lotte antifasciste, prodotti in quel decennio: Il giardino dei Finzi-Contini (1970) di Vittorio De Sica, Il delitto Matteotti (1973) di Vancini, Il sospetto (1975) di Maselli, Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975) di Pier Paolo Pasolini, Salvo D’Acquisto (1975) di Romolo Guerrieri, Novecento. Atto II (1976) di Bernardo Bertolucci, L’Agnese va a morire (1976) di Giuliano Montaldo, Antonio Gramsci. I giorni del carcere (1977) di Lino Del Fra, Cristo si è fermato a Eboli (1978) di Francesco Rosi, Uomini e no (1980) di Orsini.
Scarsa, invece, fu la presenza di documentari: a parte Resistenza, una nazione che risorge, l’unico cortometraggio degno di rilievo fu Fascista (1974) di Nico Naldini.
L’ultima fase del cinema resistenziale si è aperta nel 1980, giungendo fino ai giorni nostri, in corrispondenza con il montare del revisionismo storico e con lo “sdoganamento” della destra neofascista, avvenuto in Italia dopo il 1994.
Nell’ultimo trentennio, in particolare, si è assistito al tentativo, portato avanti da studiosi come Giampaolo Pansa, di «metter sullo stesso piano sia coloro che si schierarono con
Ciò ha comportato una sorta di nuovo oblio dell’antifascismo e della lotta partigiana, con una forte riduzione dei film ad essi dedicati, anche se ci sono state ugualmente pellicole «di qualità etico-politica molto alta»: La notte di San Lorenzo (1982) dei fratelli Taviani, A porte aperte (1990) di Gianni Amelio, Mediterraneo (1991) di Gabriele Salvatores, Jona che visse nella balena (1993) di Roberto Faenza, La tregua (1997) di Rosi, La vita è bella (1997) di Roberto Benigni, I piccoli maestri (1998) di Daniele Luchetti, Concorrenza sleale (2001) di Ettore Scola, Hotel Meina (2007) di Carlo Lizzani.
In controtendenza, invece, c’è stata «una crescente produzione di tipo documentario», ad opera soprattutto di giovani registi, che nei loro cortometraggi «raccolgono testimonianze dei patrioti che combatterono, […] ricostruiscono episodi minori e sconosciuti della Resistenza, […] istituiscono nessi tra il passato e il presente».
Un regista serio e severo
Il terzo saggio del libro, dal titolo Ricordo di Ansano, è un omaggio che Argentieri ha dedicato a Giannarelli, scomparso nel 2011 in seguito a una grave malattia.
Il critico cinematografico descrive l’amico come un regista «discreto, serio, schivo, severo, esigente e intransigente con se stesso», lontano dagli stereotipi dell’artista narcisista ed egocentrico, commentando con slancio e partecipazione gli innumerevoli documentari da lui diretti (ne curò oltre cinquanta) e le sue tre fiction: Sierra maestra (1969), Non ho tempo (1972) e Remake (1987).
Nei suoi documentari, Giannarelli si è occupato prevalentemente dei temi della Resistenza, dell’antifascismo, delle lotte operaie e sindacali, senza mai scadere nell’agiografia o nella lettura ideologica degli avvenimenti. Oltre a Resistenza, una nazione che risorge, il suo più importante cortometraggio fu 16 ottobre 1943 (1960), in cui egli ricostruì il rastrellamento eseguito dai nazisti nel ghetto romano, il 16 ottobre 1943.
Nei tre film da lui realizzati, invece, è prevalsa soprattutto una costante: «la vocazione a una forma non arrovellata, ma che abbia divaricazioni, improvvise e imprevedibili svolte, mossa quanto può esserlo un ragionamento che semplifica e non riduce, mantenendo una dominante asciuttezza».
In Non ho tempo − la sua opera migliore, in cui si parla della breve vita del matematico francese Évariste Galois − egli è riuscito mirabilmente a coniugare «analisi storica e introspezione, emozione e ragione, sentimenti, idee e psicologia». Un regista tutto da riscoprire, che ha fornito un apprezzabile contributo per la diffusione della cultura democratica e antifascista in Italia.
Giuseppe Licandro
(www.bottegascriptamanent.it, anno VII, n. 70, giugno 2013)
Pamela Quintieri, Alessandro Randone, Francesco Rolli, Fulvia Scopelliti
Denise Amato, Simona Baldassarre, Maria Balsamo, Sabrina Barbin, Ilaria Bovio, Francesca Erica Bruzzese, Valentina Burchianti, Maria Laura Capobianco, Maria Assunta Carlucci, Costanza Carzo, Alberto Cazzoli, Cinzia Ceriani, Guglielmo Colombero, Selene Miriam Corapi, Giacomo Dini, Stefania Falbo, Maria Rosaria Ferrara, Elisabetta Feruglio, Vilma Formigoni, Adelina Guerrera, Francesca Ielpo, Federica Lento, Giuseppe Licandro, Aurora Logullo, Stefania Marchitelli, Pinangelo Marino, Paola Mazza, Sonia Miceli, Elena Montemaggi, Irene Nicastro, Lara Parisella, Giusy Patera, Serena Poppi, Emanuela Pugliese, Francesca Rinaldi, Luciana Rossi, Maria Saporito, Francesco Staderini, Andrea Vulpitta, Carmine Zaccaro
Denise Amato, Angela Galloro, Aurora Logullo, Rosina Madotta, Manuela Mancuso, Ilenia Marrapodi, Emanuela Pugliese, Pamela Quintieri, Francesca Rinaldi, Francesco Rolli, Fulvia Scopelliti, Alba Terranova