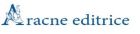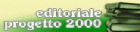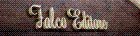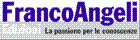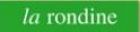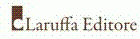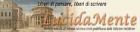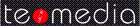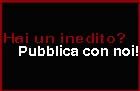Società di prodotti editoriali, comunicazione e giornalismo.
Iscrizione al Roc n. 21969.
Registrazione presso il Tribunale di Cosenza
n. 817 del 22/11/2007.
Issn 2035-7370.
Direttore editoriale: Graziana Pecora
Anno VII, N. 66, febbraio 2013
 Come affrontare la crisi?
Come affrontare la crisi?Un punto di vista moderno
per un’economia nuova
e davvero a misura d’uomo
di Giuseppe Peluso
Da Bruno Mondadori, un manualetto
elaborato da un brillante economista
È un piccolo vademecum di analisi, un combo che racchiude in sé la voglia e la critica di un ricercatore attento che, meglio di tanti altri “analisti del momento”, scrive e giudica uno spaccato di attualità da cui c’è molto da imparare, soprattutto tra le righe. Abituati ai grandi e maestosi manuali analitici di Economia, le dimensioni di questo piccolo concentrato di osservazioni potrebbero illudere il lettore (specialmente quello che di Economia conosce), ma ovviamente, come per quasi ogni cosa, le dimensioni non contano affatto anche in questo caso: le osservazioni dell’autore centreranno il bersaglio e i risultati della sua ricerca non saranno certamente da meno rispetto ai più maestosi ed aulici testi del settore.
È così che potrebbe apparire dunque al lettore curioso medio il testo da poco pubblicato dal ricercatore italiano Emanuele Campiglio, uno scritto che racchiude in sé i risultati di molti anni di studio e analisi nel settore finanziario e sociale: L’economia buona (Bruno Mondadori, pp. 176, € 14,00). L’autore, infatti, dopo il dottorato di ricerca in Economia politica, lavora oggi nel campo economico-ambientale a Londra, dove continua a studiare l’applicazione economica ai sistemi ambientali ed ecologici.
Una manovra finanziaria drastica
Parlare di economia oggi, come sicuramente l’autore sa bene, è un compito molto arduo e spinoso, soprattutto a livello nazionale. È risaputo il ruolo che l’Italia ricopre all’interno del panorama economico mondiale, è sulla bocca di tutti la politica interna che manovra le scelte finanziarie del paese, ed è palese la difficoltà che la nazione sta riscontrando nell’uscire da un periodo di crisi profonda. Date dunque per “scontate” queste linee di partenza, ecco che Campiglio sposta il tiro della sua ricerca per soffermarsi su altro punto, poiché, come il lettore stesso intuisce già dalle prime battute, l’occhio esterno e distaccato di un professionista dell’ambito economico, può dare un grosso contributo all’opinione pubblica che, più che chiedersi cosa stia succedendo, vorrebbe capire dove trovare delle soluzioni.
Sarà dunque tra il capire e il reagire che lo studio portato avanti da Campiglio andrà a collocarsi come immagine distaccata di una realtà critica sì, ma che ha ancora la possibilità di riscatto e rinascita.
Un primo spunto di riflessione l’autore lo cerca a livello internazionale e lo fa risalire al novembre 2008, quando la regina Elisabetta, con tono stupito e maldisposto, chiede agli economisti della London School of Economics: «Why did no one see it coming?», “perché nessuno l’ha previsto?”. Il prestigio, il nome e il perno economico che la nota scuola di Londra rappresentano a livello mondiale avrebbero dovuto dare l’allarme che un uragano di queste dimensioni stava per abbattersi sull’economia mondiale, ma evidentemente – ed è questa una delle riflessioni che l’autore appoggia nel suo libro – da molto tempo ormai la disciplina economica ha cambiato la sua consistenza e la sua essenza, evolvendosi e diventando qualcos’altro con cui ancora dover entrare in confidenza. L’autore si interroga, dunque, su un binomio portante che da sempre ha caratterizzato questa attività: il binomio che vede da un lato l’economia e dall’altra la felicità e il benessere. È chiaro quindi che, nel momento in cui l’economia non è più considerata come un mezzo attraverso il quale poter gestire il benessere mondiale, ecco che cambia il suo aspetto e il ruolo che gioca all’interno del mercato. L’autore, principalmente e in prima analisi, accusa il distacco della finanza dall’economia come uno dei principali fattori che hanno contribuito al cambiamento dei mercati, appunto perché, con questo cambiamento, la materia in oggetto ha assunto altri valori e da qui la reazione a catena è stata inevitabile.
Un’economia coinvolgente
Nel suo interessante trattato, Campiglio, da ricercatore e analista del settore, ovviamente non si concentra soltanto sulle cause del problema, ma si interessa soprattutto della ricerca di soluzioni attuabili in termini pratici e facilmente condivisibili da tutti.
Ciò che tra le sue righe si può notare con ammirazione è un’esaltazione dell’individualità all’interno di un contesto economico generale e internazionalizzato. Le basi per una nuova economia dovranno infatti essere gettate nel rispetto dell’individualità e nell’esaltazione di questa all’interno del discorso economico. L’economia è un qualcosa creato dall’uomo e che senza di lui non ha alcun motivo di esistere, ma ciò che ci suggerisce l’attuale realtà è invece altro: abbiamo a che fare con un organismo autonomo che ha vita indipendente rispetto soprattutto all’individuo che contribuisce alla sua esistenza. Ciò che è economia improvvisamente non riguarda più la collettività degli individui, ma l’individualità di una piccola fetta di società che ne detiene il controllo generale e ne garantisce il prosieguo. Sarà dunque qui che l’autorità individuale andrà a modellare una scienza economica più umile e su misura per l’uomo.
Altro punto centrale della ricerca di Campiglio è lo stretto legame che l’economia deve intrattenere con la questione ambientale. Ciò che l’autore sostiene prepotentemente è un appoggio reciproco con l’ambiente e le risorse naturali, poiché è solo in queste ultime che risiede il vero sviluppo, non solo a livello economico, ma umano. Sfruttare al massimo sì, ma con rispetto per il naturale rigenero: valorizzare il territorio locale ed esaltare una buona e positiva produzione sono, secondo l’autore, le fondamenta forti e ferme sulle quali poter costruire un’economia più solida e utile alla vita e al benessere comune. Il tutto con l’augurio di una coscienza collettiva più seria, attenta e vigile ai mutamenti e alle creazioni.
Giuseppe Peluso
(www.bottegascriptamanent.it, anno VII, n. 66, febbraio 2013)
Francesca Folino, Giuseppina Pascuzzo, Pamela Quintieri, Alessandro Randone
Simona Baldassarre, Maria Balsamo, Micol Bertolazzi, Ilaria Bovio, Francesca Erica Bruzzese, Valentina Burchianti, Maria Assunta Carlucci, Costanza Carzo, Alberto Cazzoli, Cinzia Ceriani, Guglielmo Colombero, Simona Comi, Selene Miriam Corapi, Stefania Falbo, Maria Rosaria Ferrara, Elisabetta Feruglio, Vilma Formigoni, Francesca Ielpo, Giuseppe Licandro, Jacqueline Maggio, Stefania Marchitelli, Pinangelo Marino, Paola Mazza, Sonia Miceli, Rossella Michienzi, Elena Montemaggi, Irene Nicastro, Lara Parisella, Giuseppina Pascuzzo, Giusy Patera, Angela Patrono, Serena Poppi, Emanuela Pugliese, Francesca Rinaldi, Luciana Rossi, Maria Saporito, Benedetta Schiariti, Antonella Spadafora, Giovanna Vizzari, Andrea Vulpitta, Carmine Zaccaro
Francesco Mattia Arcuri, Francesca Folino, Angela Galloro, Mariacristiana Guglielmelli, Francesca Ielpo, Mària Ivano, Rosina Madotta, Manuela Mancuso, Ilenia Marrapodi, Rossella Michienzi, Emanuela Pugliese, Pamela Quintieri, Fulvia Scopelliti, Alba Terranova
Dayana Borzomì, Veronica Di Gregorio Zitella, Stefania Falbo, Adelina Guerrera, Francesca Ielpo, Federica Lento, Giuseppe Licandro, Rossella Michienzi, Irene Nicastro, Angela Patrono, Giuseppe Peluso, Emanuela Pugliese, Maria Rosaria Stefanelli, Cristina Venneri