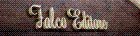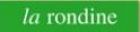Società di prodotti editoriali, comunicazione e giornalismo.
Iscrizione al Roc n. 21969.
Registrazione presso il Tribunale di Cosenza
n. 817 del 22/11/2007.
Issn 2035-7370.
Direttore editoriale: Mario Saccomanno
A. XVIII, n. 199, aprile 2024
 Nella sua ultima opera
Nella sua ultima operaCarlos Saura coniuga
la filosofia di Da Ponte
all’ironia di Casanova
di Guglielmo Colombero
Il regista spagnolo fonde il cinema, il teatro e l’opera lirica di Mozart,
dando vita a una sfrontata rivisitazione del mito di Don Giovanni
Lo spagnolo Carlos Saura, nato a Huesca 77 anni fa, inizia la sua carriera di regista nel clima plumbeo della dittatura franchista, ormai al tramonto: debutta dietro la macchina da presa nel 1963, dirigendo il kolossal storico-avventuroso I cavalieri della vendetta. Il suo talento emerge nel 1966 con La caccia, che sguscia indenne attraverso le maglie della censura di regime, annidando l’allegoria sulla borghesia alleata del fascismo in una cupa pagina di cronaca nera. Nel 1974 ottiene notorietà internazionale vincendo il Premio speciale della giuria a Cannes con La cugina Angelica, poi firma il dittico intimista formato da Cria Cuervos (1976) ed Elisa, vida mia (1977). Saura conosce la sua stagione d’oro con i musical girati negli anni Ottanta – Nozze di sangue (1981) da Federico Garcia Lorca, Carmen Story (1983) da Georges Bizet e L’amore stregone da Manuel De Falla (1986) –, una trilogia di opere-balletto che riscuote un enorme successo di pubblico grazie al sensuale fascino barocco delle immagini e al virtuosismo plastico del danzatore e coreografo Antonio Gades. Autore eclettico e imprevedibile, nella maturità Saura si cimenta con i generi più svariati (drammi come Antonieta, 1982; tragicommedie come Mama compie 100 anni, 1980, e Ay, Carmela!, 1990; rievocazioni storiche come A peso d’oro, 1988; biografie di artisti come Goya, 2000). Nel 1995 nasce il sodalizio con il grande maestro della fotografia Vittorio Storaro, che conferisce una morbida suggestione cromatica a due opere musicali di straordinario successo come Flamenco (1995) e Tango (1998).
Un librettista libertino, un vecchio seduttore e un musicista ribelle
L’ultimo film del cineasta spagnolo è Io, Don Giovanni, nato da una sceneggiatura scritta a tre mani: quelle di Saura stesso, Raffello Uboldi (giornalista e biografo di Karol Woityla) e Alessandro Vallini.
Nella decaduta Serenissima del 1779, tiranneggiata da un patriziato sempre più stagnante e da un clero tanto reazionario quanto terrorizzato dall’irrompere dei nuovi ideali illuministi, il trentenne sacerdote Lorenzo Da Ponte conduce una vita dissoluta, forse perché la conversione al cattolicesimo gli è stata imposta dai genitori (il padre ebreo, rimasto vedovo, ha accettato la nuova fede per poter sposare una ricca cristiana): beve, gioca d’azzardo, frequenta i bordelli ma, soprattutto, segue gli insegnamenti dell’impenitente libertino Giacomo Casanova, con il quale condivide l’appartenenza alla massoneria. Denunciato alla Santa Inquisizione veneziana a causa di una raccolta di versi licenziosi e anticlericali, Da Ponte subisce una condanna a 15 anni di esilio. Grazie a una lettera di raccomandazione di Casanova, lo scrittore trova accoglienza a Vienna presso il celebre musicista Antonio Salieri, che gode della stima dell’imperatore Giuseppe II, fervente appassionato di lirica. Il talento letterario di Lorenzo gli consente una rapida scalata sociale: conosce Mozart, astro nascente della musica viennese (anche se malvisto a corte a causa del suo anticonformismo), e per lui scrive nel 1786 il libretto d’opera di Le Nozze di Figaro. Il successo è strepitoso: l’anno seguente la corte imperiale commissiona una nuova opera lirica a Mozart, afflitto da una salute malferma e perennemente a corto di denaro. Il libretto che gli propone Da Ponte è sensazionale: una rivistazione in chiave sfrontatamente libertina del Don Giovanni, una commedia edificante (il titolo originale era L’ingannatore di Siviglia e il convitato di pietra) che un drammaturgo spagnolo del Seicento, Tirso de Molina, aveva scritto con l’intento di dissuadere i lettori dai peccati carnali (ottenendo l’effetto opposto: cioè la creazione di un personaggio dal tenebroso fascino luciferino, precursore degli eroi romantici e futuro protagonista di una delle più titaniche espressioni della poesia di Charles Baudelaire, Don Juan aux enfers). Da Ponte ritrova anche, sebbene invecchiato e pieno di acciacchi, il suo mentore Giacomo Casanova, relegato fra gli scaffali dell’immensa biblioteca del conte di Waldstein a Dux, in Boemia, della quale è stato nominato curatore: il seduttore, ormai in disarmo, sta compilando la propria autobiografia, e l’esercizio quotidiano della scrittura lo salverà dalla pazzia e lo trasformerà in un mito nei secoli a venire (gli resta ancora un decennio da vivere: il principe dei libertini morirà nel 1798, spettatore impotente del crollo del suo mondo sotto l’urto della Rivoluzione francese, e, da uomo colto e lungimirante quale è, dopo aver previsto l’irresistibile ascesa di un ambizioso generale corso, con sangue italiano come lui, di nome Napoleone Buonaparte, distruttore della Serenissima.
Madamina, il catalogo è questo
Rivedendo Casanova, Da Ponte ha un’illuminazione: sarà quel miscredente e disincantato maestro di vita a delineare il profilo del suo Don Giovanni, a ispirarne i tratti salienti, a infondergli la sua inesausta vena profanatoria e dissacratrice, ormai non più fondata sulle acrobazie sessuali ma sull’acume ancora pungente del suo intelletto. L’antefatto del libretto non è proponibile per il pubblico dell’epoca, nemmeno per uno spettatore laico, illuminato e tollerante come l’imperatore Giuseppe II: Don Giovanni si infila nudo nel letto di una verginella, la seduce con la sua scultorea bellezza di angelo caduto e, una volta smascherato, salta giù dalla finestra e si dilegua nel bosco. Saura, infatti, visualizza questo momento unicamente nella fantasia creativa di Da Ponte e poi, sul palcoscenico, ne propone l’incipit teatrale: il servo di Don Giovanni, Leporello, stufo di affannarsi dietro alle avventure galanti del padrone («Voglio fare il gentiluomo, e non voglio più servir», ammette sconsolato il servitore), assiste sgomento al duello in cui, con cinica noncuranza, Don Giovanni trafigge il Commendatore, padre della ragazza posseduta con l’inganno. Questa splendida sequenza d’ouverture operistica, fraintesa da qualche critico come una lungaggine accademica, è in realtà una raffinata provocazione intellettuale: ci immerge in quello che è il processo creativo di un capolavoro artistico – in questo caso l’opera lirica di Mozart, in cui si fondono parole, musica e immagini – e ne mette a nudo le viscere, la genesi quotidiana, nella quale risaltano le voci e i corpi degli interpreti. L’intercalare con i personaggi storicamente vissuti genera una fascinosa commistione fra arte e vita: il soprano Adriana Ferrarese, che fu realmente l’amante di Da Ponte, riceve da un sornione Casanova l’elenco delle conquiste amorose del librettista (c’è anche il suo nome…) e poi reitera l’evento sul palcoscenico, interpretando la «madamina» destinataria del «catalogo» stilato da Leporello e contenente l’interminabile lista delle donne sedotte da Don Giovanni. E, a sua volta, un analogo biglietto viene da lei recapitato ad Annetta, la virtuosa fanciulla di cui si innamora Da Ponte e per la quale decide di porre termine alla sua carriera di tombeur de femmes.
Pentiti! No, non mi pento!
La sequenza d’apertura allestita da Saura è avvolta nella caligine del Canal Grande, a cui il direttore della fotografia, il grande Vittorio Storaro, infonde una tonalità espressionista: la gondola che trasporta Da Ponte e Casanova incrocia il barcone su cui, marmorea e imponente, minacciosa con il suo dito puntato verso il cielo, giace la statua del Convitato di pietra. Personaggio che ricompare in carne e ossa nell’epilogo, quando Don Giovanni rifiuta di pentirsi e si lascia trascinare all’inferno (dove lo incontrerà mezzo secolo più tardi Baudelaire: «Un grande uomo di pietra, ritto nella sua armatura / s’ergea presso la barra, fendendo l’acque nere / Ma, curvo sulla sua spada, l’eroe senza paura / fissava il solco, e null’altro si degnava di vedere»). Stavolta è un tenore avvolto nel sudario, che giganteggia sui trampoli in modo da incombere su Don Giovanni, ma senza riuscire a intimorirlo. Saura cita anche i dipinti d’epoca, in cui nel paesaggio pittorico s’innesta l’immagine in movimento di una carrozza: una geniale immissione del cinema nel Settecento immortalato dai quadri (essendo la pittura l’unica testimonianza iconografica del Secolo dei Lumi di cui disponiamo). Ma non finisce qui: nel finale Saura scaraventa sul palcoscenico uno sfondo animato che rappresenta un’eruzione di lava incandescente, non certo per sostenere che i fratelli Lumiere siano nati con un secolo di anticipo, ma semplicemente per attualizzare una visione dell’inferno che poteva essere suscitata nella psiche degli spettatori dell’opera lirica; oppure, con un’altra audace contaminazione, per insinuare il linguaggio del cinema dentro la lirica del Settecento, realizzando un vero e proprio ipertesto cinematografico.
Un magnifico lavoro di squadra
Io, Don Giovanni è un’opera corale: Lorenzo Da Ponte (impersonato da Lorenzo Balducci, diabolicamente sensuale sia nei panni del librettista che in quelli, o meglio senza, del suo alter ego operistico nell’unico momento erotico della narrazione) si colloca al centro dello scenario, ma non lo invade mai. Giacomo Casanova (un elegante e sardonico Tobias Moretti, che qui riesce a farci dimenticare la banalità del commissario Rex, al quale deve la sua notorietà televisiva) è l’incarnazione dello spirito libertino, ma anche libertario del Secolo dei Lumi: la sua andatura, sempre più incerta e barcollante, è una fine allegoria del declino di un’epoca, dell’agonia dell’ormai molle ed estenuato mondo dei minuetti e del rococò, in procinto di essere spazzato via dall’avvento al potere della borghesia trionfante sull’Ancien Régime. Il Mozart di Saura (Lino Guanciale) è, per fortuna, assai distante dalla parossistica e quasi scimmiesca caricatura che ci aveva propinato Milos Forman nel delirante Amadeus: il brano in cui ricorda la figura paterna, a cui era legato da un rapporto di amore/odio, è di dolorosa e struggente intensità. Riguardo ai personaggi femminili, Saura appare più stregato dall’immagine idealizzata di Beatrice emersa da un’illustrazione dantesca – che poi si materializza davanti a Da Ponte nel viso angelico di Emilia Verginelli (Annetta) e lo redime dal libertinaggio – che dalla fisicità spesso volutamente stucchevole delle damine settecentesche: Ketevan Kemolidze è una Adriana Ferrarese languida e viperina, Francesca Inaudi una smorta e lamentosa Costanza, la moglie di Mozart aggrappata a un marito insofferente, quasi sempre immerso nel fervore creativo. Gustosi anche i camei di Ennio Fantastichini (un Salieri impettito quanto succube dell’amante stizzosa, una soprano che pretende ruoli sempre al di sopra delle sue capacità) e di Franco Interlenghi (il vecchio scialacquatore, padre di Annetta). La tavolozza cromatica di Vittorio Storaro lascia come sempre estasiati: il chiarore dei fuochi in un livido mattino viennese, la pelle ambrata delle odalische in un postribolo di lusso, le maschere bianche e i mantelli neri del Carnevale veneziano, gli interni in cui i fasci di luce cadono su persone e arredamenti come in un affresco di Caravaggio. Di pregio assoluto gli arrangiamenti musicali di Nicola Tescari (già autore del soundtrack di Vertical City e di Gli occhi dell’Altro), come pure le scenografie di Paola Bizzarri (Pane e tulipani, Ricordati di me) e Luis Ramirez (Tu che faresti per amore?) e i costumi di Birgit Hutter (Klimt). Un ultimo rilievo: il capolavoro di Saura è stato distribuito con il contagocce nelle sale italiane. Persiste la sgradevole impressione che il circuito distribuitivo nostrano si accanisca a penalizzare il cinema d’arte (un trattamento analogo è stato inflitto a Katyn di Andrzej Wajda) e a dedicare corsie privilegiate al cinema spazzatura. Come tenaci estimatori della “settima arte” non possiamo che indignarcene profondamente.
Guglielmo Colombero
(www.bottegascriptamanent.it, anno IV, n. 35, luglio 2010)
Elisa Guglielmi, Ilenia Marrapodi