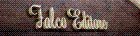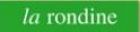Società di prodotti editoriali, comunicazione e giornalismo.
Iscrizione al Roc n. 21969.
Registrazione presso il Tribunale di Cosenza
n. 817 del 22/11/2007.
Issn 2035-7370.
Direttore editoriale: Mario Saccomanno
A. XVIII, n. 199, aprile 2024
 L’Italia liberale
L’Italia liberaletra localismo
e centralismo
di Guglielmo Colombero
Un’opera edita da Rubbettino
offre lo spunto per esaminare
la storia politica del Belpaese
«Tra la civiltà liberale del nord Europa e quelli più “barbari”, non maturi per la libertà, c’era il vasto fronte intermedio di quei paesi, come tutta l’area mediterranea o latina, non solo europea, che erano per certi versi più vicini alla civiltà d’origine, ma nei quali l’impianto della libertà e della democrazia risultava assai problematico», scrive nell’introduzione al suo saggio Importare la democrazia. Sulla costituzione liberale italiana (Rubbettino, collana Storia Politica, diretta da Fulvio Cammarano, Giovanni Orsina e Loris Zanatta, pp. 252, € 18,00) Raffaele Romanelli, docente di Storia contemporanea presso la facoltà di Scienze umanistiche dell’Università di Roma “La Sapienza” e in passato direttore del Dipartimento di Storia e civiltà presso l’Istituto universitario europeo di Firenze, autore di diverse monografie (citiamo, fra le altre, Il comando impossibile: Stato e società nell’Italia liberale, il Mulino, 1995; L’Italia liberale (1861-1900), il Mulino, 1990; Storia dello stato italiano dall’Unità a oggi, in qualità di curatore, Donzelli, 1995; Sulle carte interminate: un ceto di impiegati tra privato e pubblico. I segretari comunali in Italia, 1860-1915, il Mulino, 1989; How Did They Become Voters? The History of Franchise in Modern European Representation, The Hague, Londra, 1998; Duplo movimento. Ensaios de Història, Livros Horizonte, Lisbona, 2008) e di saggi come Ritorno a Speenhamland: discutendo la legge inglese sui poveri (1795-1834), “Quaderni Storici”, n. 53, 1983).
L’intento storiografico che traspare da questa raccolta di scritti si immette nella scia tracciata da una precedente opera dell’autore, di fondamentale importanza per il suo pensiero, e cioè Il comando impossibile. Stato e società nell’Italia liberale, in cui si sottolinea «il paradosso che governò la formazione del regime liberale nell’unificazione italiana e che ne condizionò gli sviluppi, che consisteva nell’imposizione della libertà a un paese che non la conosceva».
Il localismo delle “Cento città” come deterrente all’unità nazionale
Riflettendo sulle autonomie locali, Romanelli parte dal presupposto che, all’alba dell’unificazione italiana, si volle «imporre al paese un sistema amministrativo accentrato, alla francese, che non concedeva granché alle autonomie locali, che mise un veto secolare all’instaurazione delle regioni e per lungo tempo non tollerò alcuna disomogeneità legislativa, alcuna legislazione speciale o speciale considerazione delle particolarità e delle tradizioni locali. Da qui l’immagine di uno Stato liberale particolarmente autoritario e centralizzatore rispetto ai suoi omologhi europei del tempo». A riprova di quanto afferma l’autore, basti pensare al devastante fenomeno del brigantaggio, che scatenò nel Meridione una vera e propria carneficina: i bersaglieri mandati da Torino risposero alle gesta efferate delle bande di ribelli guidate da ex ufficiali borbonici (e raggruppate in un vero e proprio disegno di restaurazione legittimista da un esule straniero, l’aristocratico reazionario spagnolo Josè Borjes, catturato e fucilato a Tagliacozzo l’8 dicembre 1861, che prima di morire disse: «Ringraziate Dio che io sia partito questa settimana, un’ora troppo tardi; avrei raggiunto gli Stati romani e sarei venuto con nuove bande a smembrare il regno di Vittorio Emanuele», come si legge in Promemoria, Periodico di fatti, attualità, politica e cultura del Picentino, diretto da Walter Brancaccio (http://www.promemorianews.org/dossier/brigantaggio). Lo stato italiano appena formato stroncò il brigantaggio con un intervento militare di portata mai vista prima (centomila soldati nel 1864): almeno diecimila (secondo le stime più prudenti) le fucilazioni, un numero imprecisato di civili arrestati per connivenza e deceduti in carcere in attesa del processo, decine di villaggi rasi al suolo per rappresaglia, migliaia i profughi e gli sfollati nelle zone di guerra (con una cospicua percentuale di vecchi, donne e bambini falcidiati dalla denutrizione e dalle malattie). «Mancata, come si sa, una rivoluzione giacobina a distribuire le terre», osserva Romanelli, «anzi rafforzati gli antichi proprietari nei loro domini, declinanti per contro i vecchi tratti manifatturieri e mercantili delle città, le élites urbane erano costituite da un notabilato di possidenti terrieri che avevano ben solido il controllo di un contado per lo più povero e analfabeta, e che lasciava volentieri alle istituzioni ecclesiastiche quel tanto di attività sociale che si esercitava nelle città». Del resto, nel 1878 uno dei politici liberali più prestigiosi, Antonio Salandra, ammoniva sui rischi dell’autogoverno locale, affermando perentoriamente che concedere maggiore autonomia ai comuni significava opprimere sostanzialmente i diritti individuali, per cui la difesa della libertà risiedeva paradossalmente proprio nell’ingerenza statale… Non a caso l’opposizione politica socialista di fine Ottocento ritrovava nel municipalismo il brodo di coltura ideale per propugnare una forma di radicale comunitarismo antistatale: l’antagonismo verso lo stato centralizzato liberale trovava espressione in esperimenti embrionali di welfare, come le opere pie assistenziali. E anche la Chiesa cattolica svolgeva un ruolo cruciale: «forza insieme particolaristica e cosmopolita, e che pur essendo programmaticamente antagonista allo Stato nazionale ne ha però ricalcato l’organizzazione territoriale, e in molti casi ha svolto anch’essa funzioni nazionalizzanti».
Il legame fra le entità territoriali e il concetto di nazione
Riguardo al dualismo amministrazione/politica (attualmente rispecchiato in Italia dalla differente valenza che si tende ad attribuire al voto regionale rispetto a quello per il parlamento), Romanelli teorizza il cd. «doppio movimento», e cioè «il reciproco condizionamento che corre tra i due livelli», il locale e il nazionale. Infatti, «se il centro è forte e sicuro delle proprie capacità di controllo, oppure se sente il locale come omogeneo e non conflittuale, è proprio dal centro che parte la spinta che potenzia l’autogoverno locale». Gli esempi storici non mancano: la monarchia inglese ha dato impulso alle istituzioni locali in un’ottica di consolidamento dell’unità nazionale (cementata dalla borghesia nelle città e dall’aristocrazia nelle campagne). E anche nell’Italia pre-unitaria, la Toscana lorenese di fine Settecento procede nel solco dell’assolutismo illuminato attuando una serie di riforme ispirate al principio della rappresentanza delle comunità locali. Secondo Romanelli, la democrazia liberale è un regime intrinsecamente diffusivo, che «comporta una estensione capillare delle prerogative e dei diritti fondamentali» verso il basso. Le sue conclusioni sono un monito severo sulle insidie connaturate alla rappresentanza locale qualora degeneri al rango di «luogo in cui la politica come sfera alta dell’astrazione si degrada e si corrompe, riempiendosi di contenuti particolari e di interessi fazionali». La recente valanga leghista nelle regioni del Nord Italia sembra confermare questa diagnosi piuttosto allarmata: «nuovi segnali di smottamento sono arrivati dai sistemi politici, in Italia e fuori d’Italia. Non ci resta che scrutare attentamente il cielo, per decifrare i minimi segnali di nuove perturbazioni».
L’ombra persistente del campanilismo disgregatore
Una delle mete più difficoltose che si proponevano di conseguire gli amministratori liberali dell’Italia unificata era l’abbattimento delle barriere fra città e campagna, e il caposaldo di questa divisione coincideva con il localismo esasperato nella sua forma più virulenta: il campanilismo. Il clientelismo elettorale e lo strapotere ancora intatto delle vecchie oligarchie feudali (migrate disinvoltamente, nel Mezzogiorno, dalla dinastia borbonica a quella sabauda: come scriveva Tomasi di Lampedusa ne Il gattopardo, «cambiare tutto affinché nulla cambi») costituivano il substrato più coriaceo di questo conservatorismo sociale: come affermato dal meridionalista Leopoldo Franchetti nel 1885, «allargando i confini della circoscrizione elettorale, non abbiamo fuso insieme i piccoli interessi e le piccole passioni. Le abbiamo solo poste a contatto, cioè in attrito». Parole attualissime: nell’Italia del Ventunesimo secolo le amministrazioni locali protestano contro le discariche, ma solo quando se le ritrovano sulla soglia di casa, e le spinte centrifughe di un federalismo inquinato dalle tossine del secessionismo strisciante e della conflittualità, apertamente campanilistica, che contrappone il Duomo di Milano al Colosseo, rischiano di disgregare non solo le strutture sovralocali della pubblica amministrazione, ma soprattutto di sradicare la coesione sociale e culturale su cui si fonda il concetto stesso di stato unitario.
Aggregazione centralista o decentramento periferico?
Un altro dilemma sottolineato da Romanelli concerne i rapporti fra centro e periferia: «A partire dalla fine dell’Ottocento, si assiste anzi a una radicalizzazione in senso antiborghese e antistatale del discorso autonomistico, che in mano alle forze politiche emergenti cambiò natura e valenze, divenendo motivo di organizzazione politica nazionale contro il sistema, e non più progetto di riforma». I primi decenni dell’Italia unita, all’insegna del liberalismo cavouriano, videro una pura e semplice estensione della legislazione del Regno di Sardegna al resto dell’Italia. Le articolazioni del centralismo, come le prefetture dell’età giolittiana, sembrano perdere progressivamente terreno nel periodo compreso fra il primo Novecento e l’avvento del Fascismo: le periferie sono ridefinite come «spazi di aggregazione e di identificazione economico-sociali o culturali». Secondo Romanelli, la reazione delle classi dirigenti liberali dell’epoca di fronte a questa espansione periferica fu di netta chiusura: esse «affidarono il controllo della periferia, di unificazione e nazionalizzazione, a meccanismi propri delle monarchie assolute». Per cui, in sostanza, risultava «fragile e scarsamente legittimata la rappresentanza politica di fronte alla predominanza dello Stato amministrativo».
Riflessioni politiche su federalismo e autonomie locali
Ricordando la figura di Roberto Ruffilli, l’insigne studioso cattolico caduto sotto il piombo del terrorismo rosso quasi venticinque anni fa, Romanelli ne cita le importanti analisi storiografiche del liberalismo post-unitario: il rigido centralismo dei primi tre decenni di esistenza del Regno d’Italia funge da argine sia contro i tentativi di restaurazione legittimista che contro le agitazioni socialiste o clericali. Alle amministrazioni comunali, prive di qualsiasi potere decisionale, era affidata la mansione di esattori per conto dello stato (in ossequio all’antica tradizione medievale dell’oppressivo fiscalismo bizantino in Italia). Romanelli si sofferma anche sulle prospettive storiche del federalismo cd. “sussidiario”: partendo dal presupposto che, negli Stati Uniti, fu la vittoria dei federalisti sui confederati nel 1865 a inaugurare l’ascesa dell’unione come grande potenza planetaria, egli osserva nondimeno che il federalismo centralista americano «non si misurava al suo interno con poteri dispotici e tendenze “monistiche”, ma era imbevuto di spirito repubblicano, e la sua democrazia naturalmente sperimentava l’esercizio di una sovranità diffusa, nella quale i forti elementi centralistici della costituzione non mortificavano l’autonomia delle comunità statali». Un modello, quello americano, che in Italia fu sempre duramente osteggiato dalla classe dirigente liberale dell’Ottocento: «Accadde con la sinistra di Depretis, con le riforme crispine e con quelle di età giolittiana, che ampliarono le competenze comunali in maniera rilevante e significativa […] ma sempre accompagnando le maggiori autonomie con rinnovati controlli». Il concetto di sussidiarietà, formulato una prima volta nell’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII (1891) e perfezionato in seguito nella Quadragesimo anno di Pio XI (1931), si coniuga ben presto a quello di federalismo anche se «il filone del pensiero federalista italiano a partire dal Manifesto di Ventotene si è esercitato nel disegno europeo più che in quello nazionale». Solo a partire dal 2001 la sussidiarietà è stata recepita con la riforma del Titolo V della Costituzione (articolo 118): in conclusione, Romanelli auspica «una completa autonomia finanziaria degli enti subordinati nella quale eventuali sussidi, integrazioni, sconti, agevolazioni e deduzioni fossero subordinati al giudizio di un potere centrale irrobustito, tecnicamente efficiente, politicamente neutrale».
Una Costituzione liberale ma senza diritto di voto per le donne
Alla vigilia dell’uragano del 1848, che rischiò di sovvertire i delicati equilibri politici europei, il pensiero liberale in materia di unità nazionale appariva ancora «fermo all’accezione rarefatta e intimamente antropologica che era propria dell’idea romantica». Di radicamento dell’idea nazionale nella psicologia delle masse, manco a parlarne. Lo stesso Vincenzo Gioberti definiva l’esistenza del popolo italiano come un desiderio e non un fatto: per cui, una sparuta élite di intellettuali teorizzava metamorfosi politiche e sociali che rischiavano di naufragare tragicamente come la Repubblica partenopea del 1799, quando le plebi sanfediste applaudirono oscenamente l’afforcamento di un’intera generazione di riformatori meridionali. Fatto sta che, secondo Romanelli, il liberalismo italiano «emerse dalla congiuntura del ’48 del tutto privo di sensibilità costituzionale». Riguardo al suffragio politico nell’Italia liberale, riveste un particolare interesse l’indagine dell’autore sulle sentenze della magistratura che fra il 1905 e il 1907 negarono il diritto di voto alle donne: già alla fine dell’Ottocento, persino un liberale di sinistra come Giuseppe Zanardelli affermava che nella donna prevalgono «quelle stesse virtù che non sono quelle che ai forti doveri della vita civile maggiormente convengono». Come dire, è meglio che la donna si occupi del focolare domestico e stia lontana dalla politica, visto che la sua indole troppo fragile ed emotiva non è adatta all’esercizio di certi diritti. Se questa era l’opinione di un progressista, viene da chiedersi cosa pensassero i reazionari… Comunque, nel 1904 un deputato della Sinistra radicale, Roberto Mirabelli, presentò una proposta di legge a sostegno del suffragio femminile, sulla base del sacrosanto principio della parità di diritti fra uomo e donna: ma i tribunali replicarono che l’equiparazione fra i sessi valeva solo per i diritti civili, e non per quelli politici. Anzi, con una sentenza a dir poco grottesca, si sanciva che in tal caso «l’incapacità è la regola e la capacità è l’eccezione». E si ipotizzava con raccapriccio «il nuovo e bizzarro spettacolo di un governo di donne, con quanto prestigio, decoro ed utilità del nostro paese è facile ad ognuno di immaginarsi». Per accedere alle urne, le donne italiane dovranno attendere ancora quattro decenni, conquistando questo diritto fondamentale anche grazie a un alto tributo di sangue versato durante la Resistenza.
Guglielmo Colombero
(www.bottegascriptamanent.it, anno IV, n. 35, luglio 2010)
Elisa Guglielmi, Ilenia Marrapodi