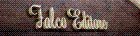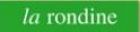Società di prodotti editoriali, comunicazione e giornalismo.
Iscrizione al Roc n. 21969.
Registrazione presso il Tribunale di Cosenza
n. 817 del 22/11/2007.
Issn 2035-7370.
Direttore editoriale: Maria Ausilia Gulino
Anno III, n.25, Settembre 2009
 Katyn. Dopo 70 anni
Katyn. Dopo 70 anniAndrzej Wajda narra
una pagina atroce
dell’ultimo conflitto
di Guglielmo Colombero
Il grande maestro del cinema polacco
dedica al padre martire dell’eccidio
la sua opera più intensa e dolorosa
Erano diecimila ufficiali dell’esercito polacco, fra i quali una dozzina di generali e un centinaio di colonnelli, catturati dall’Armata rossa durante l’invasione della Polonia orientale scattata il 17 settembre 1939. Un mattino di primavera (era probabilmente l’aprile del 1940) li caricarono su camion e blindati a gruppi di duecentocinquanta e, una volta arrivati nel folto della foresta di Katyn, nei paraggi di Smolensk, legarono loro le mani dietro la schiena e li allinearono sul bordo delle fosse comuni già scavate dai bulldozer. Ebbero appena il tempo di mormorare una mezza preghiera (ma molti di loro avevano già sentito l’alito della morte e si erano preparati durante il tragitto), poi una rivoltellata alla nuca e il buio, le palate di terra, il silenzio appena increspato dal mormorio del vento fra gli alberi.
La prigionia di quegli uomini era una conseguenza dello smembramento della loro patria, la Polonia, avvenuto per la terza volta nella storia. E i divoratori erano sempre gli stessi, anche se con altre divise e altre bandiere. Russi e tedeschi. Al termine della Grande Guerra, la dissoluzione degli Imperi centrali e la rivoluzione bolscevica in Russia avevano finalmente consentito, nel novembre 1918, la rinascita della nazione polacca. Józef Pilsudski, un cinquantenne demagogo in divisa dallo sguardo arcigno e dai grandi baffoni a manubrio, era assurto al ruolo di padre della patria, ma, atteggiandosi a moderno Cincinnato, si era ritirato dalla politica, mentre un parlamento rissoso e spaccato in due come una mela fra destra e sinistra eleggeva capo dello stato un suo amico, l’ingegnere Gabriel Narutowicz, assassinato da un nazionalista fanatico nemmeno una settimana dopo l’insediamento. Da allora la neonata repubblica aveva iniziato a scivolare irreversibilmente nel caos.
In questo clima di sfacelo, mentre cresce nel paese la simpatia per l’Italia fascista di Mussolini, il 6 marzo 1926 nasce Andrzej Wajda: suo padre è un ufficiale di cavalleria, sua madre proviene da una famiglia benestante. Due mesi dopo, il 14 maggio, il maresciallo Pilsudski irrompe nuovamente sulla scena politica alla testa dei suoi “legionari”, seppellendo per sempre la gracile e malferma democrazia polacca. Il suo è un regime paternalista, molto simile al fascismo, che lui etichetta come “democrazia articolata”. In realtà si tratta di una dittatura conservatrice che poggia su tre pilastri: esercito, chiesa cattolica e latifondo. Quando Pilsudski muore di cancro nel 1935 gli succede un’autentica nullità – il maresciallo Rydz-Smigly – e formalmente la presidenza della repubblica passa a un anziano professore di chimica, Ignacy Moscicki. La Polonia tenta di barcamenarsi fra i due colossi che premono minacciosi sui suoi confini – la Germania di Hitler e l’Unione Sovietica di Stalin – ma il suo destino è ormai segnato. Il 23 agosto 1939 due delinquenti politici camuffati da ministri degli esteri, il nazista Ribbentrop e il sovietico Molotov, firmano un patto di non aggressione che spalanca le porte dell’Europa ai folli disegni hitleriani. Il 1 settembre la Wermacht invade la Polonia e nel giro di tre settimane la schiaccia: il 17 settembre la parte orientale del paese è occupata dalle truppe sovietiche, in ossequio a un protocollo segreto di quel patto infernale, probabilmente una delle cause scatenanti della Seconda guerra mondiale. I capi politici del paese, Rydz-Smigly e Moscicki, fuggono come ladri in Romania, abbandonando il popolo polacco al suo destino. Il padre di Wajda cade prigioniero dei sovietici ed è destinato all’internamento insieme a migliaia di altri commilitoni: invia delle lettere alla moglie in cui descrive la tristezza e l’umiliazione che patisce per la sorte della nazione polacca oppressa dalle due potenze confinanti, che tentano in tutti i modi di cancellarne l’identità nazionale. L’eccidio degli ufficiali polacchi, decretato da Stalin il 5 marzo 1940 sulla base di una relazione del temutissimo direttore della polizia segreta, Laurenti Berija, rientra in questa strategia di annientamento: per stroncare sul nascere qualsiasi velleità di riscatto nel paese occupato, meglio eliminare fisicamente i potenziali quadri di un’eventuale ricostituzione futura dell’esercito polacco.
Nel racconto di Wajda il dolore appartiene alle donne
Il film si apre con una sequenza indimenticabile: due flussi di profughi provenienti da direzioni opposte che s’incrociano su un ponte, nel disperato tentativo di sfuggire agli invasori. Ma ogni via di scampo è preclusa: chi sfugge ai nazisti finisce nelle fauci dell’Armata rossa e viceversa. Anna, moglie di un capitano prigioniero dei sovietici, riesce comunque a raggiungerlo e lo scongiura di gettare la divisa e scappare via con lei. Nonostante le lacrime strazianti della sua bambina, il capitano rimane assieme ai suoi uomini: ha giurato fedeltà all’esercito, non vuole abbandonarli. Anna esplode in un pianto rabbioso e quasi giunge a odiare il marito: «La tua divisa è più importante di noi?», gli urla in faccia. Ma poi si rassegna e attende a casa il suo ritorno. Pochi mesi dopo, una retata della Gestapo all’università di Cracovia rastrella centinaia di intellettuali polacchi e li deporta in un campo di concentramento, dove molti moriranno di stenti. Una delle vittime è l’anziano suocero di Anna: la comunicazione del decesso, contenuta in un telegramma inviato dalle autorità naziste, è recata da un postino che rifiuta persino la mancia pur di dileguarsi in fretta. Passano altri tre anni, le armate di Hitler invadono l’Urss e nella foresta di Katyn avviene la riesumazione delle salme da parte degli occupanti nazisti, che ovviamente sfruttano l’impatto propagandistico del ritrovamento per accusare di atrocità il loro nemico Stalin. La moglie di un alto ufficiale polacco assassinato a Katyn viene costretta come tante altre dalla Gestapo a firmare una dichiarazione in cui sottoscrive l’accusa contro i sovietici. Ma il nome del marito di Anna non figura nell’elenco delle vittime e lei si aggrappa ancora a una fragilissima speranza. Al termine della guerra, però, sarà uno dei pochi superstiti dell’eccidio, amico del marito, a informarla che le loro identità sono state scambiate a causa di una sciarpa che il capitano gli aveva regalato, con sopra le sue iniziali (in preda a un devastante senso di colpa per essere sopravvissuto ai compagni, il reduce finirà per spararsi alla tempia, infliggendosi lui stesso la morte a cui era miracolosamente scampato). Terminata la guerra, e impiccati i criminali nazisti a Norimberga (fra i quali anche il famigerato ministro degli esteri Ribbentrop), sull’eccidio di Katyn si stende una cortina fumogena: tutti i partiti comunisti dell’Europa occidentale (compreso il nostro Pci – Partito comunista italiano) censurano qualsiasi riferimento a questo crimine di guerra dei sovietici (anzi, si insiste nell’attribuirlo ai nazisti, che in Polonia hanno sterminato tre milioni di ebrei, e quindi sono facilmente imputabili anche di questa ennesima atrocità). Palmiro Togliatti, che durante la Guerra civile spagnola non aveva esitato ad assumere il ruolo di carnefice degli anarchici e dei trotzkisti per conto di Mosca, scatena un infame linciaggio morale contro il docente di medicina legale Vincenzo Maria Palmieri, che aveva contribuito alle indagini sull’eccidio: per mesi e mesi squadracce di attivisti del Pci impediscono a Palmieri di tenere lezione all’Università di Napoli, dandogli del fascista solo perché aveva tentato di far emergere una verità scomoda. Terrorizzato, Palmieri finisce per seppellire la documentazione raccolta in una fossa scavata nell’orto di casa. Al procuratore di Cracovia Roman Martini va molto peggio: sta raccogliendo le prove della responsabilità sovietica del massacro, ma nella notte fra il 12 e il 13 marzo 1946 una coppia di giovani sbandati fa irruzione nel suo appartamento e lo crivella di pallottole. L’assassino, il diciannovenne Stanislaw Lubicz-Wróbleski, dichiara di avergli sparato perché aveva sedotto la sua fidanzata diciassettenne. Condannata a quindici anni di carcere, la coppia evade e fa perdere ogni traccia. I due furono utilizzati per eliminare un personaggio scomodo e poi a loro volta soppressi? Sta di fatto che il giovane assassino era un frequentatore assiduo dei circoli comunisti di Cracovia. Neppure la denuncia dei crimini di Stalin voluta da Kruscev (che pare avesse eliminato personalmente a colpi di rivoltella, nel bel mezzo di una resa dei conti nel partito, il rivale Berija: proprio lui, anima nera di Stalin e istigatore dell’eccidio di Katyn) getta un fascio di luce nelle “notti e nebbie” in cui è avvolta la foresta della vergogna. Il tutto in nome della Realpolitik. Persino il Vaticano, che non ha esitato a decretare la scomunica contro i comunisti, tace sul martirio degli ufficiali cattolici polacchi, temendo di suscitare rappresaglie contro la Chiesa di oltre cortina, in cui all’epoca si sta formando come sacerdote il futuro pontefice Karol Wojtyla. Solamente nel 1992 il primo presidente della Russia postcomunista, Boris Eltsin, fa aprire gli archivi di Stato e consegna la documentazione sull’eccidio di Katyn al collega polacco Lech Walesa, accompagnando il gesto con le parole: «Perdonateci, se potete».
In un’alba livida, condotti a morire come bestie al macello
Wajda opera una scelta ben precisa nel suo impianto narrativo, ed è veramente straordinaria la fascinazione visiva che ancora sa sfoderare questo ottuagenario maestro del cinema. Le immagini sconvolgenti dell’eccidio riaffiorano come un incubo dalle pagine di un’agendina ritrovata nella tasca del pastrano del marito di Anna. E quando alcuni oppositori clandestini del regime comunista la fanno pervenire ad Anna, lei la sfoglia e riscopre sul filo del ricordo gli ultimi giorni di vita del marito, le sue ultime impressioni prima di morire. Wajda ritorna al punto da cui era partito e immerge nuovamente lo spettatore in un orrore che, nella prima parte del film dedicata alla Polonia occupata, era solo accennato e mai mostrato per intero. Il simbolismo caro al maestro polacco rende alcune sequenze memorabili: il treno che trasporta i prigionieri polacchi con l’enorme stella rossa sulla locomotiva, metafora della cortina di ferro in cui saranno reclusi per mezzo secolo i popoli dell’Est europeo; la spada del generale morto che la ex domestica della vedova (ora passata sul versante del potere e del privilegio grazie al marito funzionario di partito) riconsegna sprezzante alla padrona di un tempo, per suggellare il cambio di regime; e l’importanza, muta ma eloquente, degli oggetti, ultima testimonianza inerte di vite singole travolte dalla violenza della Storia. Anche il personaggio dell’ufficiale sovietico che si innamora di Anna e, pur senza essere corrisposto, la salva dall’arresto nascondendola nel proprio alloggio e mentendo agli sgherri della polizia staliniana, è di quelli che restano impressi nel ricordo. Proprio al tramonto della sua lunga carriera artistica (che ci ha donato capolavori immortali come I dannati di Varsavia, Cenere e diamanti, L’uomo di marmo e Danton) Wajda corona il sogno di una vita (era da mezzo secolo che tentava inutilmente di realizzare un film su Katyn, e il fatto che ci sia riuscito vent’anni dopo la caduta del Muro la dice lunga sulla persistenza di certe barriere censorie sia ideologiche che di mercato) e ci infligge un colpo al cuore con un’opera dura e fredda come un diamante, ma densa di sfaccettature vibranti di commozione e di pietà. Un dolore sobrio e misurato, ma penetrante come una lama.
Prima di Wajda solo Makavejev propose immagini di Katyn
Purtroppo va constatato che la Casa distributrice di Katyn in Italia, la “Movimento film”, ha avuto vita tutt’altro che facile: il responsabile, Mario Mazzarotto, ha fatto stampare più copie di quelle effettivamente richieste nelle sale. Nella città di chi scrive, Torino, Katyn ha trovato accoglienza unicamente al cinema Romano e la stampa ne ha parlato, certo, ma senza sicuramente esagerare. Gli spot promozionali in televisione sono stati dosati con il contagocce e tutto ciò fa veramente infuriare chi ama il cinema di qualità, visto che nello stesso periodo gli schermi e gli spazi di affissione sono stati letteralmente inondati dalle smorfie di Ficarra e Picone: non ho nulla contro il duo comico, anche se non mi fanno ridere, ma trovo scandaloso provare la sensazione che l’unico film in circolazione sia sembrato il loro, mentre il capolavoro di Wajda è passato quasi sotto silenzio. Fra tutte le forme di censura mediatica, questa è senz’altro la più subdola e vigliacca. Silenziosa, ma implacabile. Niente di nuovo sotto il sole: negli anni ’70, quelli della grande avanzata delle sinistre in Italia, un regista serbo anarcoide e trasgressivo che Tito aveva cacciato via dalla Jugoslavia a causa di un film-scandalo sulla rivoluzione sessuale predicata da Wilhelm Reich (W. R. – i misteri dell’organismo, 1971), era stato l’unico a riproporre in chiave antisovietica le agghiaccianti immagini dei cadaveri disseppelliti a Katyn. Dusan Makavejev, che è potuto rientrare in patria solo dopo la morte di Tito, aveva girato Sweet Movie in Francia nel 1973, ed ebbe non poche noie con la censura nel nostro paese. Sequestrato, processato, infine assolto per le sue qualità artistiche, il film di Makavejev utilizza Katyn come metafora di un “Grande inganno” che promette il “Sol dell’avvenir” ma poi inevitabilmente degenera in morte e putrefazione. Infatti, il protagonista Pierre Clementi, vestito da marinaio della Potemkin, finisce castrato in una vasca di zucchero dall’affilato coltello dell’attrice (non a caso polacca) Anna Prucnal, pasionaria dal fascino vampiresco. Ricordo che il critico de l’Unità, l’ultraortodosso marxista Ugo Casiraghi, scomparso pochi anni fa e dimenticato da tutti, ma che all’epoca dettava legge nei cinema d’Essai (i film che lui stroncava erano boicottati dai simpatizzanti del Pci e spesso ostracizzati dalla distribuzione), scrisse una recensione velenosa contro Makavejev, accusandolo di nichilismo fascistoide: solo perché, attraverso una simbologia non sempre facilmente decifrabile, affermava (a ragion veduta, visto che lui in un paese del socialismo reale c’era vissuto quarant’anni) che l’utopia marxista era una macabra presa in giro delle masse, costata milioni di morti. Comunque, a chi vuole saperne di più su Katyn consiglio la lettura del libro di Victor Zaslavsky Pulizia di classe: il massacro di Katyn, pubblicato da il Mulino di Bologna, nonché il classico di John Sanford, Katyn e l’eccidio sovietico del 1940: verità, giustizia e memoria, edito da Utet nel 2007. E di riflettere su queste parole di Hanna Arendt, tratte dal suo libro Le origini del totalitarismo (Edizioni di comunità, 1997): «Fu con l’impiego radicale di questi metodi polizieschi che il regime staliniano riuscì a instaurare una società atomizzata quale non si era mai vista prima, e a creare intorno a ciascun individuo un’impotente solitudine quale neppure una catastrofe da sola avrebbe potuto causare».
Guglielmo Colombero
(www.bottegascriptamanent.it, anno III, n. 25, settembre 2009)
Agata Garofalo, Anna Guglielmi, Antonietta Zaccaro
Giulia Adamo, Maria Elisa Albanese, Lalla Alfano, Mirko Altimari, Valeria Andreozzi, Simona Antonelli, Sonia Apilongo, Yael Artom, Claudia Barbarino, Maddalena Beretta, Anna Borrelli, Valentina Burchianti, Giacomo Callari, Giovanna Caridei, Paola Cicardi, Rocco Colasuonno, Guglielmo Colombero, Simona Corrente, Simone De Andreis, Gaia De Zambiasi, Marina Del Duca, Maria Rosaria Ferrara, Elisabetta Feruglio, Vilma Formigoni, Anna Foti, Sara Gamberini, Manuela Gatta, Simona Gerace, Barbara Gimigliano, Patrizia Ieraci, Giuseppe Licandro, Rosella Marasco, Francesca Martino, Valentina Miduri, Sara Moretti, Mariflo Multari, Graziana Pecora, Anna Picci, Mariastella Rango, Marilena Rodi, Roberta Santoro, Marzia Scafidi, Valentina Stocchi, Sara Storione, Pasquina Tassone, Alba Terranova, Raffaella Tione, Filomena Tosi, Laura Tullio, Monica Viganò, Andrea Vulpitta, Carmine Zaccaro, Paola Zagami