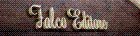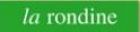Società di prodotti editoriali, comunicazione e giornalismo.
Iscrizione al Roc n. 21969.
Registrazione presso il Tribunale di Cosenza
n. 817 del 22/11/2007.
Issn 2035-7370.
Direttore editoriale: Graziana Pecora
Anno VIII, n 81, maggio 2014
 Il Regno di Napoli
Il Regno di Napolie il suo apparato
in Età moderna
di Vincenzo Cucci
Il sistema amministrativo monarchico
in un libro edito Guerini e associati
L’evoluzione del sistema amministrativo periferico del Regno di Napoli, nel corso dell’Età moderna, era determinato dal rapporto istituzionale che il governo centrale aveva instaurato con la periferia ed i suoi rappresentanti principali, oltre che da una naturale e logica influenza di quelle che furono le più importanti fasi storiche che il Regno napoletano visse. Su questo argomento risulta interessante lo studio condotto in Spazi contesi. Camera della Sommaria, baronaggio, città e costruzione dell’apparato territoriale del Regno di Napoli (secc. XV-XVIII) (Guerini e associati, pp. 830, € 32,00), di Giuseppe Cirillo, professore associato di Storia moderna presso la Seconda università degli studi di Napoli.
L’universo amministrativo del Mezzogiorno continentale in Età moderna era una realtà complessa, in cui conviveva una moltitudine di soggetti detentrice di particolari giurisdizioni; non basta indagare una dialettica amministrativa e politica che comprende soltanto stato centrale, baronaggio e città demaniali: il quadro era molto più ampio, c’erano altri corpi intermedi e ceti organizzati, come università, patriziati cittadini, enti ecclesiastici, dogane, soggetti che avevano cittadinanze privilegiate [1].
Il concetto di iurisdictio fa parte dell’ordine giuridico medievale, per cui le leggi che derivavano dalle consuetudini non erano opera del sovrano, ma interne alle cose, e i soggetti che esercitavano tali diritti erano fortemente legati al territorio, in cui assumevano un senso identitario [2]. Nell’Età moderna il Regno di Napoli ereditava questa antica dimensione giuridica medievale, per cui erano molti i soggetti che avevano acquisito costole di giurisdizione di cui il potere centrale si trovava privato, anche se il compito dello stato e la nuova configurazione di stato moderno cercava di rendere questi corpi intermedi funzionali al ruolo assoluto che doveva venire ad assumere la monarchia napoletana.
Dal periodo aragonese venne inaugurato un potere regio e centrale inteso come assoluto ed accentratore, ispirato da un’unica figura, il sovrano, come supremo giudice e legislatore, in virtù della posizione di unico e legittimo signore del regno. L’utilizzo sempre più frequente nella legislazione e negli atti di governo della prammatica invece che dei capitoli testimoniava che la fonte normativa era la figura del sovrano che, forte delle sue prerogative, manifestava la sua volontà con un atto di esecutività assoluta. Certamente non era messa in discussione l’esistenza stessa della moltitudine dei poteri intermedi intesi come detentori di giurisdizioni e che erano protagonisti nel gioco degli equilibri di forza interni [3], perché ciò avrebbe significato la perdita, da parte del sovrano, della naturale continuità costituzionale del regno.
Il sistema aragonese creava uno schema istituzionale che sarà portante per tutta l’Età moderna, andando soprattutto a riformare molte istituzioni centrali oppure ad istituirle, dotandole di personale burocratico di altissimo profilo, che garantiva il diritto positivo e quello consuetudinario del regno.
Nella nuova concezione dei rapporti tra il potere centrale e la periferia, compito dello stato centrale doveva essere quello di integrare, nella sua azione, la moltitudine dei corpi intermedi preesistenti, di portarli entro quell’orizzonte di cooperazione con il centro, in modo da garantire, da una parte, il riconoscimento della maggiore istanza del governo centrale e, dall’altra, la tradizione propria, interna del regno.
Quello che veniva ad instaurarsi era uno stato in senso moderno, che aveva il controllo sulla periferia, che legava a sé con un filo diretto. Gli altri soggetti e «corpi» giurisdizionali venivano confermati fino a quando non entravano in diretto contrasto con il potere centrale, che fino a quel momento cercava di servirsene per quelle che erano le maggiori funzioni che uno stato doveva esercitare sui territori.
L’organo che maggiormente regolava i rapporti tra il centro e la periferia, andando a determinare gli aspetti amministrativi e il conseguente assetto territoriale, era la Camera della Sommaria, nella sua nuova veste risalente al periodo aragonese, in maniera particolare ad Alfonso V d’Aragona. Oltre a ricoprire la funzione di supremo tribunale fiscale, svolgeva anche incarichi amministrativi, grazie al legame diretto con le università del regno, nonché la fondamentale funzione consultiva nelle questioni che riguardavano la grande politica, e quella di supporto alle decisioni degli altri organi centrali, primo fra tutti il Consiglio collaterale. Nel corso dell’Età moderna fu proprio la Camera della Sommaria a guidare la periferia verso quelle che erano le volontà provenienti dal centro, viste le enormi prerogative che questo supremo organo veniva ad assumere nei confronti della vita amministrativa e fiscale: patrimonio regio, cause feudali, sovrintendenze delle università, uffici vendibili, aspetti fiscali e patrimoniali di ogni giurisdizione regia, contabilità di tutti gli uffici regi [4].
La prima Età moderna
Inizialmente, l’interesse dello stato centrale era creare uno stato fiscale che producesse gettiti certi, senza intaccare il regime consuetudinario preesistente ma che, anzi, si appoggiasse ai corpi intermedi, nell’intenzione di incamerare nella sua azione tutti i soggetti e i «corpi» titolari di giurisdizioni, rendendoli sempre più omogenei alla sua attività [5].
Il regno, nel Quattrocento, aveva un assetto territoriale composto da qualche decina di città, tra demaniali e regie, mentre la maggior parte dei centri era compresa nelle grandi signorie feudali in mano a pochi e grandi lignaggi [6]. In questi centri, nel corso dell’Età moderna, avvennero le più interessanti evoluzioni territoriali ed amministrative, con la Camera della Sommaria a guidarne e dettarne i tempi ed i modi, secondo quelli che erano, di volta in volta, i calcoli politici, la condizione del baronaggio titolato, i bisogni dello stato, le nuove dottrine.
Nella prima Età moderna, il baronaggio era quello storico, legato in modo inscindibile al territorio: si trattava di blasonati riconosciuti dalle comunità come loro signori naturali. A livello territoriale, i grandi stati feudali erano fondamentali per quanto riguardava gli aspetti vitali del regno, come la difesa dei punti nevralgici, il reclutamento, ma anche a livello amministrativo e fiscale nell’esazione delle tasse. Non esisteva in questo periodo un conflitto tra le prerogative del governo centrale e quello delle corti feudali. Anzi, era lo stato, in formazione, a servirsi delle corti feudali, a rendere i grandi baroni funzionari [7], considerando, però, come elemento moderno, la nuova concezione del feudo quoad demanium, non quoad dominium. Si trattava di uno stato che aveva appena acquisito i tratti della modernità, che si trovava ad operare in una periferia in cui vigeva l’ordine territoriale ed amministrativo di origine medievale, con le corti feudali che si erano dotate di una gerarchia burocratica che ricalcava il modello pubblico. Fino al Seicento la feudalità godette di buona salute: nelle sue fila, oltre all’antica nobiltà, si contavano i baroni che erano stati introdotti nel periodo aragonese e, successivamente quelli fedeli agli Asburgo [8].
È appunto dallo stato feudale storico, date le importanti funzioni che veniva ad assumere, che si deve partire per comprendere le gerarchie amministrative e territoriali che si erano costituite nella forma istituzionale degli stati territoriali, che raggruppavano da pochi a molti centri, attorno ad una «terra» o una piccola città dominante.
I beni feudali del regno in alcune circostanze venivano riassegnati ad altri baroni, andando a determinare un nuovo assetto degli stati feudali. Dopo le vicende del Lautrec, i beni dei baroni ribelli vennero venduti, anche se fu mantenuta una struttura verticistica dei feudi. Quello che la monarchia perseguiva era una razionalizzazione interna dei feudi a livello amministrativo, riunendo i diversi diritti burgensatici e feudali in una sola unità, cioè in uno stato, al cui interno si manifestavano forti rapporti gerarchici. La razionalizzazione territoriale voluta dalla monarchia determinava un passaggio da centoventi stati feudali a poco più di ottanta, nella prima metà del Cinquecento [9].
Oltre ad una tale razionalizzazione dei «corpi» feudali, lo stato centrale, attraverso l’opera della Camera della Sommaria, sempre nel corso del Cinquecento, e seguendo quel processo di maggior controllo della periferia, aveva iniziato ad attaccare i privilegi, soprattutto fiscali e doganali, delle città feudali e regie del regno. Una prima fase riguardava la verifica delle cittadinanze privilegiate delle maggiori città, che godevano di immunità fiscali e giurisdizionali [10].
La ridefinizione degli spazi amministrativi entro quelli che erano gli stati territoriali avveniva tramite la promozione dei casali ad università. Ma si trattava, per queste nuove università, di una autonomia soprattutto fiscale ed amministrativa proprio perché istituti nati dall’involucro dello stato feudale storico, dove il territorio era promiscuo, indiviso; mentre la giurisdizione criminale era ancora appannaggio della corte feudale. Nel Cinquecento la preoccupazione dello stato centrale era ancora quella di assicurarsi gettiti fiscali certi, per questo per gran parte dell’Età moderna venivano considerate università quei centri che avevano, a livello fiscale ed amministrativo, un rapporto diretto con la Camera della Sommaria [11], che si occupava anche delle promozioni dei casali ad università.
L’istituto amministrativo prevalente negli stati territoriali era quello di «città di casali». Una università, che molto spesso era la città d’origine dei blasonati, e per questo dimora del barone, dominava a livello amministrativo sugli altri centri, che erano i suoi casali, con cui formava un «corpo» unico, indiviso [12].
La seconda Età moderna
Dal Seicento lo stato centrale perseguì un rafforzamento della sfera amministrativa delle università, con la volontà di sottrarle alle giurisdizioni feudali. Furono molte le indicazioni che fecero emergere questa tendenza del governo napoletano: le prammatiche che, mentre in precedenza avevano interessato la gestione del feudo, in questo periodo furono incentrate sull’istituto dell’università [13]; la mancata convocazione, negli anni Quaranta del Seicento, del Parlamento generale del regno, strumento insostituibile del baronaggio titolato; il protagonismo dei parlamenti degli stati territoriali, che filtravano le disposizioni provenienti dal centro, con cui assumevano anche una funzione di contrattazione, soprattutto per quanto riguardava le contribuzioni focatiche [14].
Nel XVII secolo una crisi generalizzata colpì la grande feudalità storica, a causa del forte indebitamento a cui era andata incontro, con le conseguenti devoluzioni al fisco, il ridimensionamento dei beni feudali ed un incremento del piccolo baronaggio, che però non riusciva ad assumere quel fondamentale ruolo amministrativo e territoriale che in passato aveva contrassegnato i grandi casati tradizionali.
Dagli anni Trenta del Seicento lo stato centrale perseguì un governo tutorio della periferia, con l’obiettivo di legare a sé i centri tramite il controllo amministrativo e fiscale delle università. Con gli «stati discussi» di Carlo Tapia, era la Camera della Sommaria ad avere un rapporto privilegiato con le università, di cui doveva approvare i bilanci e predisporre un piano in caso di forte indebitamento sia verso la regia corte che verso i privati [15].
I veri tentativi di modernizzazione iniziarono a delinearsi solo dalla seconda metà del Settecento, con il riformismo borbonico. Lo stato centrale mise in discussione lo stato giurisdizionale stesso, con la Camera della Sommaria che si assunse il compito di chiedere conto degli specifici privilegi giurisdizionali e baronali degli enti ecclesiastici, del patriziato urbano e delle famiglie privilegiate [16].
L’azione del governo premeva su più fronti: la disgregazione, dall’interno, degli stati territoriali; la definitiva rottura del rapporto tra baroni e comunità vassalle; il ridimensionamento delle funzioni degli stati feudali; l’allargamento della sfera di cittadinanza e l’aumento del numero dei reggimentari e dei ceti che esprimevano esponenti in seno agli organi di rappresentanza delle università, in virtù delle serrate oligarchiche che si erano imposte dagli anni Venti del Cinquecento.
Da una funzione tutoria della periferia, il centro diventò arbitro nelle controversie che vedevano scontrarsi i diversi livelli dei «corpi» intermedi del regno, ed assunse una linea ben precisa, che andò a determinare nuovi assetti territoriali ed amministrativi.
Era ormai considerato anacronistico l’istituto degli stati territoriali che, attraverso i loro parlamenti, erano riusciti a mantenere ampi privilegi, contrattandoli direttamente con la Sommaria. Il supremo tribunale non solo aveva iniziato a convertire in università decine e decine di casali, ma ne incoraggiò il processo: si passava dalle 2.051 università del 1737 alle circa 2.600 di inizio Ottocento, nel chiaro tentativo di rompere, dall’interno, l’unità degli stati territoriali, e legare le nuove università al centro [17].
Tuttavia, il territorio geografico e la sfera amministrativa, giurisdizionale e fiscale non coincidevano in nessuna parte del regno. Lo dimostrano i contenziosi in seguito alla riforma del catasto onciario. Il catasto poteva essere compilato soltanto dai centri che erano università, e per quelle di nuova formazione nacquero problemi sui confini (geografici, amministrativi, giurisdizionali e fiscali) che non erano definiti, ma promiscui [18].
La monarchia borbonica operò anche importanti riforme per quanto riguardava i reggimenti cittadini, con l’introduzione di un terzo ceto, quello delle «arti meccaniche», che andava ad aggiungersi a quelli dei nobili e dei popolari. Nel regno, tuttavia, continuò a permanere un’idea di nobiltà esclusiva, con il predominio delle logiche parentali dei lignaggi e tra i lignaggi [19].
I tentativi di modernizzazione borbonica, sia a livello territoriale che amministrativo, andarono nella direzione opposta rispetto a quella che era la natura del regno, cioè un vecchio ordine di ancien régime, giocato sugli equilibri tra sovrano e poteri intermedi; continuò a permanere lo stato giurisdizionale le cui radici erano da ricercarsi nell’antico sistema feudale [20].
Con le riforme del Decennio francese si intervenne sia sulla sfera amministrativa che su quella territoriale, andando a stabilire nuovi criteri di rappresentanza e la creazione delle province, dei distretti e dei comuni, che soppiantarono l’antico istituto delle università. A prendere il posto dei vecchi parlamenti cittadini era il decurionato, che variava secondo un criterio demografico. I comuni vennero divisi in base a tre tipologie demografiche: comuni con più di 6.000 abitanti; comuni con una popolazione compresa tra 3.000 e 6.000 persone; comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000. Data questa nuova configurazione, si passò alla frantumazione o all’aggregazione dei centri, a seconda delle circostanze, non tenendo però presente, anche in questo caso, quello che erano stati gli antichi istituti territoriali, un «corpo» unico, in cui la sfera amministrativa era comune. In questo modo decine di centri vennero privati di uno spazio che precedentemente era promiscuo, su cui si erano sviluppati o avevano indirizzato la propria crescita [21].
Vincenzo Cucci
[1] Giuseppe Cirillo, Spazi contesi. Camera della Sommaria, baronaggio, città e costruzione dell’apparato territoriale del Regno di Napoli (secc. XV-XVIII), vol. I, Guerini e Associati, Milano, 2011, pp. 27-28.
[2] Ivi, p. 32.
[3] Ivi, pp. 28 ss.
[4] Ivi, pp. 138 ss.
[5] Ivi, p. 37.
[6] Ivi, pp. 84-100.
[7] Ivi, vol. II, pp. 119 ss.
[8] Ivi, vol. I, pp. 198-201.
[9] Ivi, pp. 268-270.
[10] Ivi, vol. II, pp. 153 ss.
[11] Ivi, vol. I, p. 201.
[12] Ivi, pp. 200-202.
[13] Ivi, vol. II, pp. 239-240.
[14] Ivi, pp. 19-21.
[15] Ivi, pp. 244-245.
[16] Ivi, vol. I, pp. 40-41.
[17] Ivi, vol. II, pp. 418-419.
[18] Ivi, p. 321.
[19] Ivi, pp. 372 ss.
[20] Ivi, p. 348.
[21] Ivi, vol. I, pp. 344 ss.
(www.bottegascriptamanent.it, anno VIII, n. 81, maggio 2014)
Francesca Buran, Ilenia Marrapodi, Pamela Quintieri, Fulvia Scopelliti
Simona Baldassarre, Sabrina Barbin, Ilaria Bovio, Francesca Erica Bruzzese, Valentina Burchianti, Maria Laura Capobianco, Maria Assunta Carlucci, Alberto Cazzoli, Guglielmo Colombero, Veronica Di Gregorio Zitella, Giacomo Dini, Maria Rosaria Ferrara, Elisabetta Feruglio, Riccardo Fiorenza, Maria Francesca Focarelli Barone, Federica Lento, Chiara Levato, Giuseppe Licandro, Flavia Maccaronio, Stefania Marchitelli, Irene Nicastro, Maristella Occhionero, Giusy Patera, Stefania Pipitone, Elisa Pirozzi, Luciana Rossi, Martino Santillo, Maria Saporito, Maria Chiara Sicilia, Paolo Veltri, Andrea Vulpitta, Carmine Zaccaro
Denise Amato, Selene Miriam Corapi, Vilma Formigoni, Mariacristiana Guglielmelli, Aurora Logullo, Rosina Madotta, Manuela Mancuso, Ilenia Marrapodi, Elisa Pirozzi, Pamela Quintieri, Francesca Rinaldi, Fulvia Scopelliti